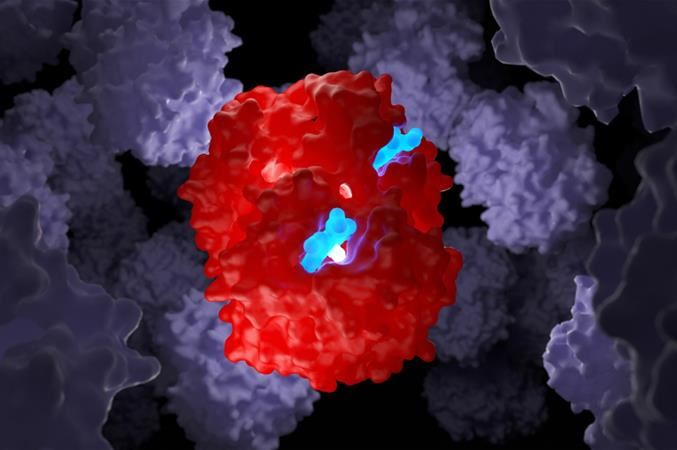Sergio Picardo, responsabile dell’Anestesia, rianimazione e comparto operatorio dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma
«Le valutazioni diagnostiche e terapeutiche devono essere sempre molto attente e coscienziose, poco emozionali, ma certamente non sono autorizzato a togliere un supporto vitale». Sergio Picardo, responsabile dell’Anestesia, rianimazione e comparto operatorio dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, riflette sulla vicenda del piccolo Alfie Evans, morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo oltre quattro giorni dal distacco del ventilatore, e con l’interruzione (poi ripresa) di idratazione e nutrizione. Una vicenda che ha lacerato prima di tutto la famiglia ma anche l’opinione pubblica e ha messo in evidenza una gestione che si può definire almeno problematica del rapporto con i genitori da parte dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool, che ha ottenuto dai giudici l’autorizzazione a interrompere i supporti vitali al bambino.
Al Bambino Gesù come gestite con i genitori i casi più delicati, legati alle malattie per le quali non ci sono terapie?
L’atteggiamento è innanzi tutto quello di creare il miglior clima possibile con i genitori. Questo significa avere un rapporto professionale, ma anche un rapporto umano: i medici non sono solamente tecnici, sono anche uomini che devono stabilire con i genitori un rapporto di fiducia, di collaborazione e di alleanza. Lo scopo, nostro e dei genitori, è curare i bambini: non significa guarire, ma prendersene cura. È l’aspetto fondamentale in tutti i casi di pazienti gravi, specialmente quelli in cui la mancanza della diagnosi non permette una prognosi assoluta e certa. Peraltro ci deve essere il massimo impegno da parte dell’équipe medica per cercare la diagnosi: la strada talvolta può essere lunga e difficile, e prevedere anche ripensamenti, ma senza diagnosi non si può fare nessuna prognosi e nessuna terapia certa. In ogni caso favoriamo l’eventuale richiesta di un secondo parere da parte dei genitori, o lo proponiamo noi stessi se pensiamo che possa servire.
E quando la prognosi appare infausta a breve termine?
Quando la strada è segnata bisogna essere franchi, onesti, partecipativi nei confronti dei genitori, coinvolgendoli nel percorso assistenziale, senza arrivare a forme di contrapposizione o di guerra. Perché in tal caso tutti i ruoli diventano molto più difficili. Credo che il personale medico e paramedico dell’ospedale di Liverpool sia stato sottoposto a un impatto mediatico estremamente difficile da gestire. Mi sono anche messo nei panni di chi, all’interno dello staff, poteva non essere perfettamente in accordo con quanto era stato deciso, e che ugualmente era coinvolto nelle cure del bambino. Come avrà potuto vivere la situazione?
Cosa dire del divieto di portare altrove il bambino, anche solo perché morisse a casa?
È fondamentale capire che il paziente non è di proprietà del medico, che interviene solo per le sue competenze: non decido, io medico, il momento della morte. Ci sono interessi generali la cui definizione è estremamente difficile, vale a dire se la patria potestà possa dipendere anche dalla comunità. I genitori hanno una partecipazione affettiva, e quindi emozionale, molto importante, e possono non avere la lucidità per poter fare la migliore scelta. Credo che l’eredità maggiore di questo caso per evitare che si ripetano simili contrapposizioni, che hanno accentuato il dramma della famiglia, sia creare un consesso di esperti medici, giuristi e bioeticisti, per approfondire i problemi di fine vita e arrivare a un consenso più diffuso e convinto.
Ma si può definire una vita 'futile', come ha fatto il giudice di Liverpool, e pensare che prendersene cura sia accanimento? Queste situazioni non sono bianco o nero: il limite tra accanimento terapeutico e accompagnamento alla morte non è una linea netta, va calibrata sulla singola situazione clinica. Alcuni supporti che i medici consideravano vitali si sono dimostrati non così vitali. Da medico non sono autorizzato a togliere un supporto vitale. Ed è impossibile dare un giudizio sull’utilità di una vita. Se fossero utili solo le persone economicamente attive e non bisognose di cure avremmo un’enorme fascia di pazienti esclusa. Al Bambino Gesù seguiamo tanti pazienti che hanno subìto anossìa al momento del parto, e nessuno li ritiene inutili. La nostra società consumista lega l’utilità al guadagno e alla produttività e vede le persone disabili come pesi. Una forma di discriminazione che dovremmo rifiutare ispirandoci a valori superiori.
Le famiglie, che talvolta vogliono l’impossibile, più spesso chiedono solo di non rinunciare alla cura: perché in Gran Bretagna è apparso 'troppo'?
Il medico non può garantire l’immortalità, cerca di curare e si adopera per la vita: ma queste vicende devono essere viste sotto tutti gli aspetti, e anche la valutazione delle risorse non illimitate per la sanità ne fa parte. Per questo è fondamentale l’alleanza con la famiglia, prestando la massima attenzione alle richieste e cercando di assecondarle nei limiti del possibile. In Gran Bretagna c’è una cultura molto pragmatica, con regole e protocolli, che aiutano nei momenti difficili ma che andrebbero adattati alle singole situazioni evitando atteggiamenti troppo rigidi. La logica anglosassone non è la nostra, o la mia.
.jpg?dt=1713806742938&Width=300)
.jpg?dt=1713806742938&width=677)
.jpg?dt=1713281878103&Width=300)
.jpg?dt=1713281878103&width=677)




.jpg?dt=1713968456410&Width=300)
.jpg?dt=1713968456410&width=677)