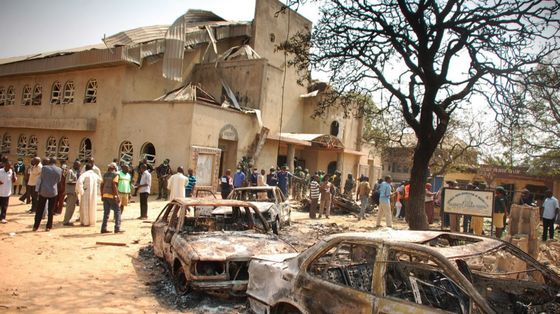«Quei no alla cittadinanza non sono una sorpresa. Vi spiego perché»
di Diego Motta
Pagnoncelli (Ipsos): c'è una percezione sbagliata del fenomeno migratorio, così il tema è diventato divisivo. Per uscire dai pregiudizi, ora servono meno ideologia e più pragmatismo

La sorpresa per quel 35% di “no” al quesito sulla cittadinanza non è stata affatto una sorpresa. Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia, l’aveva ampiamente prevista. Perché, al di là del merito sul dimezzamento dei tempi di residenza richiesti agli stranieri per accedere alla naturalizzazione, quel che è andato in scena nell’urna di domenica e lunedì scorso è stato un piccolo grande referendum sull’immigrazione. Su quel che ne sappiamo, su come stiamo vivendo la presenza degli immigrati nel nostro Paese, sulle preoccupazioni e le paure neanche tanto nascoste. E i numeri hanno spiegato bene che timori e diffidenze sull’argomento sono forti, verrebbe da dire forse maggioritari se la parte del Paese che non ha votato avesse deciso di esprimere una preferenza ai seggi. Perché? «Perché in quel quesito – risponde Pagnoncelli – era in gioco il rapporto con la popolazione straniera presente nel Paese, un tema divisivo e che presenta molte ambivalenze».
A cosa è imputabile l’esito della consultazione?
Ci sono due ordini di fattori. Il primo riguarda la percezione del fenomeno, che resta distante dalla realtà. Lo dicono i nostri numeri: se chiediamo agli italiani quanti sono gli stranieri nel nostro Paese, la risposta in media è il 30% della popolazione contro il 10% reale. Se prendiamo in considerazione i dati di Eurobarometro, alla domanda se ci sono più immigrati regolari o irregolari, vediamo che l’Italia risulta agli ultimi posti per la correttezza della risposta. Il secondo elemento rilevante riguarda il dato territoriale. Se domandiamo quali sono i problemi del Paese, l’immigrazione come risposta spontanea arriva al 26%. Nel momento in cui si ci riferisce alla tua zona o al tuo quartiere, si scende al 13-14%. Significa che la percezione dello straniero è molto meno problematica se la si identifica con le persone che si frequentano abitualmente: si pensi alle badanti per le persone anziane o ai compagni di scuola per i nostri figli. Lo stesso vale per il mondo del lavoro.
Secondo l’Istituto Cattaneo, il 15-20% del Pd ha votato “no” sul tema della cittadinanza, percentuale che diventa maggioritaria nel M5s.
La tendenza evidenziata dal Cattaneo è confermata, in particolare nelle grandi città. È sufficiente inquadrare il fenomeno storicamente per capire che anche questo è un dato solo in piccola parte sorprendente. Emblematica in questo senso è stata la stagione del primo governo Conte, con decreti Salvini e la battaglia contro i cosiddetti “taxi del mare”, slogan con cui venivano ribattezzate le Ong che salvavano i migranti. Ora la composizione dell’elettorato dei Cinque stelle è più di centrosinistra, ma l’identità profonda del Movimento non è cambiata. Quanto al Partito democratico, ha sbagliato chi pensava che ci potesse essere un effetto trascinamento dei “sì” per i referendum sul lavoro anche sul quesito della cittadinanza.
Ciò vuol dire che la domanda di protezione, nel nostro Paese, è forte anche nel centrosinistra e che i diritti vanno difesi in chiave personale, prima di pensare a quelli degli altri?
È così. Il bisogno di protezione, in questa fase storica, è cruciale. C’è una componente non giovane e, aggiungo, cattolica, che è impaurita da un fenomeno non controllato come l’immigrazione, è più sensibile alle emergenze sociali, è più vulnerabile rispetto ad altre fasce di popolazione. Ricordo che facemmo una ricerca demoscopica nel 2013, due settimane dopo il primo viaggio papale di Francesco, a Lampedusa, in memoria dei migranti morti in mare. Quella visita suscitò grande emozione nel Paese. Ebbene, due settimane dopo, chiedemmo agli italiani se erano favorevoli o contrari ai respingimenti nel Mediterraneo. Le risposte più alte tra coloro che erano favorevoli alle operazioni di respingimento arrivarono proprio da chi andava a Messa tutte le domeniche.
Crede sia possibile tornare a parlare di cittadinanza per gli stranieri, senza sollevare tutte le volte il coperchio delle nostre paure o dell’indifferenza?
Penso sia importante evitare l’approccio ideologico al problema, che poi fa venire meno il confronto sul merito della questione. Non serve parlare di questi temi radicalizzandone i termini: così si polarizza ulteriormente un’opinione pubblica peraltro già divisa. L’aspetto premiante invece sarebbe quello di spostare l’attenzione sulla dimensione quotidiana e locale. La cittadinanza non riguarda i massimi sistemi, ma la vita di badanti e bambini. E così pure di tanti lavoratori. Si sottovaluta sempre in modo significativo, ad esempio, l’impatto della popolazione straniera sulla demografia del nostro Paese e sul nostro sistema economico. Eppure, come affermala Fondazione Moressa, c’è una quota rilevante di immigrati extracomunitari che sono piccoli imprenditori, hanno una loro attività economica e manifestano le stesse esigenze di maggior semplificazione e meno tasse che manifestano i colleghi italiani. Consideriamolo, anche nel campo della comunicazione politica: chi pensa che, una volta diventati nostri connazionali, questi stranieri possano votare esclusivamente per chi si è dimostrato favorevole alla cittadinanza, si sbaglia. Perché probabilmente questi futuri elettori voterebbero come il resto dell’opinione pubblica, dividendosi tra destra e sinistra.
Il mondo cattolico può orientare questo dibattito?
Se è vero che occorrono meno ideologia e più pragmatismo, ai cattolici è chiesto di considerare anche altri aspetti: chi lascia le proprie radici ha diritto poi di trovare persone che capiscano la sua situazione e il dolore del distacco dalla propria terra. Forse quello che ci è chiesto, a partire dalla vita delle nostre parrocchie, è il dovere dell’empatia con il prossimo, che a volte abbiamo colpevolmente trascurato.
A cosa è imputabile l’esito della consultazione?
Ci sono due ordini di fattori. Il primo riguarda la percezione del fenomeno, che resta distante dalla realtà. Lo dicono i nostri numeri: se chiediamo agli italiani quanti sono gli stranieri nel nostro Paese, la risposta in media è il 30% della popolazione contro il 10% reale. Se prendiamo in considerazione i dati di Eurobarometro, alla domanda se ci sono più immigrati regolari o irregolari, vediamo che l’Italia risulta agli ultimi posti per la correttezza della risposta. Il secondo elemento rilevante riguarda il dato territoriale. Se domandiamo quali sono i problemi del Paese, l’immigrazione come risposta spontanea arriva al 26%. Nel momento in cui si ci riferisce alla tua zona o al tuo quartiere, si scende al 13-14%. Significa che la percezione dello straniero è molto meno problematica se la si identifica con le persone che si frequentano abitualmente: si pensi alle badanti per le persone anziane o ai compagni di scuola per i nostri figli. Lo stesso vale per il mondo del lavoro.
Secondo l’Istituto Cattaneo, il 15-20% del Pd ha votato “no” sul tema della cittadinanza, percentuale che diventa maggioritaria nel M5s.
La tendenza evidenziata dal Cattaneo è confermata, in particolare nelle grandi città. È sufficiente inquadrare il fenomeno storicamente per capire che anche questo è un dato solo in piccola parte sorprendente. Emblematica in questo senso è stata la stagione del primo governo Conte, con decreti Salvini e la battaglia contro i cosiddetti “taxi del mare”, slogan con cui venivano ribattezzate le Ong che salvavano i migranti. Ora la composizione dell’elettorato dei Cinque stelle è più di centrosinistra, ma l’identità profonda del Movimento non è cambiata. Quanto al Partito democratico, ha sbagliato chi pensava che ci potesse essere un effetto trascinamento dei “sì” per i referendum sul lavoro anche sul quesito della cittadinanza.
Ciò vuol dire che la domanda di protezione, nel nostro Paese, è forte anche nel centrosinistra e che i diritti vanno difesi in chiave personale, prima di pensare a quelli degli altri?
È così. Il bisogno di protezione, in questa fase storica, è cruciale. C’è una componente non giovane e, aggiungo, cattolica, che è impaurita da un fenomeno non controllato come l’immigrazione, è più sensibile alle emergenze sociali, è più vulnerabile rispetto ad altre fasce di popolazione. Ricordo che facemmo una ricerca demoscopica nel 2013, due settimane dopo il primo viaggio papale di Francesco, a Lampedusa, in memoria dei migranti morti in mare. Quella visita suscitò grande emozione nel Paese. Ebbene, due settimane dopo, chiedemmo agli italiani se erano favorevoli o contrari ai respingimenti nel Mediterraneo. Le risposte più alte tra coloro che erano favorevoli alle operazioni di respingimento arrivarono proprio da chi andava a Messa tutte le domeniche.
Crede sia possibile tornare a parlare di cittadinanza per gli stranieri, senza sollevare tutte le volte il coperchio delle nostre paure o dell’indifferenza?
Penso sia importante evitare l’approccio ideologico al problema, che poi fa venire meno il confronto sul merito della questione. Non serve parlare di questi temi radicalizzandone i termini: così si polarizza ulteriormente un’opinione pubblica peraltro già divisa. L’aspetto premiante invece sarebbe quello di spostare l’attenzione sulla dimensione quotidiana e locale. La cittadinanza non riguarda i massimi sistemi, ma la vita di badanti e bambini. E così pure di tanti lavoratori. Si sottovaluta sempre in modo significativo, ad esempio, l’impatto della popolazione straniera sulla demografia del nostro Paese e sul nostro sistema economico. Eppure, come affermala Fondazione Moressa, c’è una quota rilevante di immigrati extracomunitari che sono piccoli imprenditori, hanno una loro attività economica e manifestano le stesse esigenze di maggior semplificazione e meno tasse che manifestano i colleghi italiani. Consideriamolo, anche nel campo della comunicazione politica: chi pensa che, una volta diventati nostri connazionali, questi stranieri possano votare esclusivamente per chi si è dimostrato favorevole alla cittadinanza, si sbaglia. Perché probabilmente questi futuri elettori voterebbero come il resto dell’opinione pubblica, dividendosi tra destra e sinistra.
Il mondo cattolico può orientare questo dibattito?
Se è vero che occorrono meno ideologia e più pragmatismo, ai cattolici è chiesto di considerare anche altri aspetti: chi lascia le proprie radici ha diritto poi di trovare persone che capiscano la sua situazione e il dolore del distacco dalla propria terra. Forse quello che ci è chiesto, a partire dalla vita delle nostre parrocchie, è il dovere dell’empatia con il prossimo, che a volte abbiamo colpevolmente trascurato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA