Se ascolti in streaming una canzone su Spotify, quanto guadagna l’artista?
di Redazione
Secondo i dati di Spotify sono stati pagati 10 miliardi di dollari in royalties l'anno scorso, 5 alle grandi case discografiche. Gli artisti restano critici sulla suddivisione dei compensi d'autore
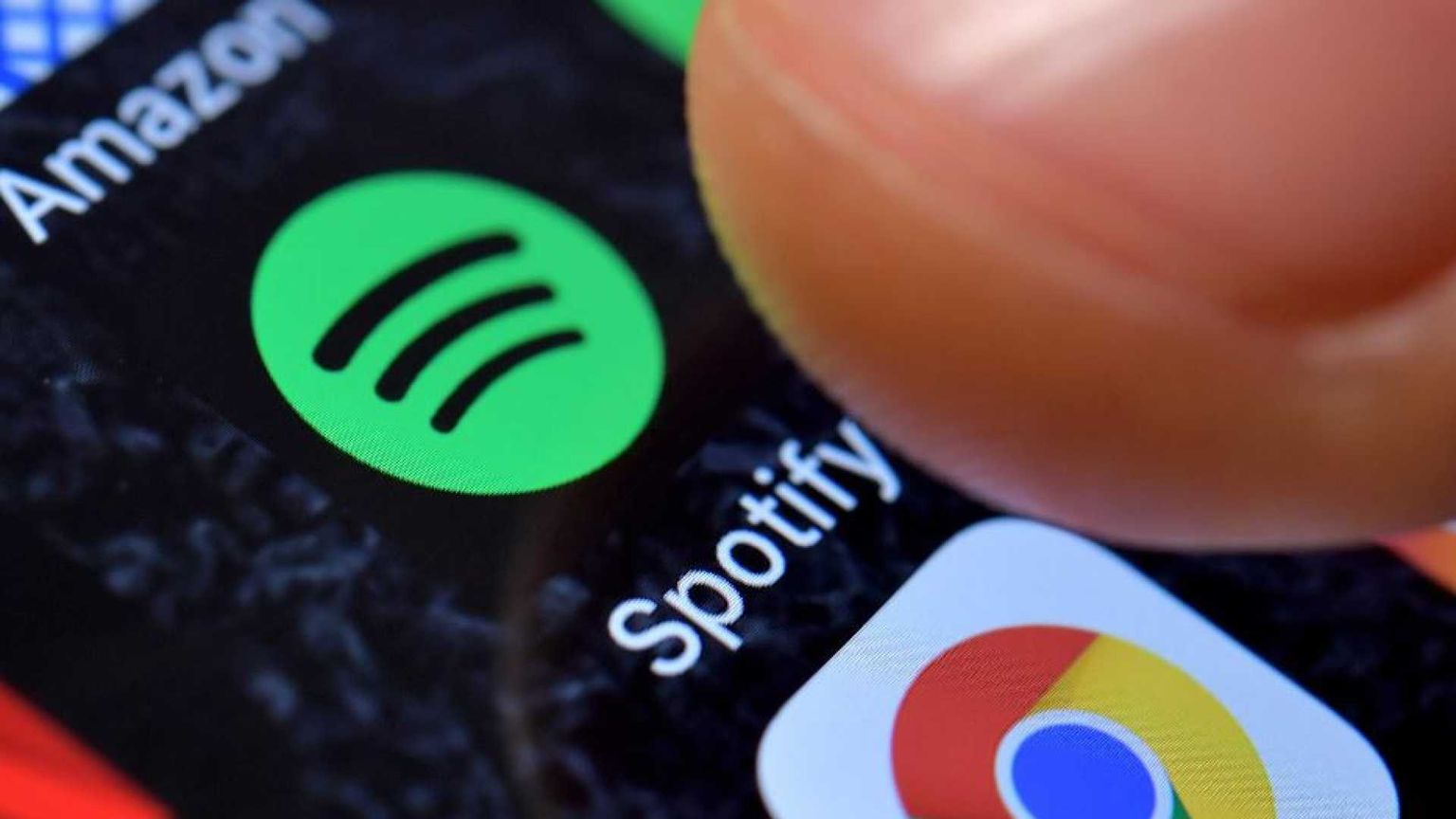
Se ascolti in streaming una canzone su Spotify, quanto guadagna l’artista? Nonostante Spotify sia da oltre un decennio una parte fondamentale del modo in cui le persone ascoltano la musica in streaming non tutti conoscono questa risposta. Quello che sappiamo è che oggi un abbonamento mensile a un servizio di streaming audio, che offra un comodo accesso a una parte considerevole della storia della musica registrata, costa molto meno dell’acquisto di un singolo album registrato su supporto fisico. Ma di questa accessibilità di prezzo, chi ne sta facendo le spese? Oggi la musica in streaming rappresenta circa l’80% per cento del fatturato dell’intera industria discografica, motivo per cui si tendono a osservare i numeri positivi della piattaforma più nota, Spotify - con i suoi 268 milioni di abbonati paganti (dati marzo 2025) - come un indicatore positivo della salute dell’industria musicale nel suo complesso. Secondo “Loud & Clear”, il rapporto annuale di Spotify incentrato sull’economia dello streaming musicale, le royalties generate dagli artisti italiani su Spotify nel 2024 sono più che triplicate rispetto al 2019, avvicinandosi ai 150 milioni di euro, con un aumento di quasi il 20% solo nell’ultimo anno. Una crescita superiore rispetto al +8,5% di quella del mercato totale della musica registrata in Italia nel 2024, o del +13,6% considerando solo lo streaming. Sempre dal colosso svedese dello streaming musicale fanno sapere che il 2024 è stato anche l’anno in cui Spotify ha distribuito all’industria musicale globale la cifra record di 10 miliardi di dollari, di cui la metà alle major, raggiungendo quasi 60 miliardi complessivi da quando la piattaforma esiste, più di quanto abbia fatto qualsiasi altro servizio competitor e in assoluto la cifra più alta di sempre distribuita in un solo anno.
Secondo i dati riportati dalla piattaforma, nel 2014, «Spotify ha contribuito a meno del 10% delle entrate annuali globali di musica registrata. Oggi, invece, contribuisce per ben oltre il 25%». Grazie allo streaming «il numero di artisti italiani che ha generato royalties oltre le soglie di 10mila, 50mila e 100mila euro è più che raddoppiato dal 2019 al 2024». Inoltre, l’italiano per la prima volta «è entrato a far parte delle lingue da oltre 100 milioni di dollari - si legge ancora nel report - con i ricavi globali generati dalla musica eseguita in italiano che sono aumentati del 23% rispetto al 2023».
«Lo streaming permette realmente a un numero sempre maggiore di artisti di raggiungere il successo, di farsi conoscere, nel proprio Paese e nel mondo» ha commentato Federica Tremolada, general manager Europe di Spotify. «Il denaro versato agli artisti e il numero di artisti che ne beneficia sta crescendo anno dopo anno. Ma la crescita dell'industria musicale non è solo una questione finanziaria, è anche una questione culturale. Stiamo vivendo in un’industria musicale sempre più senza confini, come mai prima d’ora».
Indubbiamente i musiclover sono entusiasti di tutto ciò e del rapporto qualità-prezzo del loro abbonamento mensile - che in Europa potrebbe avere un rialzo di un euro nei prossimi mesi - ma che al momento garantisce un accesso a un catalogo estesissimo per soli 11 euro al mese; pure i mercati premiano la piattaforma di streaming svedese, il cui valore delle azioni è più che raddoppiato nell’ultimo anno, dopo che il 2024 ha segnato il primo anno di profitti. A fare da contraltare ci sono, però, da sempre le ire dei musicisti, i quali sostengono che il modello di streaming della piattaforma svedese, che genera solo pochi centesimi per ascolto, non remuneri gli artisti abbastanza per guadagnarsi da vivere. Secondo il Financial Times questa reazione negativa si è attenuata nel corso degli anni, quando Spotify ha raggiunto i 675 milioni di utenti a livello globale, di cui 263 milioni abbonati. E pure le royalties sono aumentate vertiginosamente, passando da 1 miliardo di dollari nel 2014 ai 10 miliardi di dollari dell’anno scorso. Resta però un’ostilità persistente: la cantante Björk a gennaio aveva dichiarato: «Spotify è probabilmente la cosa peggiore che sia mai capitata ai musicisti».
Tornando alla domanda iniziale sui guadagni degli artisti, di fatto, Spotify versa la maggior parte dei ricavi che riceve dagli utenti abbonati ai titolari dei diritti musicali, tra cui etichette discografiche, editori e altri gruppi, che possiedono i diritti d’autore del suo catalogo musicale. Gli artisti non vengono pagati semplicemente in base al numero di ascolti che i loro brani raggiungono, ma in base alla percentuale di ascolti totali che rappresentano in ogni Paese: nel libro inchiesta della giornalista newyorkese Liz Pelly dal titolo “Mood Machine” si trovano molte spiegazioni su quale sia «il sistema principale utilizzato da Spotify per allocare le royalties», e su come anziché una tariffa fissa per stream, venga calcolato un pool di ricavi (ricavi netti meno tasse e commissioni), poi diviso tra i detentori dei diritti (Spotify stessa, i detentori dei diritti di registrazione e quelli dei diritti di pubblicazione). I detentori dei diritti di registrazione e pubblicazione vengono quindi pagati in base alla percentuale di stream che il loro catalogo genera rispetto al totale degli stream sulla piattaforma in un dato mese. Se il catalogo di una major discografica rappresenta il 20% degli stream totali, quella major riceve il 20% del pool di royalty destinato ai detentori dei diritti».
Secondo Sam Duboff, responsabile marketing e policy per il settore musicale di Spotify parlare della tariffa per stream è fuorviante: il nostro servizio è più coinvolgente, dunque la tariffa calcolata per streaming risulta inferiore matematicamente in confronto ad altri servizi. Però, «più stream per ascoltatore significano un coinvolgimento più profondo degli abbonati, il che è ottimo per gli artisti. L’engagement è il fattore più forte per la conversione e la fidelizzazione Premium» degli utenti di Spotify che passano sempre più ore sulla piattaforma con musica in sottofondo, attraverso playlist pensate per ogni momento della giornata e curate appositamente da Spotify stessa, in collaborazione con licenziatari specializzati in musica funzionale. Di fatto, un'altra strategia che va a discapito della musica e della composizione d'autore. E se il tempo di engagement si alza, a beneficiarne sono i ricavi pubblicitari, considerando che l’advertising arriva agli utenti non premium e sostiene il modello dei podcast. E solo, secondariamente si può ipotizzare che l’engagement possa favorire anche la vendita del merchandising dei musicisti e i biglietti dei loro concerti attraverso Spotify che resta il vero controllore e beneficiario dei ricavi.
Quello che mostra il libro inchiesta di Pelly è qualcosa che va oltre, e riguarda la difficile situazione dei musicisti, legata a lotte più ampie per la «giustizia economica»: viene incoraggiato l’acquisto di musica direttamente dagli artisti o dai negozi di dischi indipendenti ma anche l’andare ai concerti. Con una nota di ottimismo alla fine del suo libro si legge: «L’industria culturale aziendale consolida il suo potere non solo controllando il mercato, ma anche controllando l’immaginario popolare (il riferimento è all’insidiosità delle playlist che è ciò che distingue Spotify dagli altri servizi di streaming, perché separa la musica da chi la crea, ndr), convincendoci che non ci sono alternative. Le alternative, però, stanno crescendo tutt’intorno a noi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA







