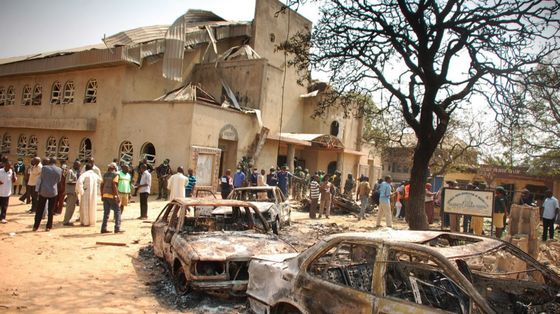Il Piano nazionale per la famiglia, umile e realista. Ora va realizzato
Presentato il mese scorso nel silenzio generale mette in fila 14 azioni urgenti ma un po' vaghe nella loro attuazione concreta. Al centro il potenziamento dei Centri per la famiglia

All’inizio di maggio è stato pubblicato, nel silenzio quasi generale – e con una certa prudenza anche da parte dei suoi estensori – il nuovo Piano nazionale per la famiglia 2025– 2027, predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Che un governo vari un piano dedicato alla famiglia dovrebbe, di per sé, attirare l’attenzione della stampa, soprattutto alla luce della situazione demografica del Paese.
I dati parlano chiaro: la famiglia tipo in Italia conta oggi appena 2,2 componenti. Il tasso di fertilità ha toccato nel 2024 un nuovo minimo storico: 1,18 figli per donna. Gli ultraottantenni sono ormai più numerosi dei bambini sotto i 10 anni. I matrimoni sono scesi a 3,1 ogni mille abitanti, e solo il 41% è celebrato con rito religioso. L’età media al primo figlio è di 35,8 anni per i padri e 31,7 per le madri. Non va meglio all’estero. Il calo delle nascite riguarda quasi tutti i Paesi sviluppati, e ormai coinvolge anche molte economie emergenti. Turchia, Iran, Russia, Brasile e Thailandia registrano oggi livelli di fertilità inferiori alla soglia di sostituzione. Perfino l’India, storicamente considerata un Paese ad alta natalità, è destinata a scendere sotto tale soglia nel corso dell’anno. Molti Paesi occidentali affrontano questo problema da almeno una generazione.
L’Italia, ad esempio, è scesa sotto la soglia di sostituzione esattamente cinquant’anni fa. In molti contesti – meno in Italia – si è tentato di reagire con politiche familiari volte a invertire la tendenza. I risultati, tuttavia, sono stati modesti. Basti pensare a Francia e Svezia, che da anni investono in modo sistematico nelle politiche per la famiglia: i loro tassi di fertilità, pari rispettivamente a 1,79 e 1,52, restano comunque sotto la soglia dei 2,1 figli per donna, necessaria a garantire la stabilità demografica. Il caso di Singapore è emblematico: nonostante politiche pro-nataliste tra le più generose dell’Asia, il tasso di fertilità è fermo a 1,04. In Ungheria, le politiche familiari più coraggiose d’Europa avevano portato a una risalita fino a 1,61, ma da due anni il tasso è di nuovo in calo. Insomma, il panorama internazionale delle politiche familiari – che siano incentivi fiscali, trasferimenti monetari, servizi diretti (come asili nido gratuiti e congedi retribuiti) o soluzioni innovative – non offre modelli chiaramente vincenti.
Non esiste oggi un Paese a cui guardare come riferimento sicuro per politiche davvero efficaci. In questo scenario incerto, dove copiare storie di successo non è una strategia praticabile, il decisore politico si trova in difficoltà. Ci vorrebbe il coraggio di sperimentare soluzioni audaci (come ho suggerito qui: Avvenire – Idee audaci contro la denatalità), ma non sembra ancora giunto il momento storico per farlo. Il nuovo Piano nazionale per la famiglia adotta allora una via più prudente e realista, ma comunque apprezzabile. In mancanza di svolte radicali, propone un approccio decentrato e bottom-up, che mira a stimolare l’emersione di soluzioni locali.
Tra le quattordici azioni previste dal Piano, spicca il potenziamento dei Centri per la famiglia, con l’obiettivo di trasformarli in veri e propri hub territoriali di servizi e attività. La responsabilità di animare questi centri con contenuti concreti e iniziative efficaci viene però lasciata ai territori, secondo una logica sussidiaria. Accanto a questa misura, il Piano introduce la figura del Family Welfare Manager, un referente dell’amministrazione locale incaricato di coordinare le politiche familiari in sinergia con le imprese e con le realtà del terzo settore presenti sul territorio. Si prevede inoltre la promozione, su scala nazionale, di un sistema di certificazione per le aziende family friendly e per i comuni che si distinguano come “amici della famiglia”. Un’attenzione particolare è poi riservata ai primi mille giorni di vita del bambino: il Piano prevede l’attivazione di figure professionali dedicate ad accompagnare i genitori in questa fase delicata e cruciale per lo sviluppo del minore. Infine, si propone un’indagine strutturata sulla generazione Z, volta ad approfondire le cause del crescente disinteresse dei giovani nei confronti del progetto familiare, un fenomeno già messo in luce tra gli altri dal settimanale Vita.
Come si evince, il Piano adotta un approccio sussidiario e sperimentale: al centro, la famiglia come soggetto attivo; intorno, istituzioni, imprese e terzo settore chiamati a costruire reti locali di sostegno e promozione. Una scelta condivisibile: quando mancano modelli efficaci da imitare, è giusto lasciare spazio alla sperimentazione dal basso. Il Piano ha un altro merito fondamentale: riconosce che la famiglia non è solo beneficiaria di aiuti, ma risorsa attiva per la società. In quest’ottica si inserisce anche il concetto di governance deliberativa, che mira a una co-progettazione tra pubblico e privato e a un welfare policentrico. Naturalmente, non mancano le criticità. Le 14 azioni sono ben concepite, ma ancora vaghe nella loro attuazione concreta. La figura del Family Welfare Manager, ad esempio, non è definita nei ruoli, poteri o percorsi formativi. I Centri per la famiglia sono rilanciati come hub territoriali, ma senza linee guida operative.
Si parla di strumenti di valutazione degli impatti, ma si dimentica che la demografia si misura in decenni, non in trimestri. Il successo del Piano dipenderà – come sempre – dalla qualità dell’attuazione. Strumenti senza contenuti non bastano; centri senza personale competente non funzionano; azioni isolate senza regia si disperdono. Sarà cruciale trovare meccanismi di scalabilità per replicare rapidamente, a livello nazionale, i successi che emergeranno localmente. Infine ci si consenta di dire che non basta varare un piano: bisogna crederci, investirci, raccontarlo. In questo senso, il silenzio che ha accompagnato il suo lancio interroga profondamente. Perché il Piano tocca un tema cruciale per il futuro del Paese: la famiglia. E invece è stato presentato quasi con pudore, quando dovrebbe rappresentare un motivo d’orgoglio per un governo che ha fatto della natalità una delle sue priorità dichiarate.
Questa riflessione è stata presentata al seminario della LUMSA sulle nuove politiche della famiglia del 30 Maggio 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA