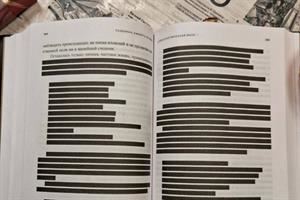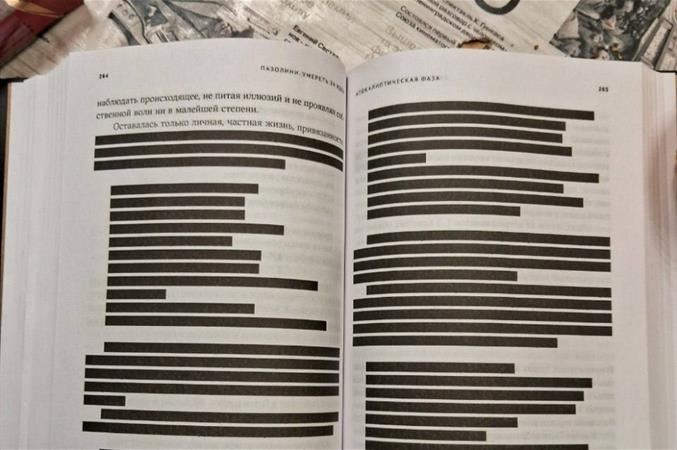Siamo così abituati a conviverci che quasi lo diamo per scontato. Come se ci fosse sempre stato e come se dovesse esserci per sempre. Stentiamo a ricordare cosa scrisse del Leviatano uno dei suoi ideatori. “Mortal God” lo definì Thomas Hobbes, lo Stato è il dio mortale che assicura la “nostra pace”. Così, dimentichi dell’avvertimento del filosofo inglese, finiamo per ritenerlo eterno. E se invece stesse arrivando al capolinea? Un tempo era il dominus della scena. Decideva liberamente entro i propri confini, legiferava, controllava tramite confini porosi flussi di uomini, merci, denaro. E poteva dirsi sovrano. Oggi lo è ancora? Glissando sul potere di legiferare autonomamente e sulle capacità di controllare i flussi che ne svellono i confini, ormai il potere decisionale dello Stato è irretito nella trama di convenzioni, accordi e alleanze che disegnano la mappa di quello che Lorenzo Casini definisce efficacemente Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati (Il Mulino, pagine 152, euro 13,00). Ormai il Leviatano, per quanto ancora parte fondante, a dire di Casini, della globalizzazione, si trova limitato dalle istituzioni ultrastatali. E non si tratta solo delle organizzazioni intergovernative di tipo classico come Onu, Oms o Fmi.
A condizionarne l’agire concorrono i network globali, i celebri G7 o il G20 o il Comitato di Basilea per regolamentare le politiche bancarie. Ci sono poi anche le istituzioni globali private come Iso per le certificazioni di qualità o il Cio, il Comitato olimpico. «Il numero di organizzazioni internazionali – ricorda Casini – è cresciuto di oltre cinque volte dal 1980 ad oggi, passando da circa 15.000 a circa 70.000». Come operano gli Stati in questa ridda di istituzioni? Per il giurista di Lucca la soluzione si troverebbe nel superamento della logica verticale del potere con una orizzontale, reticolare, cooperativa mettendo al centro il procedimento. Rispettando la procedura si legittimerebbero le decisioni della comunità dei poteri globali. Inoltre così il procedimento diventerebbe il veicolo di partecipazione alle dinamiche della globalizzazione. Ipotesi un po’ debole, forse, che fa sua la cosiddetta “analogia domestica” trasferendo semplicemente all’ordine giuridico globale prassi amministrative proprie agli Stati. Non la condividerebbe di certo lo storico Niall Ferguson che nel recente La piazza e la torre. Le reti, la gerarchia e la lotta per il potere (Mondadori, pagine 590 euro 30,00) solleva questioni ben più radicali anche se non osa trarre con altrettanta radicalità le meritate conclusioni. Lo storico britannico mostra come la storia sia scandita dall’alternanza tra due forme di espressione del potere, tra la piazza e il palazzo, tra i network e le gerarchie.
Dal 1450 al 1790 ad affermarsi sarebbero state le reti, poi sarebbe arrivato il momento dei poteri a organizzazione gerarchica ma dal 1970 le reti sono tornate a riaffermarsi. «Dagli anni Ottanta e Novanta – scrive Ferguson – la combinazione tra deregulation (soprattutto l’abolizione dei controlli su cambio e capitali) e computerizzazione (soprattutto la creazione di flussi di informazioni e transazioni transfrontaliere più rapide) comporta la vulnerabilità di qualsiasi impresa politica basata sul controllo gerarchico». Insomma, Stati addio. «Gli Stati quasi autarchici – continua lo storico britannico – con il monopolio del comando e del controllo, emersi dalla Depressione, dalla Seconda guerra mondiale e dalla fase iniziale della Guerra fredda esistono ancora ma solo come pallide ombre di ciò che erano un tempo».
Ormai che le reti informatiche prevalgono, la finanza transnazionale gestisce flussi che rendono obsolete le frontiere, gli accordi con organizzazioni ultrastatuali stabiliscono le regole dello Stato rimane poco. Ma cavi sottomarini, oleodotti e gasdotti, lo scheletro delle reti, continuano ad allignare su un territorio ancora controllato dal Leviatano. E qui, per Ferguson, potrebbe aprirsi per il “dio mortale” un’opportunità di sopravvivenza. La partita per gli Stati rimarrebbe aperta purché i maggiori tra essi sappiano, ritiene Ferguson da buon allievo di Henry Kissinger, istituire una sorta di Congresso di Vienna 2.0 capace di rintuzzare l’espandersi delle reti odierne come avvenne nel 1815. Rimane da chiedersi se effettivamente questi colossi gerarchici sono ancora in grado di farlo vista l’ampia disaffezione che li ghermisce. Scarsa la fiducia che si ripone in loro. Si ritengono, gli Stati, sempre più inadatti a gestire le questioni cruciali. Troppo grandi per risolvere i problemi locali e troppo piccoli per affrontare quelli globali. Secondo Charles S. Maier nel suo Leviatano 2.0. La costruzione dello Stato moderno (Einaudi, pagine 342, euro 30,00), un tempo erano ritenuti da tutti imprescindibili per assicurare la fioritura delle vite degli uomini. Erano la grande invenzione in grado di sostenere lo sviluppo di tutte le attività fino a far assurgere, la comunità che vi si riconosceva, alla potenza.
A partire dagli anni Ottanta del secolo passato, comincia a diffondersi l’idea che lo Stato non sia più autosufficiente. «Sembrava che potesse esternalizzare le proprie funzioni – riconosce Maier – delegandole a quella che sarebbe stata chiamata la sfera della società civile». Starebbe dunque «nascendo – prosegue lo storico di Harvard – un Leviatano 3.0, inteso come una forma di associazione funzionale» in cui la governance «sublima la politica» perché «la regolamentazione emerge dalle raccomandazioni di organizzazioni non governative e dalla comunità della conoscenza scientifica». Peccato però che così i cittadini sarebbero completamente esautorati dalla direzione politica. Procedimento, Congresso di Vienna 2.0 e governance sono le soluzioni per rilanciare lo Stato e la partecipazione dei cittadini al governo o solo il sintomo dell’incapacità di pensare nuove forme di unità politica solidali con le democrazia? Purtroppo oggi mancano i necessari Thomas Hobbes e la democrazia rischia di diventare un ricordo.






.jpg?dt=1714144783645&Width=300)
.jpg?dt=1714144783645&width=677)