
Giovanni Segantini, “Le cattive madri” (1894). Vienna, Österreichische Galerie Belvedere - WikiCommons
Non ci sono valori – e tanto meno miti – che il Novecento, secolo empio e di trasgressioni reiterate, non si sia provato a aggredire e sconciare. Persino il sacro valore della maternità, che nel mondo cristiano è stato mantenuto integro per quasi duemila anni. Siamo nel 1894 – ma già dentro, se si vuole, il nuovo tempo del nichilismo annunciato da Nietzsche – quando Giovanni Segantini, montanaro selvatico e solitario, dipinge uno dei quadri più sconcertanti, per la sua furiosa disposizione iconoclasta, della storia della pittura italiana moderna: Le cattive madri. L’aria è tersa e cristallina: all’orizzonte i monti ghiacciati sono fiocamente illuminati dalla luce del sole. Il paesaggio è deserto e completamente innevato: in primo piano a destra aleggia, come un inquietante stendardo, una donna – chissà se ancora viva – impigliata, per mezzo del velo che la copre male e dei capelli sanguigni, tra i rami contorti d’un albero isolato e spoglio. All’altezza del seno nudo da sotto il velo, quasi gemmando dal ramo, si sporge la testa d’un neonato, coi capelli dello stesso colore, forse privo di vita. La scena – il corpo scomposto e innaturalmente arcuato, l’espressione sofferente e gli occhi chiusi – pare quella d’una misteriosa esecuzione. Chi viene punita (il titolo del quadro, in tal senso, pare inequivocabile) è senz’altro una madre indegna, snaturata. Quelle capigliature sembrano ferite aperte e san- guinanti: e oltraggiano il biancore abbacinante della neve.
È come se, all’alba del secolo, quel rivolo di sangue che cola dal quadro si gonfiasse scendendo a valle, per coagularsi in uno dei romanzi più affascinanti e terribili che siano stati mai scritti nell’Italia del secolo scorso: Aracoeli (1982) di Elsa Morante, là dove quell’aurorale tentativo di dissacrazione della maternità troverà compiuta e feroce realizzazione, risolvendosi in una sorta di terminale e definitivo atto d’accusa contro la realtà e la vita stessa. Che cosa è, infatti, il romanzo di Morante, se non il viaggio d’un figlio, profondamente insoddisfatto della sua vita, sulle tracce di una “madre cattiva” ormai defunta, l’andalusa e irredimibile Aracoeli da cui s’è sentito abbandonato, intrapreso per ricostruirne la vita, per cercare di dissiparne il mistero e venire così a capo della propria? Già, Aracoeli: difficile non pensare a questo libro, alla riottosa e irriducibile 'madre cattiva' che vi campeggia nell’assenza, dopo aver letto il romanzo di Elena Mearini, I passi di mia madre. La ricerca di un amore mancato, appena pubblicato da Morellini (pagine 160, euro 15,90): che con notevole coraggio torna a confrontarsi col mito della maternità in questa sua declinazione difficile e scandalosa.
Ecco: la quarantenne Agata ha fatto per tre anni la giornalista culturale, epperò, «per intolleranza agli ordini», ha scelto di cambiare. Ora lavora nel mondo dell’editoria, proprio come Manuele, il figlio di Aracoeli: «La lingua italiana mi piace, un elastico che s’allunga e distorce senza rompersi mai. Ho scelto il mestiere di editor per frequentarla il più possibile». E poi: «Leggo passaggi di romanzi in divenire, stralci di storie, vite che si storcono e raddrizzano tra una pagina e l’altra». La vita di Agata muta drasticamente nel 1990, l’anno della guerra del Golfo Persico e della riunificazione della Germania, quando la madre esce «di casa per non tornare mai più». Un particolare bizzarro, che però ci restituisce come la sintassi d’un destino (ma anche d’una lacerazione cruenta): «Quella sera lei indossava un vestito di seta blu con le spalline sottili, uno scialle bianco di garza e un paio di scarpe da ginnastica che si abbinavano poco e male col resto». E poi: «Dalle ginocchia in su l’aspetto di qualcuno che siede al tavolo di un ristorante elegante, solleva il calice di vino rosso e lo trattiene per lunghi attimi nella mano. Polpacci e piedi lasciavano invece presagire un bisogno di corsa svelta, l’imminenza della fuga».
C’è – pare suggerirci Elena Mearini – come una divaricazione all’origine di quella perdita (di quella fuga). E la letteratura pare avere, sin da subito, la funzione di ricomporla, quella scissione, e in qualche modo di risolverla: non per niente, soltanto dopo la scomparsa della madre, Agata, appena tredicenne, ha «iniziato a divorare libri». Di quel bisogno che ha quasi di vivere la lingua, di quello storcersi e raddrizzarsi delle esistenze nei romanzi degli altri a cui lavora, s’è del resto già detto. Occorrerà aggiungere che Agata ha un compagno, Samuele, «una di quelle diete sbilanciate che quando le segui ti fanno stare male»: personaggio anch’esso rubricabile, occorre sottolinearlo, sotto la più larga e imperativa categoria dell’inafferrabilità. E poi c’è Marco, «il vicino che ascolta musica rock»: «una presenza che non smuove tensioni, saperlo lì è semplice e sempre uguale».
Lo apprenderemo senza più dubbi soltanto nell’ultima pagina: Marco appartiene «alla stessa categoria di mio padre», anche lui abbandonato senza una spiegazione, ovvero la categoria «di chi resta anche quando altrove è più facile». Da Samuele a Marco: che è un’altra divaricazione da ricomporre (l’altra faccia della medaglia), speculare all’altra che – lo sappiamo – muove tutte le pagine del libro. A un certo punto però si arriva alla meta: «Qui lascio Samuele e mia madre, due conclusioni nello stesso punto del mondo». Ne è venuto fuori un romanzo che, tra tante cose, è innanzi tutto una lunga lettera scritta alla genitrice e a sé stessi, mentre tutta la realtà, saturandosi in sé stessa, diventa comprensibile e accettabile: «Il desiderio di sentirmi figlia si è realizzato conoscendo mia madre, scrivendo a lei di lei. Si è compiuto ed esaurito nel “Ti voglio bene” dell’ultima riga». La domanda cruciale, alla fine dei conti, resta questa: bisogna inventarsi una madre per cessare di essere figlie e appropriarsi così del proprio destino di donna? È una strada possibile: di sicuro quella che Agata ha dovuto percorrere.


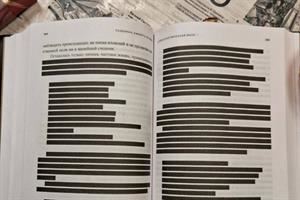
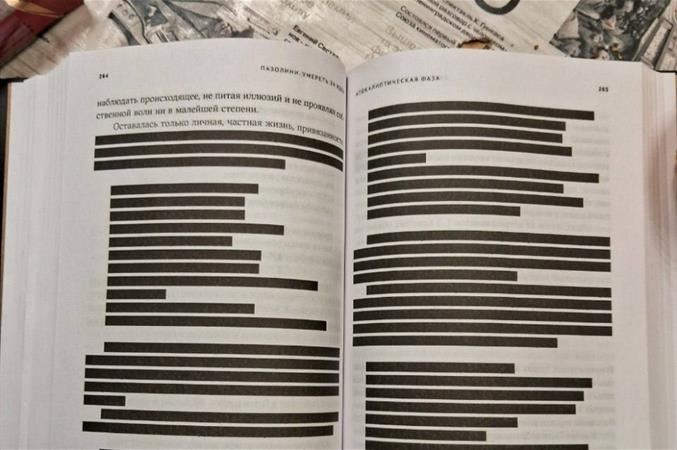






.jpg?dt=1714163656037&Width=300)
.jpg?dt=1714163656037&width=677)





