In una società piena di fobie, quella di essere spiati dalle tecnologie, sorprendentemente, non raccoglie così tante adesioni come forse meriterebbe. Quasi tutti sappiamo (o dovremmo sapere, visto che se ne parla da almeno dieci anni) che ogni volta che usiamo il telefonino, la carta di credito, la tessera punti di un qualunque supermercato o navighiamo su internet, tutto ciò che facciamo viene immagazzinato in potenti computer. Si tratta di migliaia e migliaia di dati. Che svelano pezzi della nostra vita: cosa compriamo e dove, quanto siamo stati influenzati da quel certo spot o da quell’offerta sconto, a quali riviste siamo abbonati e dove eravamo quel certo giorno a quella certa ora (meglio: dov’era il nostro telefonino, quel certo giorno a quella certa ora). Eppure, sapere di essere “spiati”, mediamente, ci mette meno in agitazione che lo scoprire che alcuni colleghi o amici parlano male di noi. Il motivo è semplice: siamo convinti che nessuno userà quei dati contro di noi. Perché sono troppi. E ci vorrebbero mesi per leggerli tutti. Quindi, è la nostra affrettata conclusione, la privacy di nessuno di noi (persone comuni) vale così tanto da meritare un simile trattamento. Il che ci fa dormire sonni tranquilli. Salvo poi fare un salto sulla sedia quando magari scopriamo che un ragazzo austriaco, per una ricerca, ha chiesto a Facebook quali erano i dati che l’azienda possedeva su di lui e si è visto recapitare un cd, con 1200 pagine formato A4. Cioè, con migliaia di dati relativi a tutto ciò che aveva fatto su Facebook negli ultimi tre anni: commenti fatti, cose scritte, amicizie strette, foto postate, idee e giudizi espressi e tanti, tanti dati relativi alla sua vita (dov’era andato, con chi, a fare cosa eccetera). Se solo Facebook ha così tanti dati su ognuno di noi, provate a moltiplicarli per tutti gli altri servizi di internet, che normalmente usiamo (social network, o motori di ricerca), aggiungete le carte di credito, i bancomat e le tessere punti che avete nel portafoglio e avrete un numero approssimativo (enorme) di dati della vostra vita regalati ad altri molto vicino alla quantità effettiva. Naturalmente penserete: se hanno ipoteticamente venti, trenta o quarantamila dati su di me, non se ne faranno niente perché sono troppi da analizzare e io non valgo così tanto. In fondo, un’idea simile ce la conferma anche un film (molto efficace) come Nemico pubblico, con Will Smith e Gene Hackman. Il primo è un giovane avvocato nero che si vede distruggere la vita dall’agenzia americana per la Sicurezza nazionale, perché l’Nsa crede che lui abbia delle informazioni che a loro interessano. Così usano qualunque sua traccia elettronica non solo per braccarlo, ma anche per spingerlo ad arrendersi. Gli tagliano la carta di credito, gli cambiano i dati della fedina penale (che da pulita diventa “sporca”), gli toccano i dati della previdenza, gli prosciugano il conto in banca e inventano su di lui un sacco di tracce false. Già, ma lui “valeva” qualcosa. Noi (pensiamo) valiamo così poco che, a conti fatti, siamo automaticamente salvi. A svelarci alcuni rischi che corriamo è stato nel 2008 La finestra rotta, un romanzo (certi libri e certi film spiegano la realtà meglio di tanti convegni) di Jeffery Deaver con protagonista Lincoln Rhyme, il criminologo paralizzato, diventato famoso grazie al libro e al film Il collezionista di ossa. Il killer protagonista del romanzo si diverte a incastrare come colpevoli ignari cittadini (tra cui il cugino di Rhyme) usando contro di loro i dati raccolti da una società che ha immagazzinato un gran numero di informazioni su quasi tutti i cittadini degli Stati Uniti. Mi sembra già di sentirvi: cose così succedono solo nei romanzi. Forse, se parliamo di serial killer che usano dati elettronici per incastrare degli innocenti. Ma la pratica di raccogliere e schedare dati sui cittadini-consumatori esiste e fa parte di quella disciplina denominata data mining. Chi la segue, il più delle volte, è un ricercatore serio.
Ma si stanno facendo largo aziende (altrettanto serie ma un tantino più pericolose per noi) che usano potenti computer per estrarre informazioni sensibili su chiunque di noi, da usare (per ora) in ambito commerciale. Un esempio banale: quanto vale per una casa automobilistica conoscere quanti sono gli utenti interessati al prodotto che sta pensando di mettere in produzione, così da sapere in anticipo se e quanto successo avrà? Una delle applicazioni del data mining, infatti, è quella di saper prevedere i nostri “bisogni commerciali” prima che noi stessi li rendiamo pubblici. In fondo non è tanto distante da quello che già fa nel suo campo Google. Per noi è solo un servizio, comodo e utile. Ma ogni volta che lo utilizziamo lui associa il nostro pc alle ricerche fatte. E così crea un nostro profilo (vero o verosimile). Man mano che facciamo ricerche, Google ci darà prima che ad altri le informazioni più vicine alla nostra sensibilità. Fate la prova: se conoscete una persona profondamente diversa da voi come interessi, opinioni politiche e gusti, chiedetegli di provare a cercare su Google un certo tema o una certa cosa e voi fate la stessa ricerca. In Italia siamo agli inizi, ma in America i vostri risultati saranno profondamente diversi. Perché Google no ha solo cercato quello che gli avete chiesto, ma facendolo ha tenuto conto del vostro profilo. Un gesto “gentile”. Che però applicato al marketing diventa oro. Provate a pensare quanto sarebbe costato all’ipermercato nel quale vi servite di solito, registrare ogni minuto i gusti di decine di migliaia di clienti, sapendo esattamente chi sono e cosa vogliono; che gusti hanno, quali prodotti prendono sempre e quali invece cambiano perché insoddisfatti o sulla spinta di una efficace campagna pubblicitaria. L’uso della tecnologia, infatti, non ci toglie solo la privacy (e su questo ci sono scritti e convegni che ne dibattono da almeno dieci anni), ma usa ciò che facciamo e diciamo per spremerci al massimo come consumatori. E sotto questo punto di vista ognuno di noi vale, e molto. In fondo, per dirla un po’ brutalmente, il punto vero sta proprio qui: ciò che facciamo vale più o meno della possibilità di acquistare con lo sconto o di avere gratis un aspirapolvere o un microonde?
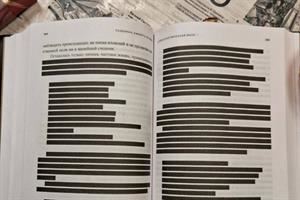
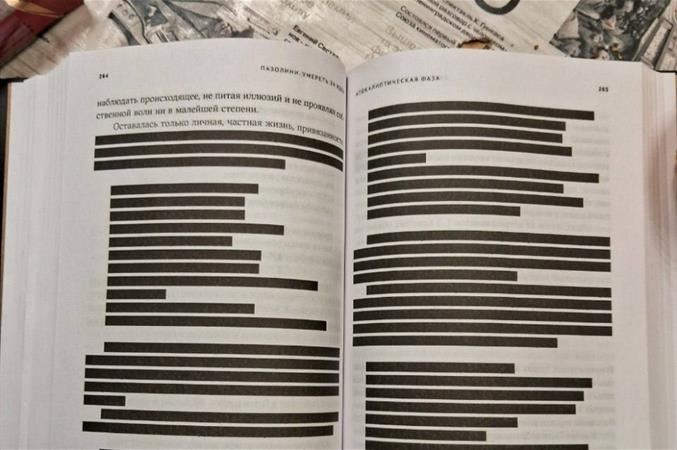








.jpg?dt=1714163656037&Width=300)
.jpg?dt=1714163656037&width=677)



