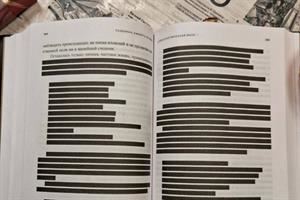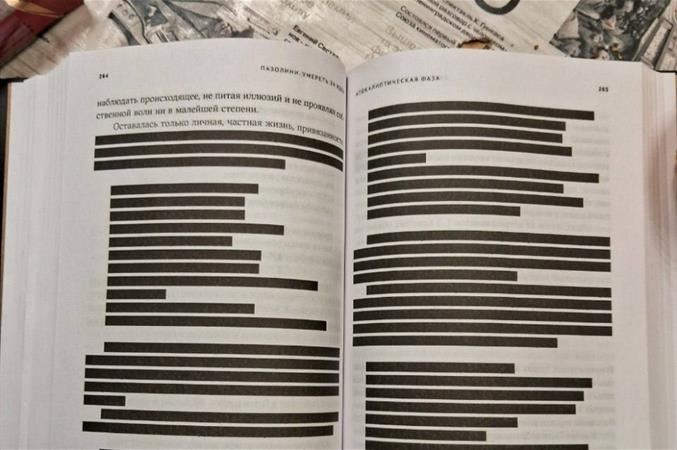Edward Hopper, “Cape Cod Morning” (1950) - © Heirs of Josephine Hopper / photo Smithsonian American Art Museum, Gene Young
Fari del Maine, le scogliere di Cape Cod, i graniti di Cape Ann. E poi brughiere, case sparse, fienili rossi tra le colline, strade verso il nulla, automobili e ferrovie. Sono i paesaggi di Edward Hopper, la parte meno nota della sua produzione, a cui è dedicata una mostra alla Fondazione Beyeler, a Basilea (Edward Hopper A fresh look at landscape, fino al 17 maggio). Hopper (1882-1967) è noto per i suoi silenziosi interni metropolitani e le scene in cui aleggia quella impalpabile tensione che tanto è stata amata dai registi, a partire da Hitchcock (e in mostra c’è il personale omaggio di Wim Wenders, autore di un corto in 3D in cui, senza bisogno di dialoghi, sviluppa le storie latenti in alcuni dei quadri più noti). Sono elementi che si trovano solo in parte nei paesaggi, dove vince “il motivo”, mentre in alcuni casi sono sviluppati proprio attraverso gli elementi naturali: su tutti, le foreste impenetrabili che avvolgono le scene.
È dunque l’occasione per osservare Hopper fuori dai cliché e guardare più da vicino la sua pittura, fatta di masse compatte e piani di luce: e che la luce sia il problema lo dimostrano bene gli acquerelli e i disegni a carboncino realizzati en plein air (mentre gli oli sono tutti in studio), pezzi davvero straordinari per freschezza, senso del bilanciamento, forza di contrasti. La pittura di Hopper è tradizionale, tanto rispetto a quella praticata in Europa tra le due guerre (anche tra quella del ritorno all’ordine) tanto rispetto a quanto accade negli Stati Uniti nel dopoguerra: negli anni in cui dipinge Cape Cod morning (1950) e Second story sunlight (1960), tra le sue opere più celebrate, la pittura americana è (stata) travolta dall’espressionismo astratto, Rauschenberg espone Bed e Johns le sue bandiere, esplode la Pop Art... Hopper non sembra muoversi di un dito, e non è solo una questione generazionale. Il fatto è che il metro dell’avanguardia e della novità è fuorviante per guardare Hopper. Impressionismo? Metafisica? Cubismo? Surrealismo? No. Leggere Hopper attraverso queste categorie – come pure capita – porta fuori strada: perché sono categorie europee e il problema di Hopper rientra nello sforzo collettivo di elaborare un’arte “americana”.

Edward Hopper,“Portrait of Orleans” (1950) - © Heirs of Josephine Hopper / photo Randy Dodson, The Fine Arts Museum of San Francisco
Cosa c’è di americano in Hopper? Innanzitutto la scelta iconografica. La pittura americana dell’Ottocento aveva celebrato i grandi spazi, la grandezza sublime e intatta di una terra promessa. Hopper sceglie un’America diversa, nascosta, priva di retorica e soprattutto percorsa e modificata dall’uomo. Ma è la celebrazione di un paesaggio “non europeo”, dotato di un proprio genius loci che si esprime anche attraverso un vernacolo composto di case in legno, verande, pali del telegrafo, benzinai.
Il linguaggio di Hopper è americano. Per quanto abbia risciacquato i pennelli nella Senna, prevale l’eredità del suo primo mestiere di illustratore pubblicitario, praticato per anni: tanto nella capacità di costruire immagini “comunicative” quanto nella compattezza delle forme. Questa natura illustrativa, abbastanza intrinseca al realismo americano, è quella che consente a Hopper di divenire una sorta di “padre” della Pop Art: sia perché è tra i primi a registrare nella pittura la presenza paesaggistica della società dei consumi (l’insegna della Esso è uno degli elementi caratterizzanti del Ritratto di Orleans) sia perché fa proprie le strategie della comunicazione pubblicitaria: non è un caso che i suoi dipinti siano diventati icone di massa, dotate di riconoscibilità istantanea e replicabilità. La pubblicità ha a che fare con la “cosa”: tanto con la sua dimensione materiale (la merce) quanto con la sua proiezione immateriale nel campo del desiderio.
Anche i suoi paesaggi sono thing, cose. È in questa parola che si gioca la dimensione più profonda della americanità dell’arte di Hopper. «No ideas but in things», “nessuna idea, se non nelle cose”, scrive Williams Carlos Williams in Paterson, pragmatico ritratto di una cittadina del New Jersey con profonde corrispondenze con l’immaginario di Hopper: «Nothing but the blank faces of the houses / and cylindrical trees / bent, forked by preconception and accident / split, furrowed, creased, mottled, stained / secret into the body of light».
Williams appartiene al movimento dell’Imagismo, la cui prima regola, nelle parole di Ezra Pound, era «trattare direttamente con la cosa, sia soggettivamente che oggettivamente». Dunque realizzare un’immagine concreta usando un linguaggio quotidiano invece di perifrasi evocative: esattamente ciò che fa Hopper. Risponde al principio anglosassone Show, don’t tell: “mostrare, non raccontare”. Hopper sceglie la realtà quotidiana, di provincia o rurale, la organizza in un discorso diretto, allo stesso tempo oggettivo e soggettivo. Scrive ancora Williams: «Il solo realismo in arte è quello dell’immaginazione. Solo così l’opera sfugge al plagio della natura e diventa una creazione».

Edward Hopper, “Cape Ann Granite” (1928) - © Heirs of Josephine Hopper / photo Christie's
È tutto lì nell’immagine, ma l’immagine è parte di una scena più grande, invisibile. In catalogo il curatore Ulf Küster osserva che Hopper usa spesso una linea ferroviaria, un bosco, una scogliera per accorciare l’orizzonte mentre sottolinea per contrasto l’illimitatezza del cielo, lasciando così che sia la coscienza il luogo delle percezione della vastità dell’ambiente americano. Allo stesso modo Leopardi osservando la barriera di una siepe finge nel pensiero «interminati / spazi di là da quella».
L’ambiguità dei meccanismi iconografico-narrativi di Hopper (la sensazione che stia accadendo qualcosa fuori dalla nostra percezione, il frammento di una storia di cui non sappiamo inizio e fine), che tanto è piaciuta al mondo del cinema – ma anche a Cindy Sherman e Roy Lichtenstein – risponde dunque a una ambiguità più profonda che è propria della nozione di realismo: «Hopper, come Williams, – scrive in catalogo Erika Doss – era molto interessato alle preoccupazioni fenomenologiche della coscienza e dell’esperienza: nel dipingere come vedeva, sentiva, e veniva a conoscere (o capire) il mondo».
La realtà per come è e per come è percepita dalla lente interiore dell’artista. Certo, c’è talvolta nei paesaggi di Hopper una dimensione onirica apparentemente magrittiana – case nella prateria, foreste appena oltre la porta di casa… – ma dal carattere più didascalico rispetto agli slittamenti linguistici del surrealista. Bisogna credergli quando dice che il suo obiettivo è «dipingere la luce del sole che batte sulla parete di una casa».
Basilea, Fondazione Beyeler
Edward Hopper
Fino al 17 maggio






.jpg?dt=1714144783645&Width=300)
.jpg?dt=1714144783645&width=677)