
Il cardinale Scola (Fotogramma/Maurizio Maule)
Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente (Marsilio, pagine 144, euro 15) è il titolo dell’ultimo libro del cardinale arcivescovo di Milano Angelo Scola del quale pubblichiamo un estratto. Un percorso di ricerca (da domani in libreria) che affronta molte questioni cruciali del nostro tempo come le ineludibili domande sull’esistenza, il rapporto con Dio e col suo tacere di fronte al male, la paradossale libertà che ci paralizza, il valore che oggi assume la testimonianza dei cristiani.
Il compito della Chiesa in questo tornante di tempo si presenta particolarmente arduo, soprattutto nelle cosiddette «questioni miste», per usare un’efficace espressione di Jacques Maritain. Quelle cioè in cui talune scelte pratiche mettono in campo, in termini molto delicati e spesso controversi, i principi stessi (penso a quelli relativi al matrimonio e alla famiglia, alla nascita e alla morte, alla giustizia sociale). Ma per accettare questo positivo “sconfinamento” dell’intervento della Chiesa, occorre approfondire la riformulazione dell’idea di laicità.
Per Jürgen Habermas «la condizione in cui si trova una democrazia si può accertare solo sentendo il polso del suo spazio pubblico politico». Negli ultimi decenni abbiamo constatato che la neutralizzazione dello spazio pubblico porta a una riduzione drastica delle pulsazioni vitali del dibattito democratico. Naturalmente la ricetta per avere uno spazio pubblico vitale non può nemmeno essere – all’opposto estremo – la deduzione del politico dal teologico. Un’intelligente soluzione mi sembra quella prospettata da Maritain. Nel suo discorso all’Unesco del 1947 ( La voie de la paix) affermò che, data l’irriducibile pluralità degli attori sociali, l’ambito politico deve puntare a convergere verso un «pensiero comune pratico», cioè uno «stesso insieme di convinzioni volte all’azione».
C’è un bene comune, come insegna san Tommaso, che vale di più del bene dei singoli consociati; ma questo bene comune, che Maritain chiama «bene comune immanente», vale meno di quel bene a cui la comunità umana è ultimamente ordinata, che per il cristiano Maritain è il «bene comune increato delle tre Persone divine». Il che implica di accettare l’inevitabile divergenza delle visioni del mondo, scommettendo al contempo sulla possibilità di intendersi concretamente sul da farsi. Questo non significa rinunciare al piano della giustificazione teorica dell’agire pratico (tale rinuncia sarebbe già nichilista); significa piuttosto riconoscere che l’ambito politico non necessita, per essere in buona salute, del consenso totale intorno a visioni sostantive della vita (cosa assai improbabile). Solo così si può realizzare quel bene comune essenziale che Maritain suggeriva quando parlava della società umana come « corps de communications sociales».
Se l’obiettivo del politico è un pensiero pratico comune, anche i cittadini credenti debbono poter dire la loro. Il politico deve essere l’ambito in cui tutti i “diversi” debbono avere la possibilità di contribuire responsabilmente al bene comune della comunicazione. Si può allora essere giustamente perplessi di fronte alla presunta laicità di scelte politiche che mirano a eliminare dallo spazio pubblico ogni riferimento religioso. È veramente pubblico, e perciò sanamente laico, solo quello spazio che scommette sulla libertà dei cittadini, credenti e non credenti, di entrare nel gioco secondo una logica – come insegna Paul Ricoeur – di reciproco, seppur faticoso, riconoscimento. Di conseguenza, l’impegno a tradurre la propria visione del mondo in un linguaggio comprensibile anche da chi non la condivide non deve toccare solo ai cittadini credenti, ma dev’essere inteso – ricorda giustamente Habermas – come «un [comune] impegno collaborativo».
Laicità non equivale perciò a costruire spazi neutri, ma ambiti in cui tutti si raccontino e si lascino raccontare. E «che c’è oggi di più urgente di richiamare l’uomo a se stesso?». Questo invito di De Lubac è quanto mai attuale nell’epoca delle disillusioni. In esso si concentra il compito della presenza cristiana nella nostra società. Si tratta di attuare relazioni buone in grado di rivelare l’uomo a partire dalla sua esperienza più originaria e inconfondibile; infatti, non si impara, né si può ragionevolmente decidere di fare il bene, di essere solidali con l’altro, se non si è mai fatta l’esperienza di relazioni buone, relazioni, cioè, con chi ha a cuore la crescita della nostra libertà. È imprescindibile, a questo scopo, partire dall’esperienza elementare e integrale, comune all’uomo di ogni epoca. Essa parla una lingua che è come una sorgente perenne: niente e nessuno la può spegnere. Attraverso le grandi e universali parole della vita e della morte, dell’amore, della giustizia e della pace, il fiume carsico della questione non posta improvvisamente riaffiora: «E io che sono?»; «Alla fine chi mi assicura?».
Se non ci fosse più nessun racconto in grado di difendere quella verità originaria dell’esperienza, non sarebbe banalmente retorico difendere la dignità umana e la solidarietà? Uno Stato veramente democratico «non può scoraggiare i credenti e le comunità religiose dall’esprimersi come tali anche politicamente, perché non può sapere se, in caso contrario, la società laica non si privi di importanti risorse di creazione del senso». Il racconto cristiano del senso della solidarietà, per esempio, è un caso tipico di questo genere di risorse politicamente rilevanti. Prendiamo ad esempio un passaggio della Lettera di Giacomo, straordinariamente carico di implicazioni sociali: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 1,22).
Cosa implica, per il bene della comunità, il fatto che un cristiano sia chiamato a praticare la Parola? La risposta sembra venire dalla metafora che Giacomo utilizza per spiegare che cosa accade ai soli «ascoltatori »: essi diventerebbero come chi si guarda allo specchio e, vedendo solo la propria immagine riflessa, subito si dimentica chi egli realmente sia, ma resta condizionato dalla sua immagine fugace: non ha autentica coscienza di sé, ha solo immaginazione di sé. Il che, potremmo tradurre, è esattamente l’illusione di Narciso. Ora, come è facile capire, è improbabile che Narciso pratichi la solidarietà, uno dei requisiti primari di una società che difende il bene comune. Chi, al contrario, mette in pratica la Parola e non si limita ad ascoltarla, si occupa di chi ha bisogno, comprende attraverso l’esperienza che il proprio essere umano dipende dalle buone relazioni che intrattiene con gli altri. Detto in altri termini, diventare ' factores verbi' significa vedere l’altro e non solo se stessi.
Anticipazione rischierebbe di perdere una risorsa rilevante per la società, quella che ci rende capaci di vedere l’altro oltre il Narciso che è in noi MILANO. Angelo Scola
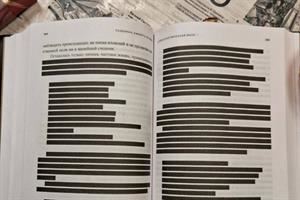
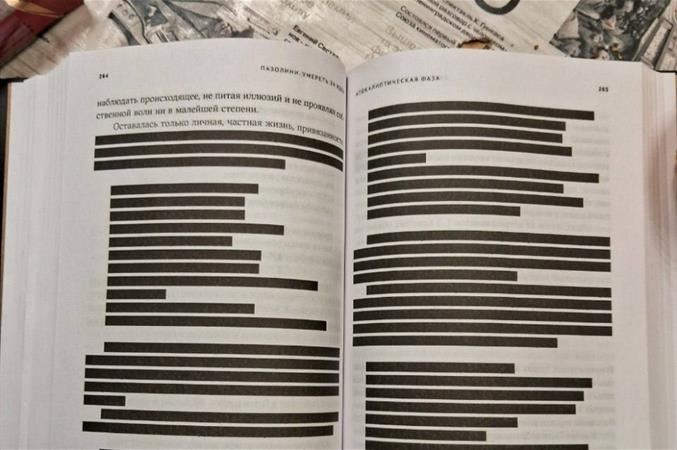








.jpg?dt=1714163656037&Width=300)
.jpg?dt=1714163656037&width=677)





