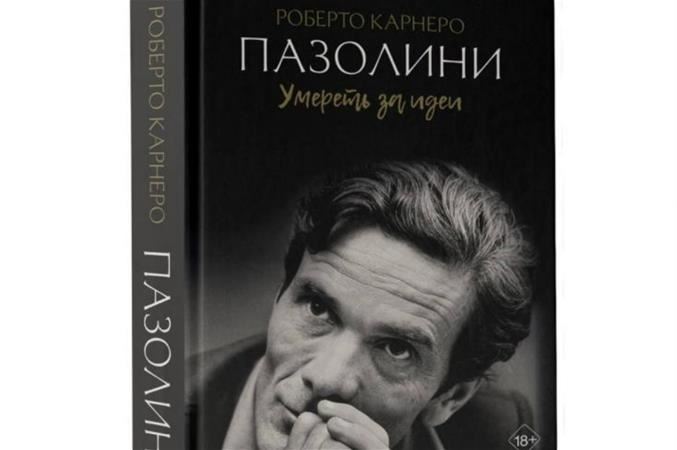Mi capita tra le mani quasi per caso, mentre sto scartabellando nell'archivio. È un vecchio fax, ed è scritto a mano, in italiano. Una calligrafia rotonda, ma veloce, che tende a calare verso il margine destro del foglio. Faccio per rimetterlo da dove è sbucato fuori come uno spiritello dispettoso, quando vengo colpito dalla data. Esattamente 24 anni fa, il giorno è lo stesso: 15 maggio 1994. D'istinto chiudo gli occhi e vedo riemergere quei giorni. E forse riesco anche a sentire la sua voce e le parole di supplica. Quella voce molto disturbata e sofferente che, dal telefono a fili, com'era in quegli anni, mi giungeva da un altro capo della terra. Dal cuore dell'Africa nera. Dal Ruanda: «Pronto... Pronto... Pronto!».
Erano terribili quei giorni di 24 anni fa, e ancora lo sono nel mio ricordo personale. Soprattutto quando dal sonno della memoria si risveglia la cicatrice. E rivedo quelle braccia che si allungano verso di me, per chiedere aiuto. Quelle file di corpi senza vita né forma, distesi a catasta, lungo le strade ai margini della foresta rigogliosa di verde e di profumo di fiori tropicali. Quelle mani alzate che brandivano i machete sporchi di sangue, sventolati per aria quando dovevamo attraversare i posti di blocco di civili armati dagli occhi intrisi di odio per chi non apparteneva alla stessa etnia. Che pazzia che era viaggiare dentro a quella follia umana degradata a bestialità.
Quel fax era stato inviato dal vescovado di Kabgayi alla parrocchia Santa Giuliana di Caponago, oggi provincia di Monza. Cominciava con queste parole che, unite alle seguenti, raggelavano il sangue: «Caro don Luigi, siamo ancora vivi». Senza giri di parole, l'autore di quella corrispondenza rivelava la sua piena consapevolezza che anche la sua sorte era segnata. Era solo una questione di tempo: quando?
«Siamo ancora vivi qui a Kagayi, con più di 20.000 rifugiati, provenienti dappertutto. La maggioranza sono Tutsi... Abbiamo bisogno di far conoscere la nostra situazione. La stampa dovrebbe parlare e chiedere la fine della guerra, chiedere ai ribelli del Fpr di non attaccare, ma di cercare il dialogo, il negoziato. E poi c'è un problema di etnie Hutu e Tutsi, che cercano di eliminarsi a vicenda, ognuna volendo tutto il potere senza l'altro... C'è una politica internazionale dei grandi Paesi che vogliono occupare questa zona dell'Africa centrale, che è un luogo strategico politicamente, militarmente e culturalmente (lingua francese o inglese?)...».
Quelle parole inviate via fax erano di monsignor Thaddée Nsengiyumva, vescovo di Kabgayi, presidente della Conferenza episcopale ruandese. Gli avevo parlato spesso per telefono. E, ricordo, ogni volta sempre con un brivido, un brivido che era difficile non provare quando ci si intrattiene con un condannato a morte consapevole di essere in attesa di salire sul suo patibolo. E così fu.
Ventuno giorni dopo quel fax, ci fu la strage. La morte violenta dei "tredici martiri di Kabgayi". Con monsignor Thaddée Nsengiyumva, morivano monsignor Vincent Nsengiyumva, arcivescovo di Kigali, monsignor Joseph Ruzindana, vescovo di Byumba, e altri dieci religiosi. Uccisi durante il pranzo da quattro ribelli del Fpr che li avevano in custodia, per vendetta.
Ripongo il fax nell'archivio e cerco di farlo anche con la memoria. La radio accesa annuncia che al confine tra Israele e la Striscia di Gaza è strage di manifestanti palestinesi. Richiudo gli occhi e penso: perché è così difficile convivere e condividere?
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI:
.jpg?dt=1714144783645&Width=300)
.jpg?dt=1714144783645&width=677)