Quel sano limite alla proprietà privata dà vita alla comunità cristiana e civile
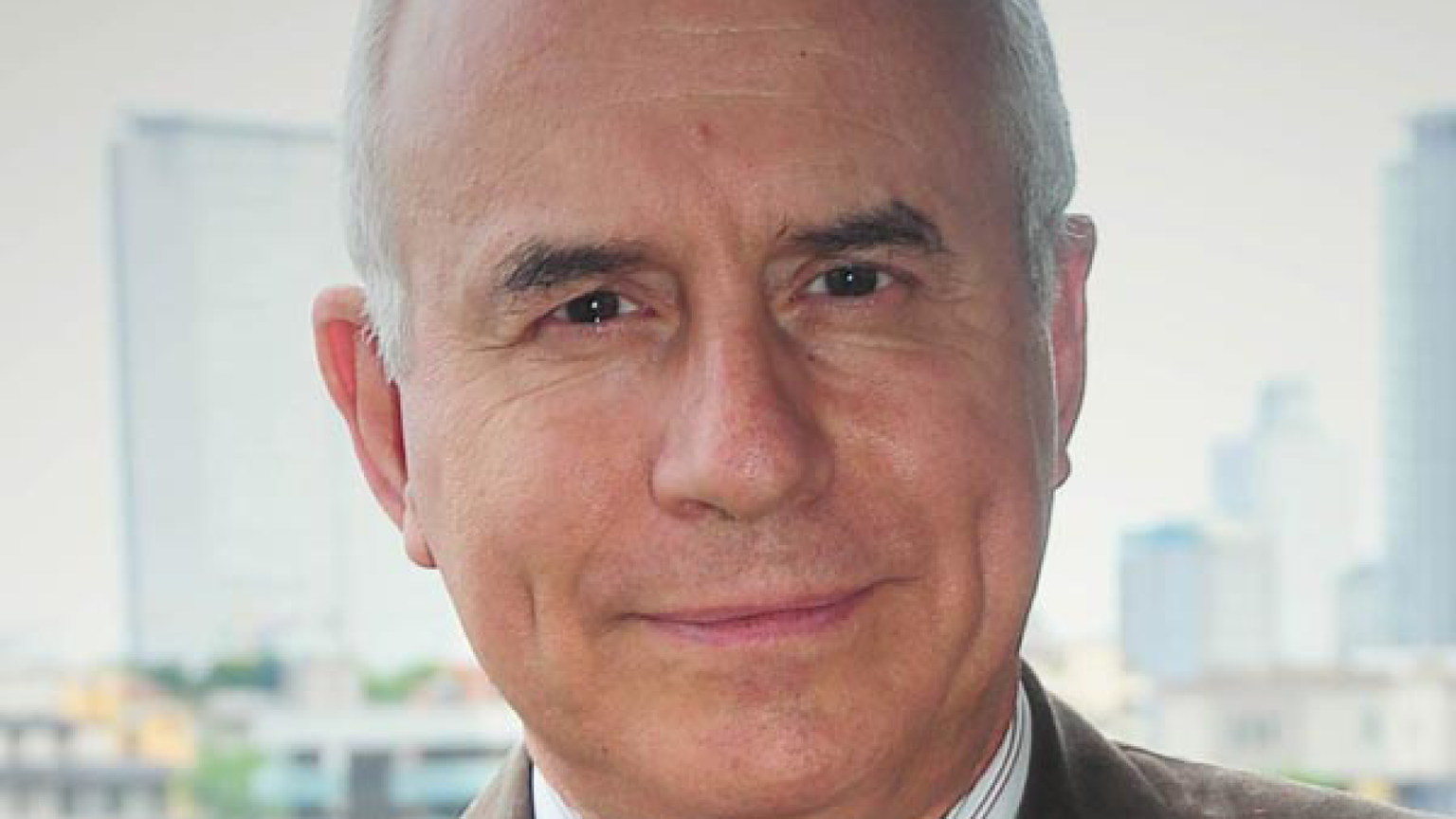
Signor direttore,
sono un suo lettore e un cattolico formatosi alla scuola dei frati francescani della mia Firenze. Ci sarebbe spesso da intervenire sul suo giornale quanto a ortodossia cattolica in merito agli articoli che talvolta vengono proposti, ma ciò che papa Francesco ha sostenuto domenica 11 aprile, commentando un passo degli Atti degli Apostoli, merita una precisazione: si è evocato il "comunismo" mettendo in discussione la proprietà privata, quasi una sorta di messaggio subliminale di chiaro ordine politico. Senza prendere in considerazione le valide argomentazioni sul tema prodotte il 13 aprile da Antonio Socci su "Libero", senza neanche citare testi di studiosi di cose bibliche, qualsiasi bravo seminarista, ma anche un ragazzo che abbia buona formazione religiosa è in grado di sapere che i cristiani dei primi secoli erano indotti a mettere in comune le proprie cose perché convinti dell’imminenza del Giudizio Universale, cioè della parusia, interpretando letteralmente le parole del Messia, come predicato e assicurato dagli Apostoli. Quindi, più nessuna importanza avevano allora i beni materiali perché si stava aspettando la morte da un giorno all’altro. Questa era la credenza, poi gradualmente abbandonata, visto l’ininterrotto perdurare dei tempi e della vita. Non mi contraddica su questo, direttore, ma faccia capire, invece, che almeno lei conosce certe cose storiche.
Nedo Tavera
sono un suo lettore e un cattolico formatosi alla scuola dei frati francescani della mia Firenze. Ci sarebbe spesso da intervenire sul suo giornale quanto a ortodossia cattolica in merito agli articoli che talvolta vengono proposti, ma ciò che papa Francesco ha sostenuto domenica 11 aprile, commentando un passo degli Atti degli Apostoli, merita una precisazione: si è evocato il "comunismo" mettendo in discussione la proprietà privata, quasi una sorta di messaggio subliminale di chiaro ordine politico. Senza prendere in considerazione le valide argomentazioni sul tema prodotte il 13 aprile da Antonio Socci su "Libero", senza neanche citare testi di studiosi di cose bibliche, qualsiasi bravo seminarista, ma anche un ragazzo che abbia buona formazione religiosa è in grado di sapere che i cristiani dei primi secoli erano indotti a mettere in comune le proprie cose perché convinti dell’imminenza del Giudizio Universale, cioè della parusia, interpretando letteralmente le parole del Messia, come predicato e assicurato dagli Apostoli. Quindi, più nessuna importanza avevano allora i beni materiali perché si stava aspettando la morte da un giorno all’altro. Questa era la credenza, poi gradualmente abbandonata, visto l’ininterrotto perdurare dei tempi e della vita. Non mi contraddica su questo, direttore, ma faccia capire, invece, che almeno lei conosce certe cose storiche.
Nedo Tavera
Spero proprio, gentile signor Tavera, che lei oltre che di "Avvenire" e di "Libero" (visto che la mail che mi ha indirizzato era rivolta sia a me sia al direttore di quell’altro quotidiano) sia un lettore anche dei testi dei grandi Papi – da Leone XIII a Francesco, dall’ultimissimo tratto dell’Ottocento, lungo tutto il Novecento e in questi primi decenni del Ventunesimo secolo – che hanno costruito il patrimonio della Dottrina sociale della Chiesa a partire dalla Scrittura e dalla Rivelazione cristiana e dentro la realtà dei complessi "tempi nuovi" nei quali la società umana stava cominciando a inoltrasi e che ancora ci incalzano, ora più manifestamente malati e più bisognosi di conversione e di salvezza. La Dottrina sociale era ed è magistero per tempi nuovi, segnati in profondità dalle pratiche e dalle "profezie" del capitalismo e del socialismo, ma che via via sono diventati nuovissimi per rapidità e potenza (anche devastante) dei cambiamenti eppure spesso vecchissimi per pre-potenza e ingiustizia (anche vertiginosa) degli arretramenti. Nel caso in cui lei, nonostante i suoi buoni maestri francescani, lettore di quei cristianissimi testi non fosse stato, o non lo fosse stato abbastanza, mi auguro che lei lo diventi. Un lettore attento, e anche critico ovviamente, ma soprattutto libero da occhiali astrattamente ideologici o dalla tentazione di attribuire quelle lenti distorcenti ad altri, persino ai successori di Pietro e ai loro insegnamenti, che sono interessanti per tutti e impegnativi per coloro che si dicono cattolici.
Possiamo e dobbiamo coltivare la virtù umile della ragionevolezza e non presumere delle nostre forze. Ma non dobbiamo illuderci di poter scovare sempre vie quiete e comode (o meno inquiete e più comode). Questo, a mio avviso, significa anche resistere alla tentazione di risolvere la questione del senso evangelico della comunione e della comunità con la storiella del "buon cristiano" delle origini che, poiché aspettava l’immediato ritorno del Salvatore, si disinteressava dei beni (e dei mali) di quaggiù e si preoccupava solo del tesoro di lassù. Se le ragioni dei cristiani fossero state così semplici e, in fondo, così remissivamente "celesti", gli uomini e le donne della Chiesa delle origini non avrebbero seguito Cristo, Parola fatta carne, per tutte le vie della Terra, non avrebbe seminato tanta diversa speranza e neppure irradiato a partire dalla periferica Gerusalemme luci apparentemente modeste eppure così vivide da illuminare dall’interno, e da far come lievitare, ciò che al mondo già sembrava grande e perfetto: la sapienza di Atene e la forza civilizzatrice di Roma. Un incontro fecondo – nonostante errori, compromessi e travisamenti – e capace di far germogliare una storia nuova, nella quale l’autentica cifra dei cristiani è la partecipazione e non l’indifferenza, la libertà coniugata alla responsabilità, la resistenza agli egoismi e non la complicità con essi. Nell’editoriale di "Avvenire" martedì 13 aprile (leggi qui) lo ha ricordato Alessandra Smerilli, religiosa ed economista, oggi chiamata dal Papa al ruolo di sottosegretaria del Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale: «La subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni è un principio che accompagna la Chiesa dagli Atti degli Apostoli fino al Concilio Vaticano II, e oltre». E Luigino Bruni, economista filosofo che anche oggi scrive in queste nostre pagine delle Idee, ci ha fatto notare più volte che il fatto che i primi cristiani vedessero con tanta chiarezza il nesso tra parusia e comunione dei beni significa che quest’ultima era considerata una pre-condizione per essere messi tra «i benedetti del Padre mio». E questo, a differenza di quanto lei sembra ritenere, gentile lettore, rafforza l’importanza della libera comunione dei beni, non la svilisce. Tanto più che essa è sempre rimasta una linea feconda del cristianesimo in quello che ancora Bruni definisce il suo «secondo e niente affatto secondario, binario», tracciato dagli ordini monastici e dagli ordini mendicanti, "costruiti" appunto attorno a capitolo 4 degli Atti degli apostoli, ed essi stessi, per secoli e secoli, decisivi "costruttori" delle radici spirituali, della dimensione sociale e del buon mercato d’Europa.
Sono convinto che noi cristiani – non solo i francescani, generati dal serafico e concretissimo carisma del santo di Assisi, mio amato concittadino – siamo tenuti a essere custodi e generosi continuatori di tutto questo. E non per ideologico "comunismo" o vago "benecomunismo", ma per la consapevolezza di un patrimonio celeste e terreno, nel quale l’idea del saldo (e mai ottuso) limite all’interesse particolare e alla (legittima) proprietà privata spinge a dare vita a una rete di relazioni umane, e quindi anche economiche, giuste e pacificamente condivise. Giustizia e pace non sono la nostra fede, ma sono frutto della nostra fede. Senza questi frutti, la nostra fede è come morta. La libertà non è liberazione. E le società si fanno infelici.
Ammetto di aver cominciato a frequentare molto presto l’idea del limite inesorabile del «proprio» che lei, gentile lettore, pare considerare poco attendibile e mostra di tenere in gran sospetto persino di "ortodossia". È un’idea che ho ascoltato e ho visto sviluppata nei ragionamenti e nel modo di vivere e di lavorare di tanti e, per primi, dei miei genitori. È un’idea viva, che ho imparato presto a sintetizzare attraverso la formula della «funzione sociale» (comune) delle proprietà personali e familiari. Sulle nostre pagine continuiamo a tornarci spesso. E la splendida e illuminante serie di articoli dedicata da Bruni all’organizzarsi dell’«economia civile» nella francescana (e domenicana) Italia del Trecento e dei secoli successivi – un’Italia di cui la "sua" Firenze, signor Tavera, è stata capitale – aiuta a capire meglio perché quei mercatanti cattolici fossero «in società con Messer Domineddio» e considerassero i poveri effettivi e legittimi rappresentanti di Nostro Signore e perché, tramite loro, a Lui "pagassero" ogni anno cospicui dividendi e alla comunità – alla città e alle sue opere comuni – attribuissero spesso gran parte dei beni "conquistati". Una scelta compiuta non solo al termine della vita terrena, per estrema filantropia, ma già durante il cammino, per fede "operante" e per la certezza che la giusta condivisione, realizzata qui e ora, è via per il paradiso.
Siamo in parecchi, più di quanti si pensi, a ritenere che il mondo è in una crisi così grave perché gli uomini e le donne (anche credenti) hanno dimenticato e ancora dimenticano, in molti modi, il loro limite. Quel limite che non mortifica e non separa, ma dà giusta proporzione alla fatica quotidiana, alle cose prodotte, alle ricchezze realizzate, alle attese di ognuno. Quel limite che rende prezioso ciò che ci porta a superarlo (non a ignorarlo o, al contrario, a mitizzarlo), oltre il proprio stretto interesse: per amore, per amicizia, per fraternità. Quel limite che dà senso, e disegna la porta verso un futuro più più giusto, più umano e, dunque, più "comune".
Mi piace pensare che assolutamente a tutti, e a maggior ragione ai cristiani, spetti di esercitare la pazienza e la forza necessarie per riedificare questa sana consapevolezza del limite, valorizzando ogni talento e bene in forma di vita buona, e mai solo per noi stessi. Il Papa, il nostro Francesco, ce lo sa dire in modo diretto e appassionante. Basta ascoltarlo davvero per rendersi conto che non c’è proprio nulla di «subliminale», come lei teme, nel suo testimoniare alla Chiesa e al mondo. Abbiamo proprio bisogno di questo cordiale e forte parlar chiaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







