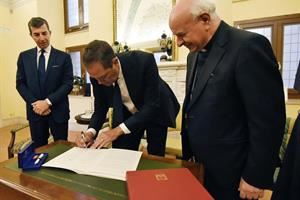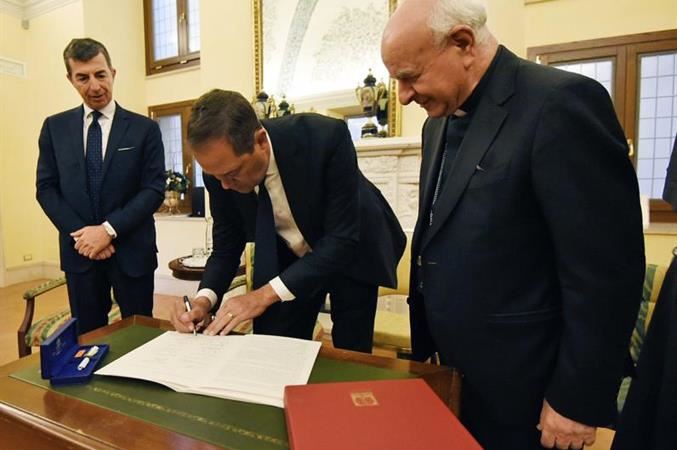Un limite al profitto. E poi un’impresa che sappia dare una collocazione all’uomo inteso nella sua interezza. Magari che cresca meno, ma che dia spazio all’umanità. L’azienda come «un buon luogo di lavoro fatto di persone». Sono tante le suggestioni che Matteo Marzotto riesce a trasmettere parlando di impresa e di etica, di responsabilità sociale dell’imprenditore e di bilanci che comunque devono chiudere bene. Marzotto – imprenditore e manager con la vocazione al sociale appartiene alla sesta generazione di una famiglia che all’industria italiana ha dato e dà molto –, parla ritornando da un incontro con i volontari e i ricercatori della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (di cui è da poco presidente e che ha contribuito a creare vent’anni fa), e poco prima di un suo intervento a Vicenza nel dibattito «L’economia ostacola o produce futuro?» nell’ambito del Festival Biblico 2018. Marzotto parla in modo accorato: «Nel fare impresa occorre capire dove mettere l’uomo. Il profitto giusto è auspicabile. L’imprenditore generando profitto genera comunque valore per tutti. Ma se c’è profitto ci deve essere profitto per tutti. La vera domanda è quindi che priorità dare all’uomo. Non basta rendere l’azienda dinamica, bisogna renderla anche un buon posto in cui vivere».
Non si rischia di cadere nel paternalismo d’impresa?
Occorre distinguere. Io non sto parlando di paternalismo e di buonismo, ma di attenzione. Il buon imprenditore deve essere una persona attenta. Capace di interagire bene con tutti e in maniera equa. E poi deve lavorare. E comunque di un buon paternalista c’è sempre bisogno.
Lavoro prima di ogni cosa, dunque?
Non proprio e non del tutto. Io arrivo dalla cultura del lavoro duro. Ma non sono particolarmente colpito da chi lavora sempre, ininterrottamente, anche la domenica. Un conto è far fronte a momenti difficili. Un altro è alienarsi. Per lavorare intendo essere sempre accanto a chi collabora con te. E lavorare tutti, ma con misura.
E i bilanci?
C’è un bilancio fatto di numeri, che deve essere per quanto possibile buono ovviamente, ma ci deve anche essere un bilancio fatto di persone e per le persone, che da imprenditore definirei un bilancio umano. Ci sono aziende con numeri straordinari, che creano valore per i loro azionisti, ma con bilanci umani miserevoli. Occorre esserne consapevoli perché nella vita, anche aziendale, tutto prima o poi torna.
Poi c’è la competitività.
Certo. Con la competitività occorre fare bene i conti, perché spesso comporta scelte dure. È bello immaginare che in un’azienda che va bene e che cresce, la competitività vera la si costruisce passo dopo passo, anche offrendo qualcosa in più ai propri dipendenti. Intendo compartecipazione, servizi, benessere. Perché alla lunga si è senz’altro più competitivi se ci si sente tutti parte di un solo progetto.
Il profitto ha un limite?
Credo che ci possano essere dei margini molto buoni, ma in assoluto occorre che vi sia una equità di fondo. Una marginalità eccessiva credo non sia sostenibile, ogni settore industriale ha le proprie caratteristiche ma in genere mi sento di dire che preferisco un’azienda che cresce in modo equilibrato, stabile e a lungo.
L’uomo dunque al centro. Ma lei ha mai dovuto licenziare?
Purtroppo sì. E non l’ho fatto a cuor leggero. Quando si licenzia è una sconfitta per tutti, ma soprattutto per un imprenditore. Sono quelli i veri momenti di difficoltà. Ed è in quei momenti che ci vuole grande rispetto e attenzione all’altro.
Lei si considera un capitalista?
Io mi considero parte del sistema capitalistico. Ma il mio modello non è il capitalismo finanziario e nemmeno quello socialistico. Io penso a un capitalismo illuminato, che assicuri buoni margini, ma duraturi nel tempo. Con tutto ciò che questo implica. Nuovi prodotti quindi, più basso impatto ambientale, più attenzione e meno calcolo.
È la visione dell’imprenditore socialmente responsabile quella che lei ha in mente. Ma non è alla portata di tutti. Non crede?
Lo so. Ma non pretendo che tutti la pensino come me. Io arrivo da una famiglia che mi ha dato molto, anche sofferenze, ma che è sempre stata molto attenta al sociale, che personalmente sento come una sorta di missione. Credo però che un atteggiamento di questo genere ci possa essere anche in aziende con scarso margine. Si può essere giusti anche nelle difficoltà. D’altra parte, potrebbe essere auspicabile un sistema istituzionalizzato che agevoli le imprese virtuose, più attente all’ambiente umano che le circonda.
Etica d’impresa ed etica cristiana vanno di pari passo?
La mia idea d’impresa deriva da una visione cristiana. Però io conosco degli eccezionali imprenditori e manager, che hanno grande rispetto per la spiritualità e per l’uomo, anche senza avere una spiccata pratica religiosa. Esistono poi tantissime altre persone con una scarsa considerazione dell’uomo, in senso lato 'cristiani tiepidi'. Ma quando parli all’uomo pianti un seme che magari farà fatica a crescere ma poi crescerà e darà frutto. E lo può piantare chiunque. Poi certo c’è la fede.
Cioè?
La fede è un valore aggiunto straordinario anche per gli imprenditori, ma non è gratis.