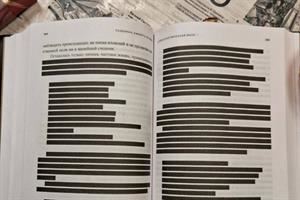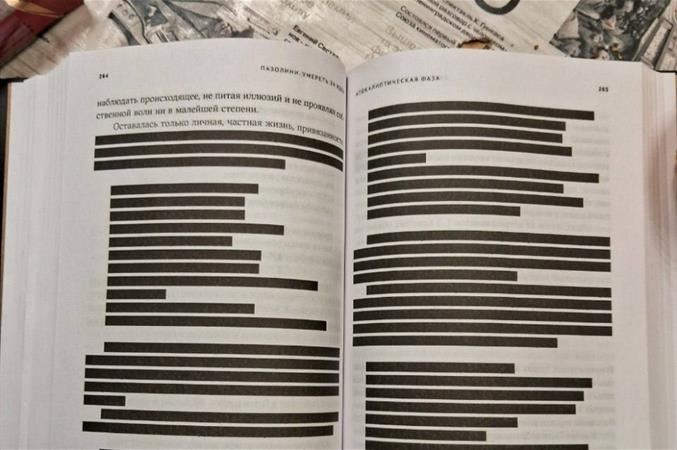lo scrittore cubano Leonardo Padura - Epa/Quique Garcia
«A Cuba l’esilio ha sempre avuto una lettura politica: chi andava via era controrivoluzionario, chi restava era a favore della rivoluzione castrista. È un dramma che ha segnato dalla nascita la nazione cubana. Io l’ho voluto affrontare in una prospettiva più vicina alla vicenda umana, sia in senso locale che universale». L’esilio è uno dei temi ricorrenti della narrativa di Leonardo Padura, lo scrittore e giornalista cubano che ha conquistato critica e pubblico con la sua serie poliziesca sulle avventure del tenente Mario Conde. Ed ora è il filo rosso di una novella corale, Como polvo en el viento ( Come polvere nel vento), di quasi 700 pagine, pubblicata da Tusquets nei paesi di lingua ispanica, subito piratata a Cuba e già in cima alle classifiche argentine. Padura racconta la sua generazione di esiliati e 'insiliati', dalla crisi degli anni Novanta del 'periodo speciale' post–sovietico all’attualità. Amici, familiari, genitori separati dalle varie ondate della diaspora. E come questa abbia cambiato per sempre non solo chi è partito – balseros, i tanti forzati a emigrare per persecuzione o necessità – ma anche chi, come l’autore, ha scelto di restare a Cuba. Nel romanzo si intrecciano le storie del Clan, un gruppo di compagni che finirà disperso nel mondo – da Miami a Madrid, a Barcellona, Puerto Rico, New York e Buenos Aires – a partire dalla misteriosa scomparsa di Elisa Correa, l’anima della compagnia, dovuta a ragioni occulte, che si svelano lungo la trama. «Cosa spinge ad andarsene o restare è la domanda che si pongono tutti i protagonisti, ognuno con le proprie motivazioni, frustrazioni professionali, motivi sentimen- tali», anticipa Padura ad Avvenire dalla sua casa di Mantilla, all’Avana. «Ha a che vedere con lo sradicamento, la permanenza, la fedeltà, gli amori, i tradimenti, con la vita».
Padura, lei narra la 'meglio gioventù' progressivamente impoverita dalla precarietà. È la fine della «felice credulità » nell’uomo nuovo?
Sono persone tipiche di una generazione, la mia, che per la prima volta accede all’istruzione di massa all’università. Cibernetici, medici, ingegneri, matematici, fisici, qualche filologo come me. Le aspirazioni del nostro futuro sono state coperte dal manto oscuro di una profonda crisi, che ci ha costretto alla lotta per la sopravvivenza. Clara, uno dei personaggi, dice: «Tutte le ragioni per restare o esiliarsi sono valide, bisogna comprenderle e rispettarle».
Anche lei, che è rimasto, non è a salvo dallo sradicamento…
Se avessi voluto emigrare, avrei potuto farlo nel 1992, quando viaggiai a Miami, o due anni dopo, quando andai in Messico per un premio. A Cuba non avevamo nulla, niente da mangiare, zero denaro. Ma io avevo tempo e storie quotidiane da narrare, una strada come scenario. Se fossi andato via, non avrei potuto dedicarmi alla scrittura».
Da allora la povertà si è estesa con la corruzione, mentre avanzava il controllo sociale. Quanto hanno influito sui suoi personaggi?
A Cuba il grande cambio sociale avvenne con la rivoluzione del 1959. Poi, negli anni Ottanta, accadde l’impensabile: la caduta del muro di Berlino e il collasso dell’Unione Sovietica. Noi cominciammo ad avere una percezione diversa da quella avuta fino allora. È un tema affrontato nel mio romanzo L’uomo che amava i cani sull’assassino di Leon Trotsky, dove un giovane poeta cubano tenta di capire cosa sia stato delle utopie, e parla di perdite, delusioni profonde. Noi vivevamo in un sistema omogeneo, in cui tutti eravamo uguali e ugualmente poveri. Però, con un unico paio di scarpe e una camicia, ho avuto la possibilità di studiare e di formarmi. In questa società hanno cominciato a espandersi borse di povertà, lampi di ricchezza, e dell’uguaglianza non si parla più. La gente esprime opinioni nelle reti sociali. L’altro giorno in tv c’era un reportage su un gruppo di impiegati negli uffici della 'tessera di povertà', che qui ancora esiste: si erano inventati 100 bambini per appropriarsi dei libretti destinati a loro. La corruzione è diventata un’alternativa vitale in un paese impoverito.
«Come siamo arrivati a questo?» è la domanda ricorrente nel libro. Scandisce un logoramento morale?
Sì, quando le condizioni economiche e sociali si deteriorano, decadono anche i valori. Nella cultura urbana è evidente, ad esempio, nella musica come il reggaetón, che esprime posizioni machiste, a volte razziste, con un linguaggio aggressivo. Il governo stesso ha riconosciuto la necessità di muovere «una battaglia epica» contro la corruzione.
Lei critica anche le posizioni più radicali della diaspora a Miami. È possibile la riconciliazione?
È necessaria. Non significa che nessuno, sia fuori che dentro l’isola, debba dimenticare le offese. Ma dovremmo avere la capacità di superarle in uno spirito di perdono, perché la ricostruzione e ricostituzione di una nazione deve essere fatta da tutti. I fondamentalismi, divenuti per alcuni strategia di vita, non esprimono il sentire della maggioranza, ma si impongono sul dialogo.
È ancora apolide chi decide di emigrare?
La patria è un concetto globale, non appartiene a governi o partiti. A Cuba è il sentimento che fu espresso da José Martí nel pensiero «Con tutti e per il bene di tutti». A lungo qui è stato considerato apolide chi sceglieva «l’uscita definitiva dal paese». Ma chi ha diritto di decidere? Per me patria è questa casa in cui vivo, nel quartiere di Mantilla, dell’Avana, nel paese che si chiama Cuba e da dove le parlo a 10mila km di distanza. È questo piccolo luogo di appartenenza e di incontro.
Lei parla della «ferocità» cubana per preservare un’essenza propria: è una questione identitaria?
Tutti gli emigranti lottano per preservare un’identità. Ci sono due modi per assumere l’esilio: uno è l’integrazione per assimilazione, l’altro è tentare di preservare la propria identità spirituale e culturale. Si tenta sempre di essere se stessi cercando uno spazio di integrazione. L’emigrazione è un enorme dramma, per questo interessa l’arte, la filosofia, la cultura, il cinema.
La visita di Obama nel 2016 a Cuba aprì le speranze di ristabilire relazioni diplomatiche con gli Usa. Poi però arrivò Trump e svanirono.
Le relazioni con gli Stati Uniti sono vitali per lo sviluppo del paese. E sono state pessime per 60 anni, eccetto durante i pochi mesi del secondo mandato di Obama, la cui politica mirava a produrre un cambio nell’isola. I politici cubani si sono resi subito conto di quanto fosse pericoloso e hanno alzato un muro per evitare la penetrazione per vie diverse dallo scontro. Con Trump la politica del muro contro muro ha toccato estremi inediti dalla crisi dei missili del 1962, con ripercussioni soprattutto sulla vita dei cubani. Il nostro quotidiano è oggi ancora più difficile per la pandemia, che è stata gestita bene, secondo criteri scientifici, medici, epidemiologici. Ma ha messo a nudo insufficienze e carenze strutturali, perché la pressione dell’embargo nordamericano è molto più forte.