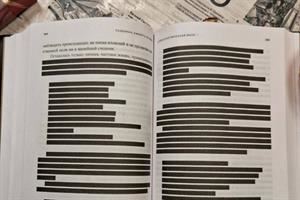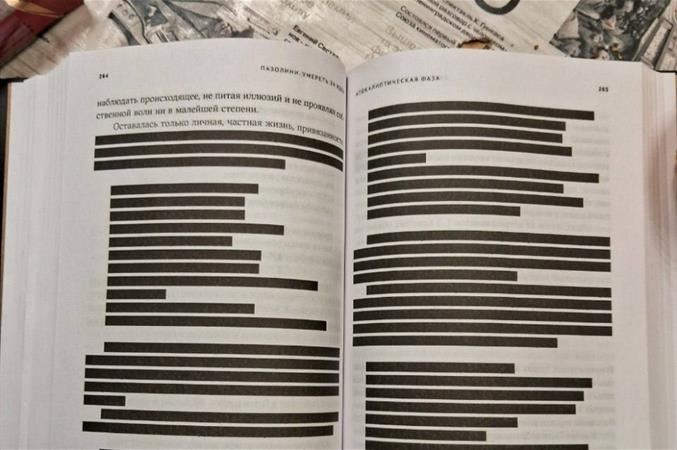Un dipinto di Pierre Subleyras esposto nella mostra sul Barocco a Venaria Reale: “Diana ed Endimione” (1740 circa) - .
C’è un limite profondo nella storia dell’arte come è affrontata in Italia – a scuola e a livello divulgativo – ed è l’italocentrismo. È un difetto antico, in parte dovuto a fattori interni e in altrettanta parte alla costruzione del mito di un italico eccezionalismo estetico (prodotto dal disposto combinato di manufatto e paesaggio) da parte degli sguardi d’Oltralpe. È qualcosa che si è condensato nella favola che vuole l’Italia custode di percentuali variabili del patrimonio artistico mondiale. Certo c’è una specificità italiana, dovuta a ragioni storiche: la stratificazione millenaria, l’ininterrotta continuità di civiltà e infine la frammentazione che ha favorito la gara tra territori e campanili, devastante sotto il profilo politico ma fruttuosa sotto quello creativo.
La storia dell’arte italiana assomiglia a uno straordinario, lunghissimo canto della cicala. Ma c’è vita oltre le Alpi. Accade invece che, nei manuali e in quanto sopravvive nell’opinione comune, la prospettiva italiana porti a veri e propri fraintendimenti, si pensi a come è raccontato il romanico, il cui spirito è comprensibile solo in un quadro europeo, dove si manifestano gli esiti più alti. Il gotico sembra in parte salvarsi perché è impossibile fare a meno delle cattedrali francesi, ma è per il resto terra incognita. Ignoriamo o quasi quanto accade nella scultura in area francese tra XI e XII secolo, fatto salvo dire che sono i modelli a cui guardano i nostri artisti.
Il Rinascimento (termine fuorviante), a cui in quest’ottica tende teleologicamente un percorso avviato da Nicola Pisano, nasconde la lunga fioritura del gotico e obnubila il continente della pittura di Fiandra (che diventa “l’altro Rinascimento”). L’arte italiana ha un suo proprium rispetto all’Europa, ed è la pertinacia del retaggio antico (ossia una questione di retorica civile e identitaria e insieme la continuità linguistica del sapere costruttivo e manuale) che mitiga sempre le formidabili sperimentazioni d’Oltralpe e che nel Quattrocento si riversa nell’artificialità della ricostruzione filologica di uno stile: una pratica che non si basa sulla vitalità della continuità della tradizione “orale”, ossia consegna e trasformazione, ma nella astratta reversione temporale, contro la corruzione del presente, a una fissata purezza ideale individuata da modelli storicamente definiti, e quindi sottratti alla storia stessa: il latino di Cicerone e Virgilio, l’architettura di Vitruvio…
Il glorioso Rinascimento è dunque anche la nascita dello storicismo. Accade così, proseguendo il cammino, che sempre nei manuali i tre più grandi pittori del Seicento, Rubens (la vera miccia del barocco italiano, a produrre il quale non sarebbero mai bastati Caravaggio e Carracci: senza di lui Bernini non esisterebbe), Velázquez e Rembrandt, sono protagonisti di brevi medaglioni con nullo o ridotto contesto. Fino al Settecento quanto accade nelle altri parti d’Europa è trattato in via sintetica, quasi secondaria. E quando si approda al XIX secolo, ecco all’improvviso la storia dell’arte diventare europea, con la nuova grande capitale a Parigi, saltata fuori fatta e finita come Atena della testa di Zeus…
Per questo motivo è salutare una visita alla mostra “Sfida al barocco” (curata da Michela di Macco, Università di Roma La Sapienza, e Giuseppe Dardanello, Università degli Studi di Torino, fino al 20 settembre) alla reggia di Venaria Reale. Il percorso, articolato e ricco di opere, polarizza la questione del tardobarocco, ossia gli anni dal 1685 al 1750, su un arco retto dai pilastri di Roma e Parigi, con Torino a fungere da chiave di volta. Una narrazione non solo policentrica ma paritaria, che mette in luce tendenze di lungo corso i cui esiti si proiettano proprio nella modernità. C’è in trama la doppia anima di barocco e classicismo, i cui confini sono fluttuanti.
C’è poi il problema del goût, che investe interi universi estetici e codici linguistici - un terreno su cui nel 1665 si erano consumate le incomprensioni del viaggio parigino di Bernini. C’è infine un intrecciarsi di linee, alcune delle quali sono cul de sac, altre sono vettori fondamentali di forze e di sviluppi. La mostra presenta pittura, tra opere da camera e pale d’altare, scultura (la selezione di bozzetti in terracotta e marmo è davvero ricca), oggetti di arredo e argenti, architettura. Roma, città dalla vocazione cosmopolita, è un teatro di stili dove le tradizioni (antiche e moderne) sono così forti da avere un ruolo vincolante. Parigi sviluppa invece un confronto diretto con il proprio tempo.
Il fatto è che Roma (e l’Italia in generale, salvo forse Venezia) si trova in una sorta di impasse, stretta tra le troppe eredità. In Francia, anche politicamente, il fardello è meno ingombrante e la tradizione, appare un problema così ideale da consentire lo sviluppo di una autonomia sempre più marcata. E Torino? Torino, prima città francese in territorio italiano, cerca una sua identità di capitale di nuova fondazione, per quanto di antico lignaggio. I Savoia costruiscono così una identità ibrida e di sintesi, specialmente quando alla regia sale il genio di Juvarra: città europea e allo stesso tempo scena della scuole pittoriche italiane, attraverso il confronto diretto dei maestri nelle chiese da lui progettate.
I romani Sebastiano Conca e Francesco Trevisani, il veneto Sebastiano Ricci, Claudio Francesco Beaumont, tra i pochi pittori locali capaci di reggere il confronto, il napoletano Francesco Solimena (la cui pala con san Filippo Neri è tra i vertici pittorici di un secolo intero): pittori eccellenti che però si muovono in una palude di convenzioni. Le loro sono opere tecnicamente grandiose e formalmente ripetitive. Il discorso vale anche per la scultura: sono i bagliori di uno splendore epigonico.
In Francia (i cui maggiori artisti si formano a Roma, all’accademia di Villa Medici) si manifestano i germi sostanziali di una libertà di visione e di linguaggio. Su tutti i nomi di Pierre Subleyras e Jean-Baptiste-Siméon Chardin (dovremmo aggiungere Watteau, ma in mostra non c’è). L’Endimione del primo è un capolavoro di studio formale, di luce cinerina e di brani di naturalismo; più radicali sono il dipinto con il servitore di schiena, immagine irriducibile ai canoni iconografici dell’epoca, quindi la tela con san Camillo e il nudo femminile dove i modelli classici e recenti sono spunto per dipinti di spiazzante modernità. Del secondo, tra i grandi della storia dell’arte, pittore di pochi soggetti e di una grandiosa semplicità, abbiamo una lepre e un’anatra, frutti della caccia. Pezzi vertiginosi, dove ci sono solo l’artista, la pittura e la realtà. Libertà e realtà. Per capire perché Parigi è già la capitale della pittura moderna, partite da qui.










.jpg?dt=1714163656037&Width=300)
.jpg?dt=1714163656037&width=677)