Chiaro il risultato, non le conseguenze
l risultato del voto del 4 marzo è chiaro, le conseguenze no. E se questo, per un verso, è naturale in un quadro politico fortemente cambiato dai votanti (stavolta in calo lieve sul 2013) ...
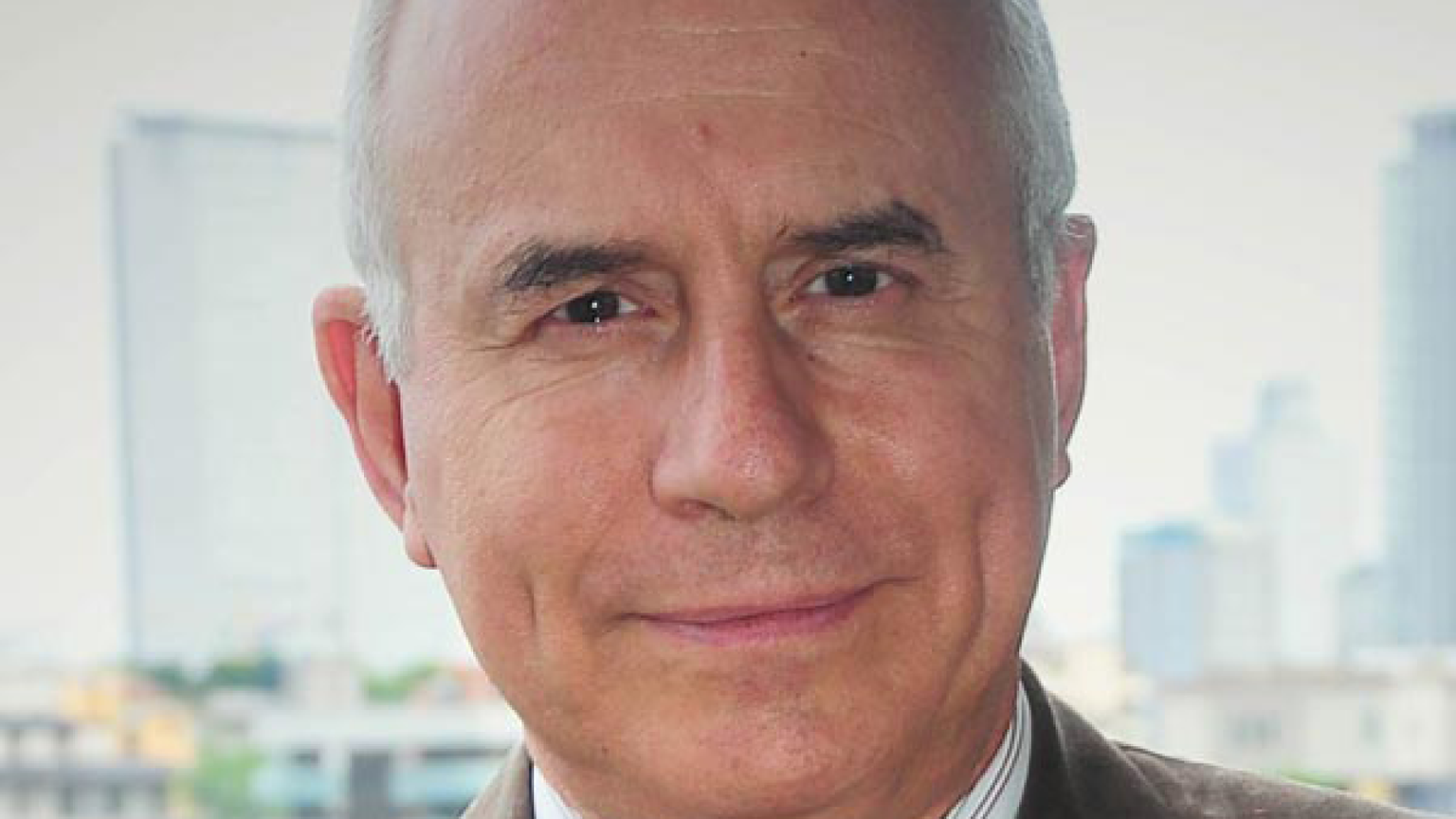
Il risultato del voto del 4 marzo è chiaro, le conseguenze no. E se questo, per un verso, è naturale in un quadro politico fortemente cambiato dai votanti (stavolta in calo lieve sul 2013), per un altro verso sottolinea un nodo che, in base alle prime mosse di vincitori e sconfitti, è davvero duro da sciogliere. E non solo perché dopo una campagna elettorale a spade sguainate sarebbe stato impossibile anche un repentino cambio di toni e di copione.
Partiamo, allora, dai dati. Vince, a livello di partito, il Movimento 5 Stelle guidato da Gigi Di Maio, perché si afferma definitivamente come la forza più votata dagli italiani, assume di fatto la rappresentanza (non esclusiva, ma largamente prevalente) di un Sud ferito ed esasperato e conquista di forza il centro – oggettivo, non geopolitico – della scena politica. Ma vince, a livello di coalizioni, anche il centrodestra dell’alleanza-competizione tra Lega e Forza Italia. E in esso vince soprattutto Matteo Salvini che batte Silvio Berlusconi nella corsa alla leadership e realizza, con parole d’ordine in rivendicato stile lepenista, il progetto di mietere consensi in tutta la Penisola.
Perde, invece, tre volte il Pd di Matteo Renzi che dopo cinque anni di governo (con tre premier, due segretari e una scissione) dimagrisce sin sotto la soglia del 20%, non è più il perno di una grande coalizione e rischia di invischiarsi in una tutt’altro che appassionante guerra interna sui tempi e modi per arrivare a una nuova leadership dopo le dimissioni al rallentatore – diciamo così – del segretario. Ma perde nettamente anche la sinistra che si è chiamata Leu, voluta da Massimo D’Alema e guidata da Pietro Grasso, perché si rivela un partito scissionista piccolo piccolo, capace di aggregare ben poco a sinistra del Pd e di raccogliere meno della metà dei voti in uscita da quel partito. E pèrdono pure gli europeisti radicali di Emma Bonino che conquistano alcuni segmenti di elettorato, ma parecchi ne tengono alla larga e non mobilitano nemmeno l’altra metà del mondo post-pannelliano (impegnata in uno "sciopero del voto" per la riforma delle carceri). Pèrdono infine, separatamente ma come in blocco, tutte le mini-aggregazioni e i partitini germinati dalle progressive frantumazioni (di palazzo o di piazza) delle formazioni che in ogni dove si sono richiamate alla mortificata tradizione del popolarismo cattolico.
Nessuno, però, tra i vincitori si avvicina a numeri sufficienti per governare. Dunque, come era prevedibile e, infatti, previsto, le regole elettorali del Rosatellum sono state usate nelle urne per costruire un nuovissimo quadro parlamentare, ma non un quadro di governo. Una rivoluzione a metà, o – se si vuole – in corso. Che spinge i due vincitori – Di Maio e Salvini – a rivendicare per sé l’incarico da premier.
E che induce il segretario dimissionario (ma non troppo) di un Pd oggi ridotto a terzo polo, ma non assolto dalle proprie responsabilità, a blindare una linea di opposizione "senza se e senza ma" come il M5S o la Lega del 2013-17. Per questa via, però, si tornerebbe presto e confusamente alle urne. Può darsi che accada. Ma non sarebbe un bene per alcuno, e sancirebbe un’impotenza. E non del presidente della Repubblica-arbitro, ma di giocatori senza gioco, senza visione e senza generosità. Incuranti del vero campionato, che l’Italia può e deve vincere in Europa e non fuori da essa. Per questo può anche darsi che non accada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







