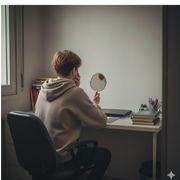Chiesa domestica, cosa significa e qual è il suo futuro?
di Redazione
Secondo i teologi Paolo Carrara e Francesco Pesce «l’enfasi sulla famiglia chiesa domestica va di pari passo con un crescente senso di lontananza reciprocamente percepito tra Chiesa e famiglie».
«L’enfasi sulla famiglia chiesa domestica va di pari passo con un crescente senso di lontananza reciprocamente percepito tra Chiesa e famiglie: se da una parte si constata che «da qualche tempo sono sparite le famiglie a messa», dall’altra le preoccupazioni pastorali non sembrano incrociare i nodi e le sfide della vita delle famiglie. Il linguaggio della predicazione e le attenzioni pastorali, a esempio, sono colti come incapaci di “mordere” la realtà della vita familiare; anche le consuetudini, gli stili e gli orari sono considerati come non più in sintonia con i ritmi e le dinamiche della vita quotidiana di una famiglia. In altre parole, la Chiesa è percepita poco domestica, poco familiare». Lo scrivono Paolo Carrara e Francesco Pesce nell’introduzione al libro “Per una Chiesa che sa di casa. Dalla famiglia chiesa domestica a una Chiesa più familiare” (San Paolo). Tanti spunti originali e stimolanti su una questione che interroga la Chiesa fin dal Vaticano II. Cosa significa concretamente l’espressione Chiesa domestica? Come innestare l’amore della famiglia in una pastorale missionaria? Qual è il vissuto delle famiglie in una prospettiva di fede? E poi si parla della collaborazione delle famiglie nella pastorale, della spiritualità della coppia, delle conseguenze sociali del rinnovamento ecclesiale in chiave familiare. Proprio alla luce dell’obiettivo di costruire una Chiesa più sinodale – concludono gli autori - «non è possibile per la Chiesa e la teologia tralasciare l’ascolto delle famiglie nei loro vissuti: le loro “domande ci aiutano a domandarci”, i loro “interrogativi c’interrogano”». Pubblichiamo qui alcuni stralci della prefazione di Gilles Routhier dell’Université Laval nel Québec, in Canada, docente di teologia ed ecclesiologia.
---------------------------------------------------------
Se la Chiesa si fa vicina alle famiglie, fa strada con loro, è a motivo del fatto che, come insegna l’inizio della costituzione Gaudium et spes, «nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore» dei discepoli di Cristo, quindi non in vista di altro o di un altro progetto (che sia la difesa di una concezione del matrimonio o della regolazione delle nascite). La Chiesa è chiamata a farlo con benevolenza, per sostenere le famiglie affinché siano comunità di condivisione, di rispetto, di attenzione, di crescita e di solidarietà; in breve, comunità di alleanza. E ciò alla sequela del Buon Pastore che dichiarava «sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Questo sta al primo posto. Certamente e per la stessa ragione, la Chiesa può intervenire in modo da metter in guardia contro ciò che fa morire, ma ciò che è più importante deve stare al primo posto (…). La questione di partenza non è dunque come attrezzare la famiglia affinché favorisca la fioritura della vita cristiana e permetta l’allargamento della Chiesa, ma un servizio in pura perdita, un vero dono alla famiglia. Certamente, la Chiesa, nel sostenere le famiglie, le chiama anche a essere comunità di fede, convinta che rimanere nell’amore di Dio faccia vivere (Gv 15). Non bisogna allora minimizzare l’importanza della famiglia nell’educazione alla fede e nella socializzazione religiosa.
La Chiesa come una famiglia? Cosa dobbiamo comprendere?
Anzitutto, ricordiamo che la famiglia ha una forma organizzativa elementare e favorisce relazioni immediate e informali. Questo è senza dubbio l’elemento principale. Chi vuole organizzare la Chiesa in piccole comunità (maisonnées) e chi vuol fare della famiglia una Chiesa domestica – modello questo che tende a diffondersi sempre di più, soprattutto negli ultimi anni – pretende di basarsi su un modello che si ritiene ispirato al Nuovo Testamento, la Chiesa domestica. Ritenendo, come cantano nell’opera rock Notre-Dame de Paris, che “il tempo delle cattedrali è finito” – così anche il tempo della parrocchia e dell’assemblea domenicale in un tempio che raccolga tutti gli abitanti di un luogo – il modello della Chiesa domestica viene sempre più proposto come soluzione. In effetti, si dice che la pandemia abbia dato un forte credito a questo modello chiedendo di coltivare la religione in famiglia, cosicché, d’ora in poi, il radunarsi cristiano dovrebbe svolgersi nella Chiesa domestica, un modello che avrebbe preceduto la comparsa delle assemblee nella basilica, le quali sarebbero apparse solo dopo il riconoscimento della Chiesa da parte di Costantino. Si tratterebbe di riscoprire una forma più antica, in grado di rispondere meglio alle esigenze dei fedeli in un contesto missionario, dopo il crollo della Chiesa di massa che ha caratterizzato gli ultimi secoli in Occidente. Inoltre, questa forma ecclesiale sarebbe più in sintonia con lo spirito del tempo e consentirebbe incontri a misura d’uomo.
Tuttavia, uno studio storico-sociale approfondito del ruolo della famiglia e delle piccole comunità (maisonées) nella diffusione del cristianesimo nei primi secoli ha dimostrato che i termini “piccola comunità” (maisonnée) e “famiglia” si riferiscono a realtà diverse da quanto questi termini indicano oggi in Occidente. I cristiani che si riunivano in casa di qualcuno non erano necessariamente un gruppo di persone con le stesse affinità o appartenenti allo stesso gruppo sociale. La piccola comunità (maisonnée) in questione spesso comprendeva tutti i cristiani della zona. Si riunivano – potevano essere anche 40-50 – in un luogo messo a disposizione dei fratelli da un cristiano (un mecenate, dato che si trattava di un sistema di patronato) che aveva beni sufficienti a fornire un luogo di ritrovo abbastanza grande per tutti i membri della Chiesa che appartenevano a classi sociali diverse. L’appartenenza a una piccola comunità (maisonnée) apriva un’ampia rete di relazioni e nuovi convertiti si aggiungevano alle comunità. Se la piccola comunità (maisonnée) era l’unità di base per l’insediamento del cristianesimo in città, la piccola comunità (maisonnée), che poteva includere i genitori e i loro figli, i fratelli e le sorelle, i nonni, gli schiavi, i dipendenti, i clienti e talvolta i partner commerciali, non era l’unico modello per la Chiesa. Già a quell’epoca, la Chiesa era in possesso di alcuni luoghi di culto, come testimonia l’Editto di Tolleranza di Galerio. Inoltre, erano presenti predicazioni nelle sinagoghe e nelle piazze, nei crocicchi e nelle strade.
La chiesa-casa non fu quindi l’unico modello di sviluppo della Chiesa, ma l’unica soluzione talvolta praticabile per riunire i fratelli diì una città. In relazione a una o un’altra piccola comunità (maisonnée) è anche probabile che il movimento cristiano abbia beneficiato di un’altra modalità di relazione sociale nella forma di associazioni volontarie, piccoli gruppi di amici, vicini o lavoratori associati. A Corinto, ad esempio, Paolo, beneficiando dei rapporti di vicinato del quartiere di etnia ebraica, ebbe i primi contatti con gli
artigiani e i loro clienti. Lì incontrò Priscilla e Aquila e condivise il loro mestiere di fabbricanti di tende, perché anche lui era un fabbricante di tende (At 18,2-4); con divise anche la loro casa. Il suo lavoro di tessitore gli aprì tutta una rete di contatti e fu un mezzo di evangelizzazione (1Tess 2,9). Infine, la diffusione del cristianesimo nell’Impero ha beneficiato delle strade romane, dei cantoni dell’esercito e dei gruppi di funzionari.
Questa breve panoramica ci avverte del rischio insito nell’uso della storia per legittimare o giustificare le scelte nella situazione attuale, conducendoci a proiettare nel passato le nostre attuali rappresentazioni della famiglia o del nucleo familiare, senza tener conto delle differenze di contesto. Se la storia è “maestra di vita”, come diceva Giovanni XXIII, è
anche vero che raramente una situazione storica si ripete identica. La storia può aiutarci a riflettere, ma non offre una soluzione pronta per la situazione attuale. Questo excursus ci mette anche in guardia dal pericolo di confondere “piccola comunità” (maisonnée) e “famiglia”, considerando queste due realtà come equivalenti. Una cosa è “la Chiesa in casa”, per usare l’espressione di Marie-France Baslez, e un’altra è pensare alla famiglia (soprattutto quella nucleare) come a una Chiesa in miniatura. In terzo luogo, occorre ricordare il modello di socialità promosso dalla piccola comunità (maisonée): relazioni brevi e spesso informali, relazioni di vicinato o professionali, relazioni brevi specifiche di gruppi, associazioni o reti, relazioni egualitarie che permettono la fraternità e la solidarietà (…)
Il percorso tortuoso della nozione di Chiesa domestica
È stato il Vaticano II a reintrodurre la nozione di Chiesa domestica, anche se incidentalmente. Durante la discussione dello schema De Ecclesia, questa aggiunta non ha suscitato alcun dibattito o discussione. Sembra essere stata data per scontata. Probabilmente non si pensava che l’inserimento di questa nozione fosse chiamato a un tale destino e che sarebbe stato ripreso con tanta creatività. Se vogliamo interpretare correttamente questo concetto, dobbiamo innanzitutto tornare al testo stesso. Cosa dice e cosa ci insegna nel contesto? Da questa missione [degli sposi cristiani], infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i quali per la grazia dello Spirito Santo diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica (velut Ecclesia domestica)6, i genitori devono essere per i loro figli i primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno, quella sacra in modo speciale (LG 11). Innanzitutto, va notato che il passo del Vaticano II che fa riferimento alla nozione di Chiesa domestica (LG 11) non tratta direttamente della famiglia (questione che sarà affrontata nel primo capitolo della seconda parte della Gaudium et spes), né di un modo concreto o ideale di realizzare la Chiesa. Inoltre, anche se era stato chiesto di allegare a questa locuzione una nota che facesse riferimento a una testimonianza patristica sulla famiglia come ecclesiola, il suggerimento non è stato accolto (…)
Da un’analogia sulla fecondità della Chiesa e della famiglia a un’identità: la Chiesa è una Chiesa domestica
Tuttavia, questa nozione sarà sviluppata nel magistero dei papi a partire da Paolo VI. Questa ripresa, nella Evangelii nuntiandi (1975), modifica leggermente la nozione di Chiesa domestica. In primo luogo, viene abbandonata l’analogia tra la fecondità dell’una e dell’altra. Nella famiglia “dovrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa intera”. In breve, la famiglia è una Chiesa in miniatura e offre una sintesi o un concentrato della Chiesa, poiché ne contiene tutti gli aspetti. Poi, volendo insistere sull’evangelizzazione, come era lo scopo dell’esortazione, si lascia cadere il tema della nascita dei cittadini (…). Con spostamenti successivi, siamo passati dalla famiglia come Chiesa domestica (velut Ecclesia domestica) alla famiglia identificata con la Chiesa domestica e presentata come un modello di Chiesa che contiene in sé i vari aspetti o funzioni della vita della Chiesa. Siamo passati da una considerazione della fecondità della famiglia a una considerazione della famiglia per la crescita della Chiesa. Questi diversi passaggi ci portano a pensare che la Chiesa non si costruisce a partire dalle parrocchie, ma dalle famiglie. L’accento non è più sul tipo di socialità permessa dalla Chiesa nelle case e che può ispirare lo sviluppo di una Chiesa più fraterna, ma sul munus Ecclesiae della famiglia.
Infine, per sfocare ulteriormente l’orizzonte – qualora fosse necessario –, negli ultimi tempi si è passati, senza farci caso, dalla nozione di Chiesa domestica o di famiglia come Chiesa alla nozione di Chiesa come famiglia di Dio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA