Stuart Bage è arrivato un paio di anni fa a Firenze come manager delle Risorse umane per dirigere, dal quartiere generale italiano, la divisione "Oil and Gas" di General Electric. «Il nostro obiettivo è utilizzare i talenti delle Regioni in cui operiamo per massimizzare le risorse nel mondo», premette dalla hall di un albergo milanese dove partecipa a un convegno. «Vuole sapere la prima prova di Diversity Management che ho dovuto affondare? Armonizzare gli orari: in Italia si comincia dopo ma si finisce più tardi. Quando devi mettere insieme manager di 40 diverse nazionalità, che provengono dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, dall’India e dall’Angola, qui da voi il giorno si fa più lungo».Le "diversità" nelle imprese del Terzo millennio non sono certo solo questione di orologio. La globalizzazione dei mercati e le grandi migrazioni hanno ridisegnato nei Paesi occidentali il tessuto sociale e contemporaneamente la fisionomia delle aziende. L’Italia, con i suoi 4 milioni di stranieri, attraversa oggi forse la fase più acuta del cambiamento. E molte aziende – anticipando spesso i policy makers – hanno cominciato, con il pragmatismo che le caratterizza, a interrogarsi su come valorizzare al meglio le diversità di culture, tradizioni, esperienze della loro "forza lavoro" per trasformare la multiculturalità in un valore aggiunto.L’idea di gestire al meglio le diversità nasce negli anni Novanta negli Usa. Sono le società statunitensi – per storia, cultura, proiezione sui mercati internazionali – le prime a interrogarsi sulla possibilità di valorizzare talenti interni che appartengono a culture differenti. Con una consapevolezza di fondo, maturata sul campo e certificata dai bilanci aziendali: un’azienda "multiculturale" possiede molta più ricchezza, in termini di potenziale umano, di un’azienda "a cultura unica". E questo presupposto si rivela ancor più stringente in un’economia globalizzata e interconnessa come quella dell’era digitale. L’obiettivo del Diversity Management è dunque quello di monitorare, comprendere e valorizzare le risorse in modo che non solo tutti abbiano le stesse opportunità, ma che il risultato finale – detto olisticamente – sia maggiore della somma delle parti. Nella "Vecchia Europa", una quindicina di anni fa, anche il top management di British Telecom ha cominciato seriamente a guardarsi intorno. A vedere quello che stava succedendo all’interno del gruppo e, più in generale, nella società britannica. Puntando l’obiettivo sulle caratteristiche socio-demografiche del Paese, sono balzati agli occhi alcuni dati che non potevano essere trascurati: su base familiare le entrate medie annue dei cinesi, degli africani, degli asiatici e degli indiani risultavano superiori rispetto a quelle della popolazione bianca. British Telecom si è "accorta" poi che una persona su quattro nel Regno Unito era disabile, che le donne gestivano la metà delle piccole imprese del Paese e che Internet aveva raggiunto un tasso di penetrazione altissimo. La realtà aziendale, insomma, di pari passo con il contesto in cui era inserita, aveva cambiato completamente fisionomia. Diventando più complessa, per certi versi esplosiva, e per altri così piena di potenzialità inespresse che sarebbe stato uno spreco non cercare di capirle e gestirle in maniera strutturata. Nel 1995 il colosso delle telecomunicazioni ha deciso allora di inaugurare una funzione aziendale nuova, un dipartimento composto da un piccolo gruppo di lavoro inserito nel team dedicato alla gestione delle Risorse Umane che da allora si occupa di "Diversity Management".La prima iniziativa è stata quella di predisporre un programma educativo di sensibilizzazione alla diversità della durata di un giorno e rivolto a tutti i manager. In 14 anni lo hanno frequentato in migliaia. Contemporaneamente, il gruppo ha scelto di introdurre una valutazione delle prestazioni basata anche sulla conformità alle politiche di "Diversity Management" e alla promozione di orari di lavoro maggiormente flessibili, capaci di intercettare specifiche esigenze culturali.In Italia si cominciano a muovere i primi passi. Anche le aziende italiane, soprattutto quelle internazionalizzate, diventano sempre più multietniche. Per l’aumento della popolazione immigrata in Italia, certo, ma anche per la maggior proiezione all’estero. Uno studio della società di ricerca "Wise Growth", incentrato sulla presenza straniera nei Cda delle società quotate, rileva come su 361 consiglieri delle 30 aziende considerate ben 47 sono stranieri, con un’incidenza del 13%. Estendendo la rilevazione alla prima linea dei manager operativi, la tendenza alla multiculturalità si mostra addirittura più marcata. La media di dirigenti stranieri raggiunge infatti il 31,1% e, in casa Enel, lambisce il 55%: su 1.130 manager 621 non sono italiani e la maggior parte sono impiegati nelle sedi estere del gruppo. In questa prospettiva vanno lette anche le percentuali relative a De Longhi (il 45,5% dei manager sono stranieri), Pirelli (28,4%), Finmeccanica (26%), Indesit (23%), Eni (14,6%) e Brembo (12,5%).Molte di queste aziende hanno già affidato alla funzione Risorse Umane la definizione delle linee guida e la gestione della multiculturalità che, inesorabilmente, dai piani più alti si allarga a macchia d’olio, fra operai ed impiegati, fino ai livelli base.






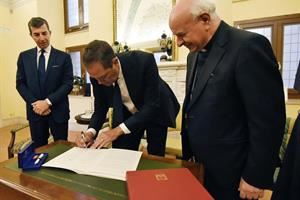
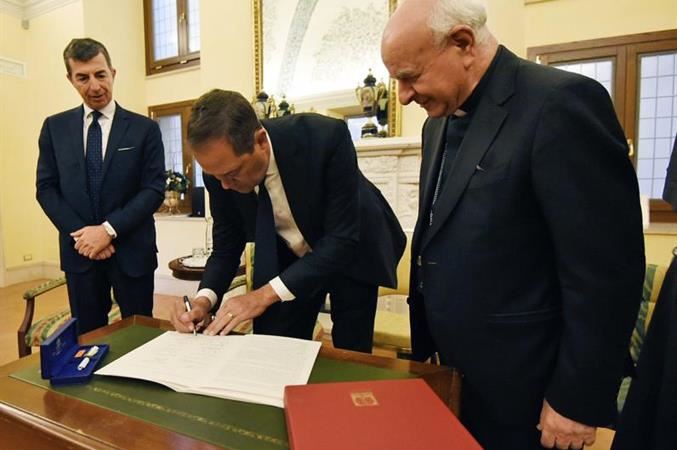




.jpg?dt=1714129714088&Width=300)
.jpg?dt=1714129714088&width=677)





