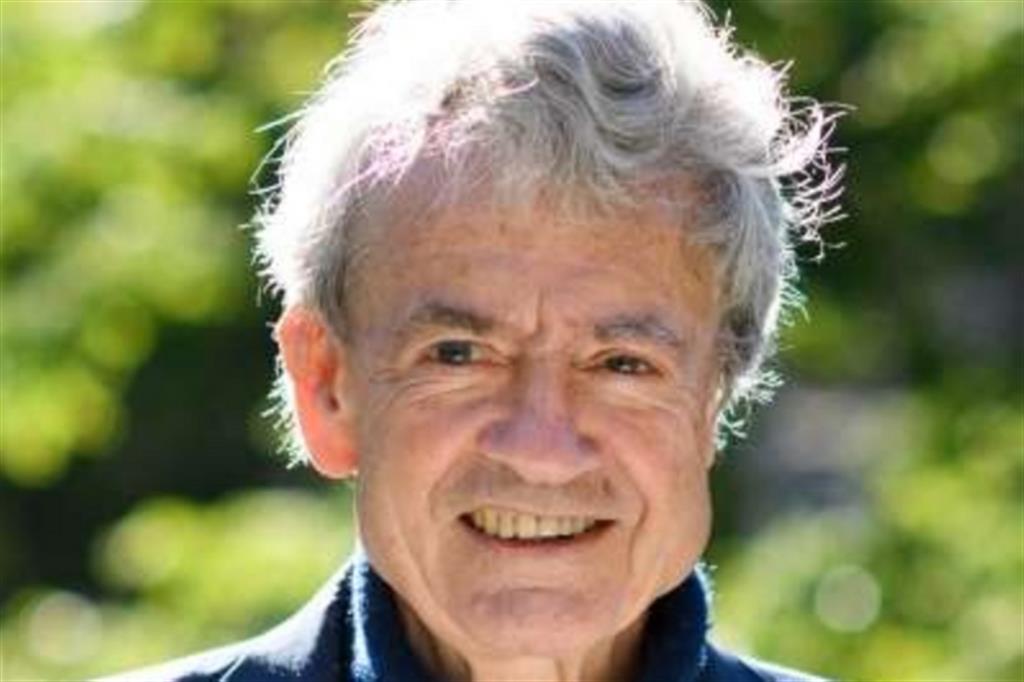
Michael Cook è uno studioso che non conosce mezze misure. Ha condensato la storia universale in meno di quattrocento pagine (il suo A Brief History of the Human Race è uscito nel 2004) e ne ha dedicate oltre settecento all’analisi di un singolo precetto islamico, quello che impone al credente di impedire che qualcun altro cada in errore. Insieme conAncient Religions, Modern Politics (“Antiche religioni e politica moderna”, 2014), che mette a confronto l’evoluzione dell’islam, dell’induismo e del cattolicesimo latinoamericano, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought (“Comandare ciò che è giusto e proibire ciò che è sbagliato nel pensiero islamico”, 2000) rappresenta uno dei contributi più rilevanti di Cook, professore di cultura del Vicino Oriente a Princeton, nel New Jersey, e curatore, tra l’altro, dell’imponente New Cambridge History of Islam. «Da qualsiasi prospettiva lo si osservi, l’islam non può essere considerato qualcosa di unico rispetto alle altre religioni. Nello stesso tempo, è una religione diversa da tutte le altre», sintetizza Cook, che per il complesso delle sue ricerche ha ricevuto ieri a Berna uno dei premi attribuiti annualmente dalla Fondazione Balzan.
Non unico, eppure differente: perché?
Prendiamo il caso che ho cercato di approfondire in Commanding Right and Forbidding Wrong. Di per sé, si tratta di un principio che ritroviamo anche in altre tradizioni, compresa quella cristiana, dove la cosiddetta “correzione fraterna” è contemplata e addirittura raccomandata. Solo nell’islam, però, l’iniziativa può spingersi fino alla coercizione fisica e all’impiego della violenza.
E questo che cosa significa?
Che nell’islam sono compresenti aspetti non estranei alle altre religioni, ma che soltanto qui si combinano tra loro fino a risultare indissolubili l’uno dall’altro. È la ragione per cui, contrariamente a quanto si sente ripetere, nell’islam continua ad agire una forza centripeta molto più forte di qualsiasi eventuale spinta centrifuga di tipo regionale.
Sta dicendo che esiste un solo islam?
Nella sostanza sì, è così, e non soltanto perché esperienze pure storicamente interessanti, prima fra tutte quella del sufismo, sono ormai prive di reale consistenza. Il punto è che, fin dall’inizio, l’islam è dotato di un centro, che possiamo individuare nella penisola arabica, rispetto al quale le altre declinazioni locali sono consapevoli di trovarsi in una condizione periferica. Già nel Medioevo, un musulmano della Spagna, dell’Asia centrale o del Nordafrica sapeva di occupare una posizione letteralmente eccentrica, lontana dal cuore dell’islam.
Vale ancora oggi?
A maggior ragione. La facilità e la globalità dei mezzi di comunicazione costituiscono un fattore determinante per la coesione dell’islam, anche nella direzione di quello che, in senso stretto, possiamo definire il fondamentalismo musulmano.
Lei intende il termine in un’accezione particolare.
Credo che sia necessario operare una distinzione tra fondamentalismo e islamismo. Il primo deriva, ancora una volta, da una tendenza comune a diverse religioni. La nozione di “fondamentalismo” viene introdotta attorno al 1920 dalle congregazioni battiste statunitensi, che indicano con questa espressione la necessità di tornare al fon- damento della fede e alla purezza del messaggio evangelico. In forma più o meno evidente, una componente fondamentalista si può riscontrare in molte confessioni religiose.
Ma l’islam fa di nuovo eccezione?
Sì, perché questo ritorno alle fonti viene a rendere disponibile materiale utile al progetto dell’islamismo, che pure è un’ideologia politica abbastanza recente. Non voglio affermare che la lettura del Corano conduca necessariamente all’islamismo, ma è indubbio che un islamista trovi quel che gli serve nel Corano.
A cominciare dalla legittimità della guerra?
Il jihad è un concetto tipicamente musulmano e Muhammad è l’unico fondatore di religioni che guidi personalmente una campagna militare distinguendosi in battaglia. Anche per questo motivo risulta molto difficile emettere un giudizio univoco sulla composizione di formazioni come al-Qaeda o il Daesh. La mia impressione è che in alcuni contesti, come nelle banlieues francesi, la radicalizzazione possa derivare da fenomeni di esclusione e risentimento sociale. Nondimeno, nei ranghi del Califfato militano anche combattenti persuasi di compiere il loro dovere di buoni musulmani.
Un altro ritorno alle origini?
Nella sua configurazione iniziale l’islam si concepisce come Stato territoriale: a questo mira, appunto, l’unificazione delle tribù arabe promossa da Muhammad anche attraverso le guerre di conquista. Meno delineata, in questa prima fase, è la concezione di una società islamica, della quale si intravedono comunque le caratteristiche. La solidarietà e l’uguaglianza sono, fin dal principio, valori costitutivi di una fratellanza che dal nostro punto di vista fatichiamo a considerare propriamente universale. Dalla umma dei credenti sono escluse le donne e sono esclusi gli schiavi, per esempio. Ne fanno parte solo i maschi adulti.
Una visione di questo genere è conciliabile con la modernità?
Sono un storico, mi sforzo di conoscere il passato e, purtroppo, non sono in grado di prevedere il futuro. Mi limito a constatare che questa è una delle sfide più impegnative che ci attendono nei prossimi anni, specie per quanto riguarda l’Europa. Molto si gioca nell’equilibrio tra migrazione e integrazione: un attenuarsi dei flussi di ingresso potrebbe favorire un processo analogo a quello sperimentato dal cattolicesimo nel secolo scorso.
In che senso?
Le istanze della modernità sono state recepite con una certa lentezza dalla Chiesa, ma questo non ha impedito che, alla fine, venisse felicemente risolta la contraddizione fra l’essere credente e l’essere cittadino del proprio tempo. Qualcosa di simile potrebbe verificarsi all’interno dell’islam o, almeno, nelle comunità di immigrati musulma- ni nei Paesi occidentali.
Ma le religioni non erano destinate a scomparire dalla scena pubblica?
Questa era l’ipotesi predominante qualche decennio fa. Non dico che fosse una scommessa azzardata, ma di sicuro aveva il limite di concentrarsi quasi esclusivamente sulla parte economicamente più sviluppata del pianeta: l’Europa, gli Stati Uniti, il Giappone. Tutti territori nei quali la secolarizzazione si è effettivamente affermata. Nel resto del mondo, invece, è andata molto diversamente. L’esuberanza dell’islam rappresenta il caso più vistoso, ma ci sono questioni ancora del tutto inesplorate. Nello specifico, non siamo in grado di valutare quale potrebbe essere la situazione religiosa in Cina qualora il regime decidesse di garantire una vera libertà di culto. Il futuro rimane imprevedibile, insisto, eppure dal passato qualcosa abbiamo imparato.
Che cosa?
A essere più umili nei confronti delle altre culture e a diffidare dei nostri pregiudizi occidentali. Non è un’acquisizione da poco, glielo assicuro.

















