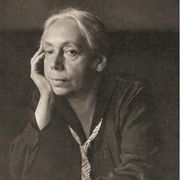L'anima ebraica del Padre nostro
Il testo, riportato solo da Luca e Matteo ma non da Paolo, ha forti affinità con il Qaddish e le preghiere coniate dai maestri nelle sinagoghe e poi trascritte

Dal primo numero di “Avinu”, nuova rivista “per il dialogo ebraicocristiano” diretta da Massimo Giuliani e pubblicata da
Castelvecchi a cadenza quadrimestrale, anticipiamo alcune pagine dell’ampio contributo di Milena Beux Jager dal titolo La “teologia ebraica” del Padre Nostro che sei nei cieli. Tra le altre firme del numero, dedicato in particolare al post 7 ottobre 2023: Alon Goshen-Gottstein, Noemi Di Segni, Ambrogio Spreafico, Davide Assael, Alessio Aringoli, Riccardo Burigana, Riccardo Shmuel Di Segni, Marco Cassuto Morselli, Francesca Baldini e Guido Guastalla.
Dai pochi documenti scritti in cui compaiono formule o preghiere strutturate correnti nel I secolo e.v., due sono le principali forme liturgiche attestate, al di fuori dei salmi e dello Shema‘ Israel: il Qaddish e la Tefillah. Il primo, derivato dalla qedushah, la santificazione del Nome divino, era un ampliamento di quest’ultima, in particolare con l’aggiunta dell’esaltazione della “Torah di verità”, quando era recitato durante lo studio biblico. Il suo nucleo, oltre a interrompere le parti dello studio o del culto, concludeva il sermone aggadico (interpretazione narrativa) ed era verosimilmente già corrente nel periodo del secondo Tempio: « Il grande Nome sia magnificato e santificato… Domini il Regno… Il grande Nome sia benedetto nei secoli dei secoli… ». Nella sua forma più antica, il Qaddish era probabilmente di origine palestinese; ma dopo il 70 e.v., con la distruzione del Tempio e la diaspora, le preghiere subirono un ulteriore sviluppo, adattandosi all’esi- genza del momento e del luogo, e dalla tradizione orale passarono a una trascrizione. L’unione della santificazione del Nome divino, l’esaltazione della Torah come “insegnamento di verità” in una delle forme più antiche della qedushah e il fatto che essa si trovi, più tardi, sempre in contesto scolastico fanno supporre che già originariamente la sua recitazione fosse una prassi usuale dopo le lezioni e le interpretazioni dei passi biblici. Questo potrebbe essere confermato dai Vangeli [...] La particolarità delle preghiere recitate in sinagoga (durante il culto pubblico) e/o nella sala di studio (come culto privato) consisteva nel fatto che ogni maestro di una scuola di interpretazione o di un gruppo religioso ufficiale (farisei, sadducei, componenti le scuole citate) poteva redigere una preghiera o aggiungere qualcosa a una già esistente, secondo l’esigenza della comunità, il periodo storico e la situazione politica attuali. I maestri erano, in pratica, liberi di modificare le preghiere o di crearne di nuove secondo l’uso, la situazione e la funzione, e altri potevano decidere di inserire le novità nella liturgia vigente, rendendole, così, preghiere fisse. La preghiera di Gesù si presenta solo in due scritti neotestamentari, i Vangeli di Matteo e di Luca, in due versioni. Nessun altro autore la riporta o vi fa cenno, compreso l’apostolo Paolo, che testimonia, invece, di una corrente tradizione sull’istituzione della Santa Cena (1Cor 11); bisognerà attendere il II secolo per ritrovarne una recensione, nella sua versione matteana, nel primo testo di ordinamento della proto-chiesa, la Didaché, abbreviazione di Didaché tôn dodeka apostolon, ossia Dottrina dei dodici apostoli. Il Padre Nostro ha tutte le caratteristiche, finora elencate, di una preghiera ebraica e costituisce un documento determinante per la ricerca sull’antica liturgia ebraica del I secolo, poiché è l’unica preghiera, a nostra conoscenza, interamente scritta contenente il binomio santificazione del Nome/Regno di Dio, concetti fondamentali di quell’attesa messianica che caratterizza il periodo compreso tra la rivolta dei Maccabei (165 a.e.v.) e quella di Bar Kochba, e che sia stata trascritta per intero, sebbene in greco, prima del II secolo della nostra era. Il Padre Nostro è l’unica preghiera finora conosciuta, risalente al periodo del secondo Tempio, trascritta per intero, che contenga il binomio santificazione del Nome divino/ Regno di Dio e che derivi da un contesto scolastico. Esso è molto simile nella forma e nel contenuto a diversi schemi di preghiere contemporanee, documentati nella Bibbia e nella letteratura ebraica extra- biblica. Con quest’ultima esso condivide l’orientamento apocalittico, tipico di certi ambienti influenzati dall’attesa del Regno di Dio. Alcuni elementi, come l’uso di alternative al Nome divino (Padre) e il riferimento alla volontà di Dio, ne suggeriscono l’origine in ambiente scolastico, nella casa di studio della Torah, come preghiera privata (non per il culto pubblico). Il fatto che solo Matteo e Luca riportino la preghiera di Gesù e che la situino in un contesto messianico, mentre essa è assente da testi presumibilmente più antichi (Marco e Paolo), farebbe supporre che la versione di Matteo sia una rielaborazione di una versione più antica e forse originale trasmessa da Luca, e reinterpretata per la situazione della diaspora dopo gli avvenimenti del 66-70. In questo periodo, come testimoniato da altre fonti contemporanee, all’interno dell’ebraismo si è sentita l’impellente necessità di riordinare e trascrivere la tradizione, anche quella liturgica, di fissarla e di dare a quest’ultima un orientamento messianico. Sorge spontanea una domanda: perché il Padre Nostro è diventato la preghiera cristiana per eccellenza? Possiamo solo fare delle supposizioni, gettando uno sguardo alla letteratura proto-cristiana. Tale testo entra a far parte della liturgia cristiana con il primo ordinamento protocristiano della Didaché, risalente alla prima metà del II secolo. Là esso è inserito tra il rito del battesimo e quello dell’eucaristia. Il rito di iniziazione comprendeva due complessi di rituali: a) catechismo, digiuno e celebrazione del battesimo; b) alla fine il culto eucaristico. Il Padre Nostro che il battezzato recitava con la comunità collegava i due rituali, e questo potrebbe essere un indizio che la prassi ebraica di separare due rubriche nello studio della Torah o nel culto sinagogale era ancora in vigore nelle comunità proto-cristiane. È lecito supporre che queste abbiano, a ragione, adottato la preghiera del loro maestro, mentre le comunità ebraiche abbiano adottato il Qaddish. Tutto ciò rimane nell’ambito delle supposizioni ma un fatto è certo: anche nella preghiera l’origine ebraica della comunità di Gesù è innegabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA