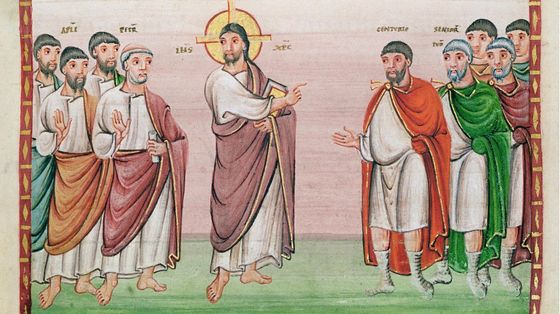Come costruire luoghi fondati sull'idea d'inclusione
Il geografo Vanolo: «Un altro tipo di città, aperta alle differenze, dove è possibile ripensare l’incontro con autismo e neurodiversità e sperimentare altri ritmi, relazioni e modi di vivere»

«Proviamo a immaginare un altro tipo di città, aperta alla differenza. Uno spazio dove ripensare l’incontro con le neurodiversità e dove sperimentare altri ritmi, relazioni, e modi di vivere. Una città così, orgogliosamente autistica, avrebbe molto da offrire a chiunque». Con queste parole stampate in copertina si apre La città autistica (Einaudi, pagine 114, euro 12,00) di Alberto Vanolo, professore di geografia politica ed economica all’Università di Torino, dove si occupa di geografia urbana e culturale. Quello di Vanolo è un «piccolo testo che intende sviluppare una riflessione sul rapporto fra autismo e citta », provando a immaginare modi diversi di intendere le diversità, incluse quelle neurologiche, anche al di là del linguaggio delle categorie, delle diagnosi e delle disabilità. Vanolo guarda in senso più ampio agli spazi pubblici e cerca di alzare l’asticella della sensibilizzazione culturale: uno dei temi centrali del libro infatti è che «autistico» non va inteso in senso peggiorativo e che la condizione di neurodiversità può offrire molto per progettare città più vivibili e aperte, più semplici e sostenibili, per tutti e tutte.
«La mia impressione – spiega Vanolo – è che ci sia più sensibilità e percezione di un tempo, ma c’è ancora spazio per crescere». Per farlo, ci racconta, si dovrebbe partire dal linguaggio: «Esiste un ampio dibattito su neurodivergenza e neurodiversità, ma trovo questo tema sia poco diffuso nel dibattito pubblico, che spesso utilizza ancora un linguaggio poco attento ai modi che abbiamo per interpretare l’autismo. Penso che le linee guida siano ottime per orientarsi nel mondo, ma non esauriscono il discorso. Per esempio credo che occorrerebbe parlare di autismi al plurale, e non al singolare, non solo perché le persone con una diagnosi sono differenti le une dalle altre, ma perché il nostro sguardo sull’autismo e in trasformazione, nel tempo e nello spazio. Le stesse definizioni mediche sono in costante evoluzione». Vanolo nel libro fa un parallelismo con la letteratura queer, che in questo senso ha prodotto varietà e sensibilità di linguaggio: «Questo – dice – nel mondo della neurodiversità non è ancora stato fatto ed è un tema culturale. C’è una questione di fondo ed è la tendenza a inserire nella categoria autismo cose differenti tra loro come bisogni, necessità, richieste. Immagino – continua – ci voglia tempo per codificare un certo linguaggio condiviso: da pochissimo lo standard per esempio è “persona autistica” e non “persona con autismo”. Mi sta bene, ma guardiamo le sfuma-ture: persona autistica potrebbe suggerire che il tratto più importante sia l’autismo, invece per quella che chiamiamo intersezionalità, siamo tante cose». Vanolo parte da una vicenda personale e da lì sviluppa la possibilità di intraprendere altri percorsi: « Mi sono accorto con mio figlio che l’offerta pubblica è preziosa, ma al tempo stesso può essere anche problematica nel tentativo di trovare formule universali, punteggi, categorie. Questo aspetto fissa uno standard, per cui bisogna capire se vivere per ridurre un gap o sperimentare percorsi laterali. Come geografo è un mantra intraprendere percorsi differenti: per esempio, non è che tutte le città devono svilupparsi come città del turismo se non ne hanno le caratteristiche. Faccio un altro esempio: un concetto come quello di autonomia piace a tutti e tutte, ma con una provocazione posso dire che se mi si rom-pe il computer lo faccio riparare, quindi nessuno può dirsi completamente autonomo. Dobbiamo tenere contro che la disabilità può capitare a chiunque, può essere anche una condizione transitoria, può capitare invecchiando, per questo è necessario pensare nel mondo più ampio possibile».
Questo concetto introduce il rapporto tra autismo e città a partire dal termine inclusività, «che potrebbe assumere sfumature anche problematiche – ci spiega Vanolo – poiché suggerisce l’idea di far parte di una norma. Per questo – continua – ho trovato ispirazione nella letteratura queer, che rivendica il diritto alla differenza. Ci sono diversità che se si fa un lavoro di decolonizzazione dello sguardo, smettono di essere un problema. La costruzione dello spazio urbano travalica infatti l’esperienza quotidiana e arriva fino alle radici dell’inconscio politico: immaginare differenti tipi di citta e un modo per immaginare differenti forme di società, più o meno giuste o ingiuste, come ci insegna la tradizione della letteratura utopica (tutte le grandi utopie classiche sono legate a specifiche citta immaginarie) o di quella fantascientifica. Cosi , ragionare sulla citta autistica e un modo di immaginare una società dove l’autismo sia vissuto e immaginato in maniera differente.
Per fare un esempio, la vita delle persone autistiche e dei loro familiari risulta assai differente a seconda del contesto geografico e delle sue caratteristiche sociali, politiche, culturali e ambientali. O ancora: le persone autistiche spesso percepiscono gli stimoli sensoriali in maniera peculiare, con specifiche sensibilità rispetto a rumore, luce e odori, per cui l’esperienza dello spazio urbano non e necessariamente la medesima di quelle neurotipiche, ma nemmeno la stessa per tutte le persone autistiche». Vanolo a partire da questi esempi introduce il tema dei diritti, altra parola chiave del libro: «L’idea non è solo avere una buona città, ma avere una voce politica rispetto alla costruzione dello spazio urbano, perché questo ha a che fare con la mia vita, con il tipo di città che voglio vivere e immaginare». In conclusione, un passaggio sul rapporto tra digitale e autismo: «Sui social spesso mi imbatto in persone che fanno discorsi sofisticati sull’autismo. Ci sono per esempio molte forme di attivismo, soprattutto sui forum americani, ma talvolta c’è anche un filone – a mio avviso più problematico – di soluzionismo tecnologico, ovvero l’idea che con qualsiasi App si possa risolvere qualsiasi problema; questo vale anche per l’ambiente e per altri temi. Credo in questi casi le persone siano mosse dalle migliori intenzioni, ma forse con una visione più ingegneristica. Tuttavia, ci sono anche esperienze come semplici mappature che agevolano la sensibilizzazione e favoriscono una maggiore attenzione e divulgazione culturale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA