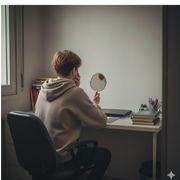Perché la speranza nasce solo nel cuore della famiglia?
di Luciano Moia
Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero laici, famiglia e vita: non esiste al mondo nessun altro sistema di relazioni umane così potente da costruire con la stessa efficacia fiducia, perd

La famiglia è il primo luogo dove si sperimenta la virtù della speranza. Lo sguardo di una madre, lo sguardo di un padre, le buone relazioni generano speranza. Ecco perché il Gubileo delle famiglie che si celebra il prossimo week-end a Roma è in qualche modo il cuore di quest’anno giubilare. Lo racconta Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero laici, famiglia e vita.
Come declinare il tema della speranza in chiave familiare?
Nel documento finale del Sinodo del 2024 vi è una descrizione molto bella della speranza che si annida nella famiglia: «Nonostante le fratture e le sofferenze che le famiglie sperimentano, restano luoghi in cui si apprende a scambiarsi il dono dell’amore, della fiducia, del perdono, della riconciliazione e della comprensione» (DF 35). In fondo, è proprio così. La famiglia è il primo luogo vocato alla speranza, che si genera naturalmente nelle relazioni familiari: quando ci scopriamo figli si genera in noi la certezza di essere stati amati e desiderati; nello sguardo di una madre ogni figlio cerca lo sguardo del padre, e la paternità è essenziale a ciascuno di noi per poterci aprire alla vita, al futuro, alla speranza; è tra fratelli che scopriamo una comune maternità e paternità, che ci lega e genera forze vitali; è nella relazione nonni-nipoti che scopriamo radici lontane che ci trascendono. Nell’intrecciarsi di queste relazioni, la famiglia che accoglie la vita, dice al proprio figlio: “tu sei una promessa, perché in te è scritto il principio della vita”, con le sue domande inesauribili e il suo orizzonte di futuro. Questa ricchezza appartiene in sé al principio famiglia. Per questo è importante che i giovani credano in essa e desiderino costruirne una propria. Non esiste al mondo nessun un altro sistema di relazioni umane così potente, nel quale siano inscritte la speranza e la vita.
Come il Giubileo potrà favorire un clima di rinnovata speranza e di ritrovata fiducia nelle famiglie sempre più fragili e disgregate dei nostri giorni?
Con l’esperienza del perdono. Bisogna parlarne con i giovani e le famiglie, far loro scoprire la grazia di questo dono di un Padre che ci ama, perché quando ti scopri amato e perdonato nella tua fragilità e nei tuoi errori non hai più bisogno di rivendicare, di portare rancore o chiuderti: riesci a rialzare lo sguardo e questo ti dà speranza. Per i cristiani, attraversare la Porta santa è un gesto di fiducia e di abbandono a Dio. E la porta non è solo una soglia fisica che attraversiamo in una Basilica, ma è Cristo nella nostra vita: la Porta che si apre e la Via da percorrere per nutrirci del suo amore, che ci aiuta a riavviare le relazioni con gli altri. Ce lo ricordava sempre Papa Francesco: «la migliore medicina per curare il dolore di una famiglia ferita è il perdono, che permette di guardare avanti con speranza».
Nella Lettera inviata a monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, in occasione del Giubileo 2025 papa Francesco sollecita a ritrovare il senso di fraternità, chiamando in causa l’impegno educativo delle famiglie. Crede che nelle nostre comunità si faccia abbastanza per sostenere questo sforzo da parte dei genitori?
Anzitutto credo che l’educazione dei figli oggigiorno sia una sfida molto più complessa di un tempo: la globalizzazione delle relazioni e il mondo social hanno introdotto dinamiche che ancora ci sfuggono a livello educativo, rendono difficili le relazioni familiari e quelle educative in genere. Servono nuovi approfondimenti da parte della pedagogia, della psicologia familiare e sociale. Penso a tanti comportamenti patologici che si stanno diffondendo tra i giovani e al fatto che tante, troppe famiglie cerchino l’aiuto di specialisti per gestire le proprie relazioni familiari, sia di coppia sia tra genitori e figli. Ciò premesso, è evidente che come adulti siamo in grande difficoltà e le comunità stentano a sostenere i genitori nel compito educativo. Dobbiamo sviluppare nuove competenze, nuove capacità relazionali con i giovani. I ragazzi vanno aiutati a prendere coscienza di sé, delle proprie emozioni, dell’importanza delle relazioni reali, vanno educati ai valori, al rispetto della dignità e della vita umana; devono poter sviluppare un’intelligenza critica di fronte alla realtà e i dispositivi digitali che mettiamo a loro disposizione fin da piccoli non li aiutano a sviluppare quella plasticità cognitiva e intellettiva, che li aiuterebbe anche sul piano emozionale a reagire in maniera costruttiva di fronte alle difficoltà della vita. Credo che il primo passo da compiere nelle nostre comunità sia formare una generazione di adulti più consapevoli e attrezzati a livello educativo per saper avviare i figli alla loro vita.
In che modo le famiglie possono vivere la dimensione spirituale del Giubileo coniugandola, come sottolinea ancora la Lettera, “con gli aspetti fondamentali del vivere sociale”?
Il Giubileo ci invita a dare segni visibili di speranza. Uno di questi può essere l'esperienza di volontariato che le famiglie possono far fare ai propri figli o fare con i propri figli, attivando in tal caso dinamiche fortemente educative. C’è un grandissimo bisogno di dedicarsi agli altri nei giovani. Prendersi cura, sentirsi utili, generare un sorriso quando doni qualcosa di te a un altro è ciò che apre un giovane al senso della propria vita e alla speranza. È ciò che ti fa uscire da te stesso e ti fa scoprire la ricchezza delle relazioni umane. È così che si generano solidarietà e bene comune. Ma è anche così che si creano contesti in cui si può incontrare Cristo, coniugando l’esperienza spirituale con quella della carità. Un ruolo, in questo senso, potrebbero averlo le parrocchie, proponendo attività organizzate di volontariato per le famiglie e i giovani. Sarebbe anche un modo per accompagnare le famiglie nel proprio compito educativo di trasmissione di valori sociali come la fraternità, la solidarietà, la cura dell’altro (cf. Fratelli tutti, 114). Chi fa quest’esperienza ne esce straordinariamente arricchito: toccare con mano la fragilità, la povertà e il limite ci permette di fare i conti con il nostro stesso limite e il nostro bisogno degli altri.
Perché si è avvertita l’esigenza di sottolineare, accanto alle famiglie, il fatto che queste Giornate sono dedicate in modo specifico ai bambini, ai nonni e agli anziani?
Perché la famiglia è un sistema di relazioni in cui si intrecciano generazioni diverse. Non ha alcun senso tenere separati i bambini dai propri genitori o i nonni dai nipoti. L’esperienza spirituale del Giubileo può e deve essere un momento che riunisce la famiglia, che permette alle relazioni ferite di ricostruirsi e alla gioia del perdono e della preghiera di essere condivisa. Il recente Sinodo fa presente il fatto che nella Chiesa si condividono differenze di vocazione, età, sesso, professione, che ci permettono l’incontro con l’altro per maturare a livello personale; le famiglie cristiane, “piccole Chiese domestiche”, sono il primo luogo dove siamo chiamati a vivere questa maturazione. Esse umanizzano le persone attraverso la relazione del “noi” e promuovono le legittime differenze di ciascuno (DF, 35). Bisogna un po’ superare nella Chiesa l’idea che come fedeli battezzati dobbiamo essere etichettati per categorie e vivere separati in compartimenti pastorali autoreferenziali. Avere uno sguardo differente sulla famiglia, che oggi ha bisogno di essere educata e aiutata a rimanere unita, può essere il primo passo.

Nel programma viene proposto, venerdì pomeriggio, un momento dedicato alla gioia in famiglia sull’esempio della famiglia Martin. Quale insegnamento possono trovare le famiglie dei nostri giorni dalla famiglia di santa Teresa di Lisieux?
La famiglia Martin viveva in un’altra epoca, ma ci sono esperienze familiari che non hanno tempo. Luis e Zélie, i genitori di Thérèse, si sono innamorati come capita anche ai giovani di oggi: tra loro ci fu un vero “colpo di fulmine” e dopo soli tre mesi si sono sposati. Non hanno avuto una vita facile: hanno avuto 9 figli, ne hanno persi 4 ancora piccoli e hanno conosciuto la sofferenza del lutto genitoriale; hanno lavorato entrambi tutta la vita cercando di conciliare famiglia e lavoro; hanno fatto l’esperienza della malattia. Ma hanno vissuto la loro quotidianità con fiducia e spirito di abbandono. Il matrimonio per loro era una “salita a due verso il cielo”: dunque, se era salita, non era una discesa senza difficoltà, ma la certezza che dava loro speranza era la méta: il Cielo. Così, per esempio, per me è di grande insegnamento il loro modello educativo: hanno cresciuto i figli con lo sguardo rivolto “dal tetto in su”. Cosa che oggi appare quasi impossibile per noi famiglie, spesso completamente concentrate sul dare ai nostri figli un’educazione scolastica che dia loro possibilità competitive nel mondo del lavoro, dimenticandoci del loro bisogno d Dio e di trovare risposte di senso alla loro sete di eternità. Ma vorrei anche aggiungere che Luis e Zélie sono un esempio di amore coniugale: non parlavano mai male l’uno dell’altra di fronte ai figli e li rassicuravano anche dopo un litigio sul fatto che si amassero profondamente. I bambini hanno bisogno di poter avere fiducia nella stabilità dell’amore dei propri genitori: è ciò che li rende capaci di avere fiducia negli altri e nella vita.
Il convegno tematico è dedicato al Family Global Compact. Qual è il collegamento tra questo importante progetto e la virtù della speranza?
Il Family Global Compact è di fatto un invito ad investire sulla famiglia, sulla sua forza generativa nella società civile, ma anche nella Chiesa: la famiglia è un soggetto ecclesiale e ogni famiglia deve sentirsi parte della Chiesa, chiamata a partecipare e a contribuire alla missione dell’evangelizzazione. Il FGC propone dei percorsi formativi su temi che necessitano di un urgente approfondimento all’interno delle università cattoliche, perché questi approfondimenti servono in realtà alla Chiesa per sviluppare un’azione educativa e pastorale all’altezza delle sfide dei tempi. Il Family Global Compact, in questo senso, è un progetto di speranza: ha come obiettivo quello di ricostruire un pensiero cristiano forte sulla famiglia, nella cultura e nello spazio pubblico, anche a livello politico. Ne abbiamo urgente bisogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA