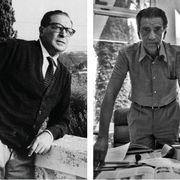Nei Salmi lo sguardo vivo dell’uomo che è bambino
La poetessa e scrittrice riminese ripercorre la sua lunga familiarità con l’affascinante e consolatoria lettura dei lirici componimenti dell’Antico Testamento, ponte d’amore tra l’umanità e Dio

Attraverso incontri, dialoghi e spettacoli il Festival Bliblico indaga in questa 21ª edizione, intitolata «Salmi. Libro infinito», il valore culturale e simbolico dei Salmi. Domenica 11 maggio, alle ore 16, 00 a Rovigo, ai Giardini delle Due Torri (Piazza Matteotti), appuntamento dal titolo “Luce: sopra la paura” con la poetessa Rosita Copioli.
Per me è difficile dire quando ho cominciato a leggere i Salmi. Credo molto presto, se penso al bisogno di consolazione, di forza e di rifugio che mi davano ancora prima che diventassi una adolescente solitaria, insicura, in continui conflitti. Risuonavano nelle liturgie della messa, e in quelle dolorose dei riti funebri, dovevano sollevare le persone amate e chi le aveva amate, a pascoli erbosi perenni: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla»...
Davano sensazione di conforto, nella solitudine: il tu che si poteva rivolgere al Dio del cosmo, e della Genesi: la difesa, il rispecchiamento in un sacro che era quello del mondo vivente, che mi circondava, nella natura. Forse erano già in me, nella bambina piccolissima che celebrava da sola i suoi riti guardando sorgere il sole, nel giardino che apriva il cancello sulla sabbia del mare, vicino a un albero, il macrocarpa piramidale verdissimo, sotto il quale aveva costruito un minuscolo altare fatto di sassi, conchiglie, foglie e fiori.
Leggevo i Salmi nella Bibbia tradotta da Ricciotti, poi nell’edizione Marietti in tre volumi, curata da Garofalo. Ma quando iniziai il Liceo a Rimini - noi di Riccione arrivavamo con il filobus o con il treno quasi mezz’ora prima della campanella - cominciò l’abitudine di recitare Prima, nella bella Chiesa di San Bernardino, all’angolo del vicolo dietro a Palazzo Buonadrata, che ospitava il Classico Giulio Cesare: «mille anni sono come un ieri ai tuoi occhi, come l’erba che germoglia e fiorisce al mattino è falciata alla sera, si secca ... consumiamo i nostri anni come un soffio».
Mio era quel ritmo che si univa al sacro dell’infanzia, tra il mare dell’alba e la collina che la guardava, di genti trascorse come senza peso: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano né mietono né raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre! Non valete, voi, più di essi? E chi di voi, affannandosi, può aggiungere un cubito solo alla lunghezza della sua vita? E per il vestito, di che vi affannate? Osservate i gigli del campo, come crescono: non lavorano né filano, ma vi dico che neppure Salomone, in tutta la sua gloria, fu mai vestito come uno di essi. Se, dunque, Dio veste così l’erba del campo, che oggi è e domani si butta al forno, quanto di più farà per voi, gente di poca fede? (Matteo 6, 26-30).
Due passeri non si vendono forse per un asse? E non uno di essi cade a terra senza il permesso del Padre vostro. Quanto a voi, anche i capelli del vostro capo sono numerati. Non temete, dunque; voi valete ben più di molti passeri. (Ivi, 10, 29-31)».
Non ho studiato l’ebraico, perciò ho cercato di leggere il testo in tutte le forme che potessero aiutarmi. L’ho fatto ascoltandolo in lingua (anche nel canto: Adonai ori, il più imprimente e pop, quello interpretato da Christene Jackman), confrontando le versioni che conoscevo con quelle della Bibbia ebraica interlineare dell’editrice San Paolo (di Fr. Stefano Mazzoni in modo interlineare e del cardinale Gianfranco Ravasi in modo letterario), e considerando le antiche traduzioni greca e latina, con i riflessi che gettavano nella memoria delle culture stratificate in eventi, e liturgie. Ho cercato anche altri confronti, come quelli di Gregorio Vivaldelli, o di siti ebraici, che propongono letture in lingue diverse. Ho pensato alla tradizione ebraica che lo recita per la festa di Rosh Hashanà e Kippùr, congedandosi dall’anno, per la festa di Sukkòt (Sukkà è tabernacolo), con la luce che risveglia dal sonno per ritornare a Dio, salvezza che si riferisce al giorno santo dello Yon Kippùr, quando si purificano i torti dell’anno passato attraverso il perdono e l’espiazione. Nel salmo Davide invoca Dio per la salvezza, sottolinea le tre fasi di liberazione. Nella prima Dio illumina il suo cammino in modo che possiamo fuggire il pericolo, nella seconda ci protegge e rimuove il pericolo, nella terza Dio ci porta in un luogo di rifugio. Ho trovato in un video di Mimma Russo del 6 settembre 2022 una squisita breve illustrazione di un’anonima studiosa ebrea dello Chabad di Milano, che mi ha conquistato per la sua intelligenza precisa, a illuminare dalle loro radici questo salmo che mi risuona potente, ma anche così semplice, come l’acqua pura e scrosciante che fluiva dalla voce di Giovanni Paolo II, papa Wojtyla. Con la plastica aderenza alla realtà del popolo ebraico, la credente spiega il salmo com’è ancora la loro preghiera viva. Sintetizza l’impasse del rischio per cui il salmo 27 implora la salvezza. Una terribile malattia, una crisi finanziaria, un grave problema emotivo, queste sono le tre fasi della liberazione che tutti cerchiamo: preoccupazione, tristezza, disperazione associate a una sfida possono essere opprimenti, l’oscurità ci perseguita e immobilizza, bloccando il nostro percorso in modo che non possiamo vedere. Il primo passo verso la guarigione è trovare un raggio di luce o una speranza per illuminare l’oscurità avvolgente, poi abbiamo bisogno di un percorso, una vera soluzione per il nostro problema, in modo che la gravità del pericolo o della difficoltà sia alleviata, ed infine anche dopo aver trovato una soluzione dobbiamo imparare a trovare la serenità, uno stato mentale calmo, un luogo del rifugio da cui affrontare le inevitabili lotte mentre l’anno volge al termine e uno nuovo pieno di promesse fa capolino.
Noi che cerchiamo i riflessi metafisici, sofisticati delle trasposizioni di ogni tipo di salvezza – che pure imploriamo per i pericoli infiniti che ci minacciano, e che pure esistono – restiamo colpiti dalla naturalezza di questa realtà aderente alle cose, e però viva, quotidiana. La lettura ebraica ci riporta alla concretezza. Ed era, è stata sempre, la concretezza del rapporto con quel Dio terribile, che anche il bambino quasi ancora infante cerca rivolgendogli la prima parola, quella più familiare, di figlio a padre/madre, con il tu della confidenza, del rapporto in un insieme di Genesi, se è stato fortunato da non avere subìto, fin dallo sbocciare, il trauma delle catastrofi recidenti le loro vite intrecciate.
Questa concretezza, bisogna dirlo subito, è la cosa più bella, quella che permette al bambino di dare del tu all’universo, di sentire fratelli tutti gli esseri. È la sostanza del Cantico delle creature di san Francesco. La stessa che immedesima con Dio, che fa scrivere il Cantico dei cantici, che spinge alla ricerca, al dialogo amoroso di chi brama Dio come il suo popolo, nell’eros totale, che i mistici di qualsiasi religione hanno conosciuto.
Tutti i Salmi esprimono questo rapporto di fusione con Dio che è proprio del bambino, anche il bambino avventuroso, che combatte con i propri avversari, vuole distruggerli, cerca aiuto e riparo in qualcuno più grande di lui, il potentissimo che lo proteggerà, che lo ospiterà nella sua tenda, che lo porterà in salvo su una roccia inaccessibile, che sterminerà tutti quanti i suoi nemici, al quale, per devozione sacrificherà tutte le primizie con gioia, esultando con canti di vittoria accesi e inni, e sperando di essere alla fine accolto nella sua casa di vita, dove tutti sono vivi. Da un lato la falsità, l’insidia, lo sbranamento, la distruzione, dall’altro la via retta, come quella del sentiero su cui le cavalle della dea guidano Parmenide, lo strappo nella sollevazione salvifica sull’altezza inaccessibile della rupe, o rocca. C’è un bambino, il puer aeternus, un eroe di Salgari, e un bambino Leopardi, un bambino come siamo stati tutti noi, ma anche bambino Buddha che oltrepassa i desideri di vendetta, e cerca la quiete, la perfetta felicità in quella casa, o tenda luminosa nel deserto, che sarà Gerusalemme dalle mura di cristallo.
Ciò che colpiva sempre, era la profonda vicinanza di molti salmi con il Vangelo. Quel sacro originario di famiglia di Dio, che diventa Vangelo. Lo so che ciò è stato sottolineato da sempre, anche in contrasto con il modo di leggerli in ambito ebraico. Eppure, se si mettessero insieme, tutte queste sostanze, come i lieviti che fanno pani diversi... Anche un ateo potrebbe sottoscriverlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA