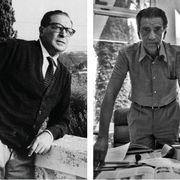Il filosofo Honneth: «Il lavoro produce la libertà»
Il pensatore tedesco propone una nuova teoria dell’impegno produttivo come fondamento di una cittadinanza democratica più partecipata

«Ho scoperto tardi, dopo la stesura del libro, di condividere con Bruno Trentin l’idea che il lavoro sia un’esperienza di cooperazione reciprocamente vantaggiosa, centrale nel tessuto morale di una società, e che quindi debba essere democratizzato» sostiene, a proposito del suo ultimo lavoro da poco pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, Il lavoratore sovrano. Lavoro e cittadinanza democratica (pagine. 274, euro 29,00) il filosofo tedesco Axel Honneth, attualmente Jack C. Weinstein Professor for the Humanities alla Columbia University di New York e in precedenza direttore del celebre Institut für Sozialforschung di Francoforte, proprio quello della famosa Scuola.
Perché il lavoro non è più un tema al centro del dibattito filosofico-politico? Dipende dall’ascesa del neoliberismo?
«No, non credo. Questo disinteresse è iniziato prima, già negli anni Sessanta, quando la filosofia e la teoria sociale hanno contribuito a diffondere l’idea che il lavoro avesse perso rilevanza etica e funzione di orientamento nella vita di ognuno. Oggi ne sappiamo di più, ma allora si pensava che lo slittamento culturale verso i cosiddetti valori non materialistici avrebbe ridotto rapidamente l’impatto del lavoro nel ciclo di vita individuale. Oggi, con la crescente precarizzazione, individualizzazione e frammentazione del lavoro, dobbiamo cambiare rapidamente modo di vedere e renderci conto che è ancora il posto di lavoro a determinare le possibilità di vita, il benessere e la salute mentale delle persone. Ecco perché ritengo il lavoro debba tornare al centro dei dibattiti filosofico-politici».
Ma cosa intende esattamente per lavoro?
«È una domanda complicata a cui non è facile rispondere. Negli ultimi decenni abbiamo imparato a non identificare il lavoro con il lavoro industriale, perché ci sono molte altre attività che, nelle società contemporanee, sono altrettanto importanti, persino necessarie, per la riproduzione sociale. È la lezione che ricaviamo dai dibattiti femministi sul lavoro domestico non retribuito, un’attività che non viene pubblicamente registrata come “lavoro”. Riconosciuto questo aspetto, è chiaro che ci sono molte altre attività necessarie al mantenimento della nostra forma di vita, anche se non sono riconosciute come “lavoro”».
Per esempio?
«Pensi all’enorme quantità di lavoro non retribuito che gli anziani svolgono nei servizi sociali o in famiglia, senza ricevere alcun riconoscimento pubblico per ciò che fanno. Ecco perché mi avvalgo di un concetto di lavoro molto ampio, che include tutte le prestazioni che in un determinato momento si considerano necessarie per la riproduzione di una determinata forma di società».
Per queste ragioni è importante che il lavoratore sia sovrano?
«Se permette vorrei riformulare la domanda. Se tutti i lavoratori, come tutti gli altri membri delle nostre società democratiche, sono considerati parte del sovrano democratico, come mai molti di loro sono incapaci di svolgere questo ruolo come dovrebbero, cioè partecipando alla formazione democratica della volontà senza vergogna, fiduciosi e sicuri di sé? Essere parte del sovrano, per i lavoratori, non è qualcosa di accidentale. Ne hanno diritto in base alle nostre costituzioni democratiche. Detto altrimenti la partecipazione democratica è un diritto fondamentale. Capire che cosa, nell’attuale organizzazione capitalistica del lavoro, renda difficile per i lavoratori realizzare e godere pienamente di questo diritto fondamentale, è la domanda guida che ispira il mio libro».
Come creare le condizioni per cui questo diritto sia sostanziale e non solo formale?
«Attraverso una politica democratica del lavoro che riconquisti un certo potere sul mercato capitalistico, così da prevenire e ridurre le condizioni di lavoro precarie e avviare iniziative per la democratizzazione delle condizioni di lavoro. Detto in breve».
E in dettaglio…
«È necessaria una duplice strategia, che, per avere successo, richiede la riconquista del potere sul capitale. Per prima cosa occorrerebbe convincere gli Stati democratici a sovvenzionare e facilitare legalmente le iniziative per la nascita di cooperative di lavoratori e realizzare esperimenti a lungo termine ricorrendo a un’organizzazione del lavoro non capitalista, come avviene in Spagna con l’esperienza di Mondragón. Poi bisognerebbe realizzare delle riforme del mercato del lavoro per ridurre il lavoro precario e promuovere i processi promotori della democratizzazione del lavoro salariato, rendendo la prestazione lavorativa più autodeterminata e cooperativa».
Quindi c’è un legame tra crisi della democrazia e un lavoro senza aura?
«Non è che il lavoro abbia perso la sua aura sociale, come lei dice, ma sta rapidamente perdendo, a causa degli effetti del neoliberismo, il suo ruolo nel riunire le persone e renderle consapevoli della loro interdipendenza. Se prendiamo le cosiddette gig-company come Google, Amazon o Deliveroo, ci si rende subito conto che alle persone che vi sono impiegate viene deliberatamente impedito di lavorare insieme e quindi di condividere le esperienze, cosa che permetterebbe loro di organizzare una resistenza contro le condizioni lavorative attuali. Più l’organizzazione del lavoro va verso l’atomizzazione, più perde la sua funzione di creazione di legami sociali attraverso lo scambio di esperienze».
Quali aspetti deve avere il lavoro per essere di supporto alla democrazia?
«Sono cinque le condizioni minime per consentire a tutti i lavoratori di partecipare al processo democratico senza vincoli sociali o psicologici. Primo, un reddito minimo che permetta di essere indipendenti dall’arbitrio altrui e consenta di avere una vita economicamente indipendente. In secondo luogo, disporre di tempo sufficiente per seguire gli eventi e i dibattiti politici in modo da potersi impegnare, se lo si desidera, nell’arena pubblica. Terzo, il riconoscimento pubblico del lavoro che si svolge, a prescindere da quanto sia qualificato, perché anche il cosiddetto lavoro non qualificato richiede alcuni talenti specifici e talvolta è più importante per la vita sociale e la riproduzione della stessa di quanto non lo sia l’altro. In quarto luogo, beneficiare di un diritto minimo di codeterminazione delle modalità di lavoro e degli obiettivi del proprio impegno. Infine, un livello minimo di complessità e rigore intellettuale in ogni i lavoro, per evitare gli effetti psicologici disastrosi di lavori passivi e ripetitivi nell’industria, nei servizi e nell’amministrazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA