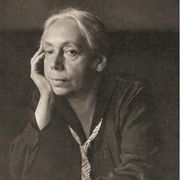Foibe, due libri per capire una tragedia ancora sconosciuta
Due volumi con le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il dramma dell'Istria quando la nuova dittatura comunista di Tito rese impossibile la vita agli italiani di quella zona di frontiera

“Fogolèr”, focolare in dialetto istroveneto, è il libro che mancava e finalmente c’è (ed. Ares, 304 pag. 20 euro). Lo ha scritto Grazia Del Treppo, partita da bambina nel febbraio del 1951 dalla sua Canfanaro, paese nel cuore dell’Istria, quando la nuova dittatura comunista di Tito aveva reso impossibile la vita agli italiani e rotto la convivenza, prima pacifica, tra le diverse etnie che da sempre popolavano le sue contrade. Del Treppo, insegnante di Lettere specializzata in Psicologia, scrive esattamente ciò che è enunciato nel sottotitolo, “Storia di una famiglia istriana”, la sua, ma incastonata nel contesto più ampio dell’altra Storia, quella con la S maiuscola. Con eleganza e pacatezza, ci conduce dentro gli eventi che tuttora a Canfanaro (oggi Croazia) la gente ricorda: tradizioni, feste patronali, parlate dialettali sia venete che slave, ma poi, via via che il clima umano cambiava e il terrore prendeva il sopravvento, la sparizione dei capifamiglia italiani, le condanne come “nemico del popolo”, le reiterate richieste da parte della sua famiglia (ripetutamente respinte) di “optare”, cioè perdere tutto ma poter andare in Italia, infine solo nel 1951 la partenza (“fu il primo grande dolore dei miei piccoli nove anni”) e il campo profughi…
Non c’è astio nelle sue pagine e mai fa di tutta l’erba un fascio, persino i titini non sono solo feroci e la scintilla della pietas può brillare dove meno te l’aspetti. I suoi ricordi di bambina rievocano fatti tragici come nel ’44 l’omicidio di don Marco Zelco, parroco impiccato dai nazisti nella piazza del paese e lì rimasto finché il vescovo Radossi lo calò dal patibolo per celebrarne, da solo, le esequie, e nel ’47 – in tempo di “pace” – l'eliminazione del nuovo parroco Miroslav Bulešić (nel 2013 beatificato da papa Francesco), pugnalato alla gola dai titini per aver disobbedito all’ateismo di regime e dato la Cresima a duecento bambini (molti dei genitori e dei padrini finirono ai lavori forzati). Fatti storici, tremendi, eppure nel fogolèr di Grazia, simbolo di quelle braci d'amore che sotto le ceneri restano accese, c’è spazio anche per tanta umanità e perfino per l’umorismo. Di pagina in pagina, la sua storia diventa la nostra, conosciamo i vari protagonisti come fossimo anche noi della famiglia, palpitiamo per la loro sorte e ci commoviamo con loro. Difficile resistere soprattutto quando, costretta a lasciare la vita armoniosa e pacifica di Canfanaro, la famiglia di Grazia abbandona la bella casa, il negozio, i campi, gli amici italiani e croati, per cercare la libertà in altre regioni d'Italia. E lì non trova la "terra promessa" dei suoi sogni, ma lo squallore dei campi profughi, dove a soffrire l'indicibile sono soprattutto gli anziani: "Il nonno Zanetto "Fatutto", creativo per definizione, nei primi anni a Torino non poteva più fare nulla. Era confinato in una buia camera con uso cucina, lui che aveva costruito la sua casa in pietra bianca, piena di luce e di bellezza". Non va meglio ai "rimasti", ormai soli in Istria, senza più gli amici scappati in Italia e sottomessi alla nuova dittatura: "Nei miei primi ritorni in Istria - scrive Del Treppo - mi è capitato frequentamente di incontrare anziani seduti in silenzio, soli, davanti alla loro casa, con lo sguardo fisso nel vuoto. All'udire la mia parlata istriana, sembravano risvegliarsi dal torpore e illuminarsi: Da dove la vien? La se ferma per sempre in Istria? Perché no tornè?... La loro solitudine in patria non era meno dolorosa di quella degli istriani in Italia".
Come rileva nella preziosa prefazione lo storico Roberto Spazzali, in queste vicende "cultura italiana e religione cattolica si saldano nell'anima. Saranno proprio questi elementi fondanti a portare la sua famiglia a scegliere di andarsene, non per odio verso gli altri" ma per le vessazioni subite, dalla condanna al carcere di sua madre (colpevole di frequentare la Messa), ai lavori forzati per suo padre, altrettanto innocente ma "nemico del popolo".
Nella postfazione Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, scrive: "Leggendo questo libro, mi accorgo che quel focolare esiste. Immutato. Per sempre. Scrivendo, quella bambina continua quanto fatto da generazioni prima di lei e ha gettato un altro ceppo tra le braci: la fiamma continua ad ardere e ci riscalda tutti. E' il dono che quella bambina ha fatto al lettore, facendoci partecipare al semicerchio di un'Istria vissuta profondamente nella sua essenza".
Sarebbe bene che questo testo entrasse in tutte le scuole: la risposta a qualsiasi estremismo, da una parte e dall'altra, voce obiettiva e competente, la Storia intrecciata alla storia.
Non c’è astio nelle sue pagine e mai fa di tutta l’erba un fascio, persino i titini non sono solo feroci e la scintilla della pietas può brillare dove meno te l’aspetti. I suoi ricordi di bambina rievocano fatti tragici come nel ’44 l’omicidio di don Marco Zelco, parroco impiccato dai nazisti nella piazza del paese e lì rimasto finché il vescovo Radossi lo calò dal patibolo per celebrarne, da solo, le esequie, e nel ’47 – in tempo di “pace” – l'eliminazione del nuovo parroco Miroslav Bulešić (nel 2013 beatificato da papa Francesco), pugnalato alla gola dai titini per aver disobbedito all’ateismo di regime e dato la Cresima a duecento bambini (molti dei genitori e dei padrini finirono ai lavori forzati). Fatti storici, tremendi, eppure nel fogolèr di Grazia, simbolo di quelle braci d'amore che sotto le ceneri restano accese, c’è spazio anche per tanta umanità e perfino per l’umorismo. Di pagina in pagina, la sua storia diventa la nostra, conosciamo i vari protagonisti come fossimo anche noi della famiglia, palpitiamo per la loro sorte e ci commoviamo con loro. Difficile resistere soprattutto quando, costretta a lasciare la vita armoniosa e pacifica di Canfanaro, la famiglia di Grazia abbandona la bella casa, il negozio, i campi, gli amici italiani e croati, per cercare la libertà in altre regioni d'Italia. E lì non trova la "terra promessa" dei suoi sogni, ma lo squallore dei campi profughi, dove a soffrire l'indicibile sono soprattutto gli anziani: "Il nonno Zanetto "Fatutto", creativo per definizione, nei primi anni a Torino non poteva più fare nulla. Era confinato in una buia camera con uso cucina, lui che aveva costruito la sua casa in pietra bianca, piena di luce e di bellezza". Non va meglio ai "rimasti", ormai soli in Istria, senza più gli amici scappati in Italia e sottomessi alla nuova dittatura: "Nei miei primi ritorni in Istria - scrive Del Treppo - mi è capitato frequentamente di incontrare anziani seduti in silenzio, soli, davanti alla loro casa, con lo sguardo fisso nel vuoto. All'udire la mia parlata istriana, sembravano risvegliarsi dal torpore e illuminarsi: Da dove la vien? La se ferma per sempre in Istria? Perché no tornè?... La loro solitudine in patria non era meno dolorosa di quella degli istriani in Italia".
Come rileva nella preziosa prefazione lo storico Roberto Spazzali, in queste vicende "cultura italiana e religione cattolica si saldano nell'anima. Saranno proprio questi elementi fondanti a portare la sua famiglia a scegliere di andarsene, non per odio verso gli altri" ma per le vessazioni subite, dalla condanna al carcere di sua madre (colpevole di frequentare la Messa), ai lavori forzati per suo padre, altrettanto innocente ma "nemico del popolo".
Nella postfazione Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, scrive: "Leggendo questo libro, mi accorgo che quel focolare esiste. Immutato. Per sempre. Scrivendo, quella bambina continua quanto fatto da generazioni prima di lei e ha gettato un altro ceppo tra le braci: la fiamma continua ad ardere e ci riscalda tutti. E' il dono che quella bambina ha fatto al lettore, facendoci partecipare al semicerchio di un'Istria vissuta profondamente nella sua essenza".
Sarebbe bene che questo testo entrasse in tutte le scuole: la risposta a qualsiasi estremismo, da una parte e dall'altra, voce obiettiva e competente, la Storia intrecciata alla storia.
“Le foibe spiegate ai ragazzi” è invece l’impresa tentata da Greta Sclaunich, giornalista del Corriere della Sera, che per Piemme (14,50 euro, 135 pag) propone una decina di brevi testimonianze, tratte da interviste già ben note a esuli istriani che si raccontano da anni: storie drammatiche che l’autrice cerca di ingentilire, tratteggiando quel mondo multiculturale che fa da sfondo alle vicende familiari e che in un pugno di anni vide cambiare dominazioni, lingue, cognomi così “strani” al nostro orecchio. A partire proprio dal suo, quello Sclaunich con ch finale che da una vita fa sì che a lei, italianissima, si chieda se sia straniera e come mai parli bene l’italiano. Al pubblico di ragazzini la giornalista racconta dunbque storie di altri ragazzini di un tempo: sono loro i protagonisti, nati a Pola, a Fiume, a Umago, a Capodistria quando lì era Italia, poi travolti dalla guerra e dalle sue conseguenze. Dal nazifascismo in queste zone non si passò alla Liberazione, ma a un nuovo regime, quello comunista jugoslavo, e quindi all’orrore delle Foibe e alla fuga verso l’Italia. Quei bambini di allora sono la voce oggi in grado di trasmettere una storia nazionale ancora a molti sconosciuta. Nota dolente, gli errori sulle cartine geografiche a corredo, e la incoerente bibliografia: esclude i testi basilari sia della saggistica che della memorialistica e ne comprende altri nettamente giustificazionisti della dittatura titina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA