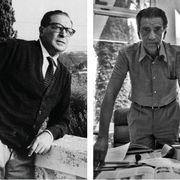Cattolici e cultura: non solo debito ma immaginazione
L’intreccio delle generazioni, nel tempo storico e in tutti gli ambienti umani, chiama a strategie mirate. Come abili cacciatori
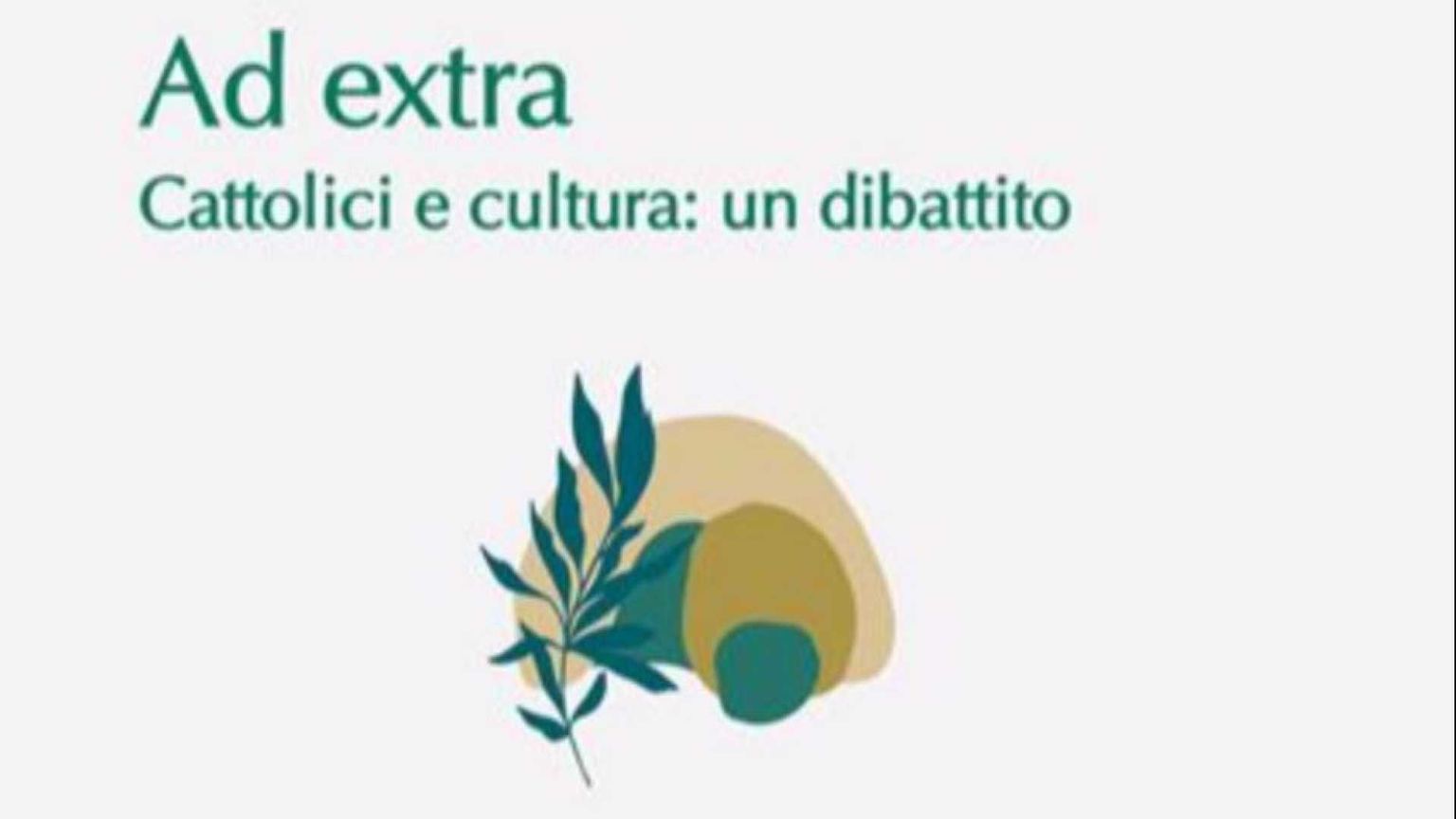
Pubblichiamo una riflessione dell’arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, sul rapporto tra Chiesa e cultura nel tempo - dal mondo classico a oggi - e nello spazio che comprende i cinque continenti. Pagazzi discuterà di questi temi sabato al Salone del libro di Torino (Padiglione 1 Sala rosa, ore 11.30) in occasione della presentazione del volume Ad extra. Cattolici e cultura: un dibattito, con il filologo Carlo Ossola. Modera Edoardo Castagna, responsabile delle pagine culturali di “Avvenire” e curatore del volume. Il libro, pubblicato da Vita e Pensiero (pagine 182, euro 15,00), raccoglie gli articoli apparsi lo scorso anno su “Avvenire” nel dibattito su cattolici e cultura innescato da monsignor Pier Angelo Sequeri e Roberto Righetto. Al dibattuto hanno partecipato anche Raul Gabriel, Bruno Forte, Silvano Petrosino, Antonio Spadaro, Carlo Ossola, Chiara Giaccardi, Giuseppe Lorizio, Sergio Massironi, Agostino Giovagnoli, Milena Santerini, Francesco Cosentino, Giuliano Zanchi, Luigi Alici, Vittorio Possenti, Lorenzo Ornaghi, Davide Rondoni, Costantino Esposito, Nicola Sabatini, Massimo Cacciari, Franco Nembrini, Roberto Gabellini, Giuliano Vigini, Roberto Timossi, Roberto Colombo, Vincenzo Arnone, Giuseppina De Simone, Luigino Bruni, Francesco Postorino, Ivano Dionigi, Luca Diotallevi, Pierpaolo Donati, Giuliano Ladolfi, Giuseppe Lupo, Fabio Pierangeli, Caterina Verbaro, Roberto Carnero, Roberta Rocelli e Andrea Riccardi.
Le stagioni della storia sono intrecciate. L’oggi è inimmaginabile senza i sostegni e gli incoraggiamenti provenienti da ieri. Un oggetto odierno, come un cucchiaio, è inconcepibile senza la metallurgia primitiva. Una missione spaziale non si pianifica senza il contributo tuttora operativo delle antiche matematiche egizie, indiane, cinesi, greche, arabe e precolombiane. Il passato è contemporaneo al presente e lo accompagna. Esiste una sincronia di tutte le generazioni. Non siamo orfani, a patto che non decidiamo di esserlo. È stabilita una sorta di comunione dei santi culturale: le opere e i pensieri buoni di chi ci ha preceduto sono ancora attivi, perciò ne siamo debitori. Dovremmo provare il medesimo senso di debito e la stessa gratitudine dell’apostolo Paolo. Ebreo, scrive ai cristiani di Roma nella lingua dei greci. Mentre nomina di continuo Cristo, afferma di essere «in debito» con tutti, «verso i greci come verso i barbari» (Romani 1,14). In forza di questo debito si sente «pronto (…) ad annunciare il Vangelo» (Romani 1,15).
La parentela tra le generazioni della storia emerge anche in quanto definiamo classico. Un classico della letteratura, della musica, del cinema, del pensiero. Ma anche della cucina, del vestire e dello sport. Un classico è tale perché accende nelle donne e negli uomini di ogni epoca una risonanza autobiografica che li fa sentire a casa. Forse perché, nonostante le innegabili differenze, le domande e i gesti di ieri ci somigliano. Scansare un classico in nome del contemporaneo, perché più immediato e accattivante, significa rinunciare alla familiarità culturale delle generazioni, sottomettendosi alla tirannia del presente. Avvicinare un classico significa interrompere la prevaricazione del presente sulle altre generazioni. Così facendo, germoglia nel presente stesso una sospensione, una sosta la quale è il requisito del tempo festivo. Infatti, senza interrompere la continuità del presente non si dà alcuna festa. Perciò, accostarsi a un classico significa riprendere fiato, distendere i muscoli dell’anima, arieggiare la stanza dei nostri pensieri e affetti, godere la solennità commovente di una domenica della mente e del cuore.
La giusta gratitudine verso la densità culturale dell’Europa, alla quale la Chiesa contribuisce da due millenni, non deve impedire il riconoscimento, la stima, l’interesse e il gusto di quanto è classico, senza essere europeo. L’Africa ha i propri classici. Così pure la Cina, l’India, il variegato ambiente linguistico semitico, le due Americhe e la Russia... In ogni ambiente umano – fino a quello meno riconosciuto dall’opinione mondiale – si trova una sedimentazione del senso della vita. Su questo suolo comune gli spiriti più diversi costruiscono la propria casa. Incanta il fatto che perfino accostando i classici dei paesaggi a noi più lontani scorgiamo, in un tratto o in un altro, un volto che ci somiglia.
L’intreccio delle generazioni, anche a livello culturale, non richiede solo di onorare il debito contratto con il passato, ma implica pure l’immaginazione del domani. In proposito è suggestivo uno dei modi dell’Antico Testamento per indicare il peccato: bersaglio mancato. Non per nulla la parola Torah (i primi cinque libri della Bibbia) allude anche al gesto con cui un cacciatore o un soldato esperto aiuta il principiante a prendere la mira affinché, appunto, non manchi il bersaglio. Prendere bene la mira è questione di vita o di morte. Se il cacciatore non cattura la preda, muore di fame. Non è sufficiente individuarla.
Colpire il bersaglio è vitale per il cacciatore e per chiunque desideri la vita... anche la vita della Chiesa. Il popolo di Dio non deve mancare i bersagli, soprattutto dal punto di vista culturale. Non è affatto facile. Il primo impulso è muoversi subito. Così facendo, quasi sempre si sbaglia la mira. Per centrare un bersaglio in movimento (quanto sono mobili le questioni, la cultura e la società!) bisogna star fermi, regolando il respiro fino a trattenerlo, poiché il suo moto agitato potrebbe sviare l’arco. La buona mira vive di questo paradosso: si raggiunge quanto si muove velocemente smettendo di respirare, facendo il morto. Inoltre, è indispensabile avere il senso per la traiettoria: conoscere l’intero percorso del bersaglio – da dove viene, dov’era, dov’è – per immaginare dove sarà. Infine, la cosa più complicata: mirare all’obiettivo non dove è adesso, ma dove sarà; altrimenti all’arrivo del proiettile, la lepre sarà già altrove. Puntare l’obiettivo dove si trova ora significa mancare certamente il bersaglio. Infatti, perfino la più svelta delle frecce arriverà in ritardo. Dopo aver immaginato la traiettoria, è necessario puntare nel vuoto, nel futuro, tentando di prevedere e anticipare quanto si muove. Così facendo si ha l’impressione di sprecare munizioni e tempo, eppure è la condizione necessaria per trovare cibo.
Concludo con un’immagine architettonica. Mi riferisco alla splendida cattedrale di Siracusa, dedicata alla Natività di Maria Santissima. L’edificio odierno raccoglie una storia di circa 2.500 anni. È l’approdo di una lunga serie di generazioni. In origine era un sontuoso tempio greco in stile dorico, dedicato ad Atena, costruito nel V secolo avanti Cristo. Successivamente, i bizantini murarono lo spazio tra le colonne, trasformando il recinto sacro pagano in un’aula liturgica cristiana. Prima i normanni e poi gli spagnoli arricchirono ulteriormente l’edificio, apportandovi rispettivamente i tratti sobri e robusti dei popoli nordici e i movimenti fluttuanti del barocco. Si può affermare che il tempio greco è l’ossatura su cui è stata plasmata la carne della chiesa. Infatti, la chiesa poggia sulle fondamenta e le colonne del tempio di Atena. Queste non sono state occultate dall’edificio cristiano, ma permangono tuttora ben visibili. Si entra in chiesa e ci si trova contemporaneamente in uno spazio della classicità pagana. Ma non è tutto: nel gennaio 1693 la Sicilia orientale fu colpita da un terremoto catastrofico. Ad esso seguì un terribile maremoto. Siracusa fu distrutta. Eccettuata la facciata, la cattedrale resistette al sisma. La sua stabilità risparmiò dalla distruzione sia l’opera dei bizantini e dei normanni sia il tempio greco che, senza il concorso delle pareti cristiane, sarebbe andato perduto. Se oggi si ha e domani si avrà ancora la fortuna di ammirare il santuario di Atena, distinguendone le colonne e la cella sacra, è perché la Chiesa lo ha incorporato come una cosa necessaria e bella. Grata per quanto perfino i pagani le avevano offerto, la Chiesa custodiva il proprio futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA