Il presidente: vogliamo essere liberi di prenderci cura dei nostri pazienti
Di cosa è fatta la crisi dei camici bianchi? Dove si origina il loro malessere? E come se ne esce? Lo spiega Filippo Anelli, alla guida della Federazione nazionale degli Ordini professionali

«L’invito che vi faccio è ad animare dall’interno i sistemi sanitari, perché nessuno venga abbandonato». Questo l’appello che Papa Francesco ha rivolto a noi medici e agli altri professionisti sanitari il 23 novembre scorso, ricevendoci a conclusione del Convegno internazionale “Universalità e sostenibilità dei Servizi Sanitari nazionali in Europa” organizzato in collaborazione con la Cei, seconda tappa del percorso verso il Giubileo dei malati e della sanità.
Nessuno venga abbandonato: è questo lo spirito vero, il cuore del nostro Servizio sanitario nazionale, che nasce per non lasciare nessuno indietro, per garantire cure a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali, fisiche, di genere, di età, e per rendere tutte le persone uguali di fronte alla salute. È questo il senso della nostra professione di medici, che ci impone come unico dovere quello della cura, declinato nei suoi vari aspetti e sfaccettature: la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna.
Non abbandonare significa dunque curare tutti: anche gli inguaribili, anche chi la pensa diversamente da noi. Anche gli emarginati, anche i fragili, perché il solo fatto di essere persone conferisce loro il diritto alla cura e alla tutela della salute. Anzi, le condizioni di fragilità e di emarginazione elevano all’ennesima potenza tale diritto, che deve essere garantito con maggior attenzione e delicatezza, con predilezione, come ci ha ricordato il Papa.
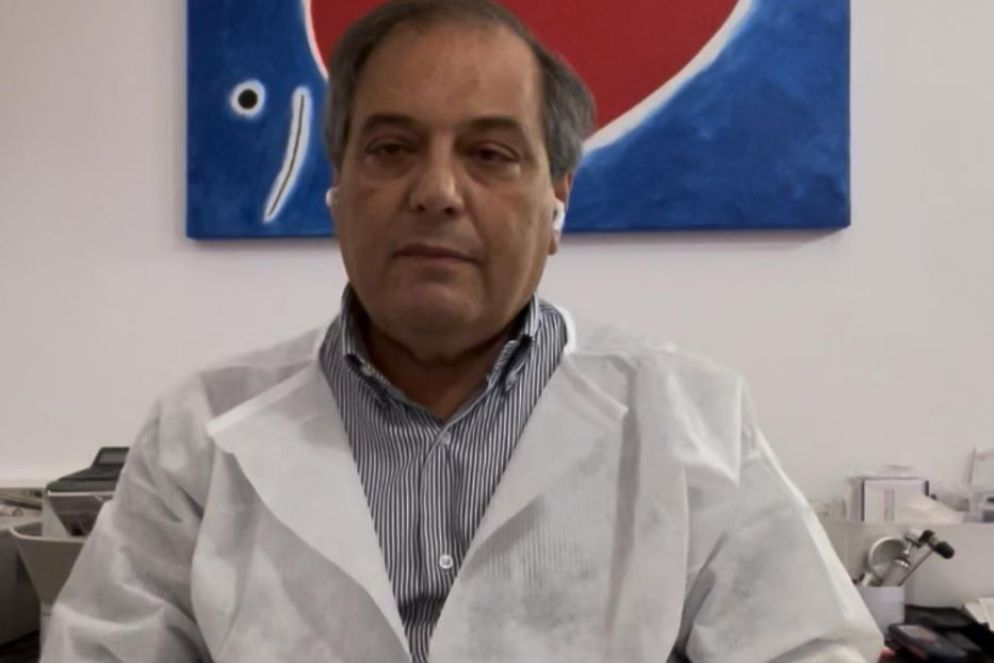
È quello che facevano i Medici Santi: san Giuseppe Moscati, che da poco abbiamo ricordato in un altro bel convegno, organizzato insieme alla Sis 218, della quale è patrono; prima di lui, i santi Cosma e Damiano, patroni di tutti i medici. È quello che ci impone il Codice di Deontologia, che dopo aver fissato, all’articolo 3, i doveri del medico, all’articolo 32 esplicita quello alla tutela dei minori, delle vittime di qualsiasi abuso o violenza e delle persone in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile. È quello che afferma la nostra Costituzione, quando, all’articolo 32, attesta che la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti, ponendo le fondamenta del nostro Servizio sanitario nazionale.
Sono questi i principi che i medici incarnano nel loro lavoro quotidiano; sono questi i principi che, resi vivi dagli uomini e dalle donne che ne sono portatori e testimoni, animano dall’interno il nostro Servizio sanitario nazionale; sono questi i principi che hanno traghettato il Paese fuori dalla pandemia di Covid. Il sacrificio di ben 383 medici, caduti a causa del Covid, ha reso evidente l’importanza dei principi che ispirano la professione, condizionandola al bene della persona.
Sono questi i principi che i medici incarnano nel loro lavoro quotidiano; sono questi i principi che, resi vivi dagli uomini e dalle donne che ne sono portatori e testimoni, animano dall’interno il nostro Servizio sanitario nazionale; sono questi i principi che hanno traghettato il Paese fuori dalla pandemia di Covid. Il sacrificio di ben 383 medici, caduti a causa del Covid, ha reso evidente l’importanza dei principi che ispirano la professione, condizionandola al bene della persona.
“Ogni vita conta” è lo slogan che Fnomceo ha utilizzato durante l’emergenza Covid per ringraziare tutti i medici che, avendo giurato di difendere la vita, non si sono risparmiati, nei reparti e sul territorio, per salvare il numero più alto di pazienti. Ospedalieri, Pediatri, Specialisti ambulatoriali, Medici di famiglia, di continuità assistenziale, delle Usca, del 118, delle Rsa, odontoiatri: tutti si sono impegnati, ciascuno per la propria parte, per l’obiettivo comune di contenere gli effetti devastanti della pandemia.
Proprio dalla pandemia è emersa con maggiore insistenza la necessità di un cambiamento del Codice di Deontologia. Un Codice che indichi chiaramente ai medici di domani che devono imparare a dedicare tempo al paziente, ad ascoltarlo, a rivalutare la singolarità dell’individuo, utilizzando la complessità degli strumenti a disposizione per giungere ad una presa in carico della persona nella sua interezza, perché il medico debba non solo curare le malattie attraverso la diagnosi e la terapia ma essere sempre più il medico della persona. Quattro le direttrici sulle quali lavorare: i “nuovi” diritti, come l’autodeterminazione, il pluralismo culturale, la libertà della ricerca e della scienza; la comunicazione, intesa come rapporto medico paziente, con le altre professioni, e con l’esterno; le nuove tecnologie, tra le quali l’intelligenza artificiale, la robotica, la telemedicina; e la responsabilità, autonomia e rischio clinico, che riguarda, tra le altre cose, il conflitto di interesse e il rapporto tra il Codice e la Legge. Si tratta di tematiche che riguardano non solo i medici, ma l’intera società civile.
Il cambiamento, dunque, non poteva che partire da un confronto con la società civile: con un “board” di esperti, medici, giuristi, giornalisti, filosofi della medicina, religiosi, per condividere le linee su cui intervenire. Rinnovare il Codice di Deontologia medica rappresenta sempre una sfida per la professione, giacché comporta una profonda riflessione sulla natura dell’esser medico e sul ruolo che i medici, attraverso quest’antica arte professionale, svolgono nella nostra società nell’assicurare la salute, nel curare le malattie e nel lenire le sofferenze.
I medici vivono quotidianamente con disagio quei condizionamenti sociali e culturali della società che riguardano la loro professione. Si tratta di condizionamenti di carattere economico ed organizzativo che rendono frustrante l’esercizio professionale, come la cosiddetta medicina amministrata, espressione di scelte, priorità, non coerenti o addirittura in contrasto con quei principi che ispirano la professione. La scelta di aziendalizzare la sanità e il Servizio sanitario nazionale ha condizionato negativamente le finalità del sistema, mettendo al primo posto gli obiettivi di carattere economico rispetto a quelli di salute che dovrebbero, invece, essere il principale scopo del sistema. In questo modello i medici si trovano spesso costretti a subordinare la loro attività professionale ed assistenziale agli obiettivi economici imposti dal loro datore di lavoro, limitando conseguentemente le prestazioni.
I medici vivono quotidianamente con disagio quei condizionamenti sociali e culturali della società che riguardano la loro professione. Si tratta di condizionamenti di carattere economico ed organizzativo che rendono frustrante l’esercizio professionale, come la cosiddetta medicina amministrata, espressione di scelte, priorità, non coerenti o addirittura in contrasto con quei principi che ispirano la professione. La scelta di aziendalizzare la sanità e il Servizio sanitario nazionale ha condizionato negativamente le finalità del sistema, mettendo al primo posto gli obiettivi di carattere economico rispetto a quelli di salute che dovrebbero, invece, essere il principale scopo del sistema. In questo modello i medici si trovano spesso costretti a subordinare la loro attività professionale ed assistenziale agli obiettivi economici imposti dal loro datore di lavoro, limitando conseguentemente le prestazioni.
Questa è una delle ragioni che, sempre più frequentemente, determina l’insorgenza di episodi di violenza contro gli operatori sanitari, chiamati per dovere etico e deontologico a essere sempre accanto al malato, invece percepiti dal cittadino come coloro che limitano il soddisfacimento del loro bisogno di salute. Anche lo stesso tema della responsabilità medica ed il fenomeno sempre più frequente relativo al ricorso alla magistratura penale per censurare l’operato del medico è espressione di uno iato tra professione e società, che provoca disagio e la medicina difensiva.
Questa difficoltà di rapporto tra medico e società, il conseguente disagio per la professione medica che ne deriva, ha portato alcuni studiosi a parlare di crisi del medico nella società moderna e della necessità di un cambiamento. Un cambio di passo appunto, un cambio di paradigma, intendendo per questo la necessità di rivedere la definizione del ruolo del medico ossia il passaggio da un professionista oggi preparato per curare la malattia a un medico capace e formato per curare la persona. Prendersi cura della persona significa rispettare l’altro come persona che a noi si affida, preservare la sua dignità, rendere esigibili – grazie alle nostre competenze – i suoi diritti. Un cambiamento che presuppone una profonda modifica anche dei percorsi formativi in grado di preparare un medico che possa utilizzare lo strumento della comunicazione come l’atto più importante per la cura del paziente.
Non abbandonare, infine, vuol dire non poter accettare che qualcuno rimanga indietro, che 4,5 milioni e mezzo di italiani oggi siano costretti a rinunciare alle cure per ragioni economiche o per le liste di attesa troppo lunghe. Ognuno di questi cittadini è per noi medici, per noi professionisti, per il Servizio sanitario nazionale, per l’intero Paese una sconfitta, una ferita aperta.
Non abbandonare, infine, vuol dire non poter accettare che qualcuno rimanga indietro, che 4,5 milioni e mezzo di italiani oggi siano costretti a rinunciare alle cure per ragioni economiche o per le liste di attesa troppo lunghe. Ognuno di questi cittadini è per noi medici, per noi professionisti, per il Servizio sanitario nazionale, per l’intero Paese una sconfitta, una ferita aperta.
Animiamo dunque dall’interno il nostro Servizio sanitario nazionale, continuiamo a riempirlo con il nostro impegno di professionisti, e chiediamo con forza alla politica di ritemprarlo con risorse e riforme. Noi siamo i clinici della persona, sempre chinati ad accogliere, curare, consolare chi soffre: la politica sia il clinico del nostro Ssn. Perché nessuno, mai, resti solo, resti indietro.
Siamo fieri di avere dalla nostra parte, verso questo obiettivo, i cittadini, la società civile, la Chiesa. Ci rincuorano le parole di papa Francesco, del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Sato della Santa Sede, del ardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei, del vicepresidente monsignor Francesco Savino, che più volte sono stati ospiti ai nostri convegni, di monsignor Giuseppe Baturi, che della Cei è il segretario generale, di monsignor Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute. Parole a sostegno di un Servizio sanitario nazionale equo, uguale, universalistico, solidale. Un Servizio sanitario nazionale dove il medico sia sempre libero di udire, ascoltare, accogliere e prendersi cura del grido di dolore, del lamento, della sofferenza silenziosa, che non ha o non trova parole. Dove questo gemito non sia soffocato dal rumore di fondo di tutte le questioni aperte, dei malfunzionamenti, delle difficoltà organizzative. Dove la persona, il malato, sia protagonista, insieme al medico e agli operatori sanitari, di quell’alleanza terapeutica che è l’essenza stessa della cura.
Siamo fieri di avere dalla nostra parte, verso questo obiettivo, i cittadini, la società civile, la Chiesa. Ci rincuorano le parole di papa Francesco, del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Sato della Santa Sede, del ardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei, del vicepresidente monsignor Francesco Savino, che più volte sono stati ospiti ai nostri convegni, di monsignor Giuseppe Baturi, che della Cei è il segretario generale, di monsignor Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute. Parole a sostegno di un Servizio sanitario nazionale equo, uguale, universalistico, solidale. Un Servizio sanitario nazionale dove il medico sia sempre libero di udire, ascoltare, accogliere e prendersi cura del grido di dolore, del lamento, della sofferenza silenziosa, che non ha o non trova parole. Dove questo gemito non sia soffocato dal rumore di fondo di tutte le questioni aperte, dei malfunzionamenti, delle difficoltà organizzative. Dove la persona, il malato, sia protagonista, insieme al medico e agli operatori sanitari, di quell’alleanza terapeutica che è l’essenza stessa della cura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







