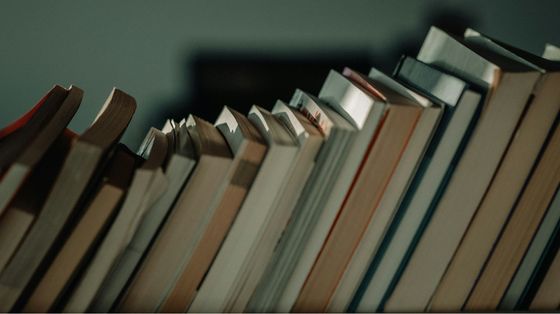Tocca alle vere democrazie difendere il diritto internazionale
Nell'età degli imperi, il rischio del disordine globale è concreto. Dall'Onu all'Europa, le istituzioni possono ancora dare un contributo forte alla costruzione di «comunità di pace»

La guerra di Israele contro l’Iran ha aperto un nuovo scenario della crisi delle relazioni internazionali. Ha distolto anche l’attenzione sull’ultima deriva della presidenza di Donald Trump rispetto ad un principio del diritto internazionale sinora riconosciuto almeno dalle democrazie: l’obbligo di rispettare i diritti umani anche nelle norme e nelle prassi interne agli Stati (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948; Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966). Rimangono dunque questioni aperte davanti alle Corti statunitensi le deportazioni degli immigrati a Guantanamo e l’impiego della Guardia Nazionale contro le provocate manifestazioni di protesta. Un dato è certo: gli Stati Uniti di Trump hanno accantonato il ruolo dell’America baluardo del Rule of Law, e rifiutano il multilateralismo espresso attraverso istituzioni globali come l’Onu. Trump intende primeggiare con l’America First in una nuova era di «dominio imperiale», e in questo sembra fargli comodo il disegno di Israele di resettare il Medio Oriente con la forza. Su Gaza ha ostacolato l’ultima Risoluzione per il cessate il fuoco portata al Consiglio di Sicurezza dagli europei, dando campo libero a Israele ora incoraggiato anche all’escalation contro l’Iran. Per la guerra in Ucraina, dopo i colloqui telefonici con Putin si è limitato a farsi suo portavoce minacciando le rappresaglie russe contro le azioni difensive di Kiev: l’Ucraina è una partita lasciata agli europei. Le responsabilità di Trump sono serie, ma riconducono anche all’uniformarsi alle sfide poste da Russia e Cina ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico internazionale. A partire dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945 (il 26 giugno si celebrerà l’80° anniversario), dovevano essere indissolubili norme che vanno considerate un tutt’uno: la sacralità dei confini, il divieto dell'uso della forza e il rispetto dell'autodeterminazione delle Nazioni.
Si tratta di norme incontestabili per le quali i divieti di «aggressione» e di «annessione» hanno lo status di Ius cogens. Anche la Corte internazionale di giustizia nel Parere consultivo del 19 luglio 2024 sulle «pratiche di Israele nei Territori palestinesi occupati» ha ribadito che la sovranità territoriale non è soggetta a contestazioni giuridiche esterne, ed è quindi illegale, precisando che «il controllo permanente» è proibito, ed è soggetto a limitazioni come qualsiasi “uso della forza’”, secondo le norme dello jus in bello e ad bellum.
Ci si chiede allora cosa fare se sono per prime democrazie e potenze nucleari con potere di veto nel Consiglio di Sicurezza ad ignorare il diritto internazionale, o addirittura a invocarlo secondo distorte letture, come fanno Russia, Israele e Cina: la prima rivendica l’unità del “Mondo russo” e la tutela di minoranze, il secondo la legittima difesa, la terza il diritto di sovranità sull’intero Mar Cinese meridionale. Il diritto internazionale obbliga gli Stati ad agire collettivamente in risposta alle violazioni. La Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che i divieti di annessione e le violazioni dell'autodeterminazione sono obblighi erga omnes, che richiedono a tutti gli Stati di astenersi dal riconoscere o sostenere tali azioni illegali. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la stessa Corte internazionale di giustizia sono le sedi dove la restante comunità internazionale può censurare anche le grandi potenze e promuovere istanze di giustizia.
Si obietta: ma siamo di fronte a grandi potenze che possono prevalere sugli altri Stati con l’uso della forza e la coercizione economica. È il caso allora di guardare al mondo accademico internazionale che (diversamente da quello italiano, spiace ammetterlo) sta dibattendo su questi temi. Per Harold Koh, già docente a Yale, occorre un atto di resistenza, un “processo legale transnazionale” che coinvolga giudici e funzionari di agenzie nazionali e internazionali, società civile, Ong ed associazioni, attori che abbiano la forza di rimanere resilienti contro il populismo e le pressioni delle superpotenze. Ancora si contesta: quando la legge è ignorata dai potenti può capitare che non possa essere efficacemente contrastata, come accade oggi nell’«età degli imperi». Sovviene un altro internazionalista, Eyal Benvenisti, professore di diritto internazionale a Cambridge: secondo lo jus cogens, «il diritto internazionale non muore mai nemmeno durante l’età degli imperi», al massimo può andare in letargo. Da qui l’importanza che giuristi e storici documentino lo stato del diritto così com'è, in attesa di un momento in cui l'ordine globale potrà essere ripristinato. Storia e diritto internazionale hanno una memoria lunga: gli Stati Baltici, ad esempio, hanno riacquistato la loro sovranità dopo cinquant’anni di occupazione sovietica. Lo stesso può e deve accadere se l'Ucraina fosse costretta ad accettare un diktat russo-americano o se i palestinesi fossero costretti a lasciare Gaza. Gli atti unilaterali o gli accordi imposti dagli imperi che si discostano dallo jus cogens - sul diritto all'autodeterminazione e sul divieto dell'uso della forza e delle annessioni - anche per la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 non hanno valore. Ciò che rimane imperativo è che gli Stati rispettosi del diritto internazionale (costituiscono la stragrande maggioranza), gli studiosi e la società civile continuino a sostenerlo, anche quando è oggetto degli attacchi dei nuovi imperi. Universale rimane la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati (New York, 24 ottobre 1970): vi si richiamano i principi di sovranità, eguaglianza e pari dignità degli Stati sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, e si enuncia il principio secondo cui «gli Stati risolvono le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non siano messe in pericolo». Pace, verità e giustizia sono le parole-chiave su cui Papa Leone XIV si è soffermato davanti al corpo diplomatico: ha ricordato che occorre sradicare «ogni distruttiva volontà di conquista» e «ridare respiro alla diplomazia multilaterale e a quelle istituzioni internazionali volute e pensate per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla Comunità internazionale». È l’idea che il teorico della democrazia moderna Hans Kelsen volle concepire per ridare speranza all’umanità dopo la II guerra mondiale: “Pace attraverso il Diritto”(Peace through Law- 1944). Un monito su cui l’Italia farebbe bene a dare un contributo forte, insieme a quella Europa che, a ragione, può proporsi come «comunità di pace e di diritto» rispetto alla logica egemonica e disumanizzante dei nuovi imperi.
Membro dell’International Law Association
Si tratta di norme incontestabili per le quali i divieti di «aggressione» e di «annessione» hanno lo status di Ius cogens. Anche la Corte internazionale di giustizia nel Parere consultivo del 19 luglio 2024 sulle «pratiche di Israele nei Territori palestinesi occupati» ha ribadito che la sovranità territoriale non è soggetta a contestazioni giuridiche esterne, ed è quindi illegale, precisando che «il controllo permanente» è proibito, ed è soggetto a limitazioni come qualsiasi “uso della forza’”, secondo le norme dello jus in bello e ad bellum.
Ci si chiede allora cosa fare se sono per prime democrazie e potenze nucleari con potere di veto nel Consiglio di Sicurezza ad ignorare il diritto internazionale, o addirittura a invocarlo secondo distorte letture, come fanno Russia, Israele e Cina: la prima rivendica l’unità del “Mondo russo” e la tutela di minoranze, il secondo la legittima difesa, la terza il diritto di sovranità sull’intero Mar Cinese meridionale. Il diritto internazionale obbliga gli Stati ad agire collettivamente in risposta alle violazioni. La Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che i divieti di annessione e le violazioni dell'autodeterminazione sono obblighi erga omnes, che richiedono a tutti gli Stati di astenersi dal riconoscere o sostenere tali azioni illegali. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la stessa Corte internazionale di giustizia sono le sedi dove la restante comunità internazionale può censurare anche le grandi potenze e promuovere istanze di giustizia.
Si obietta: ma siamo di fronte a grandi potenze che possono prevalere sugli altri Stati con l’uso della forza e la coercizione economica. È il caso allora di guardare al mondo accademico internazionale che (diversamente da quello italiano, spiace ammetterlo) sta dibattendo su questi temi. Per Harold Koh, già docente a Yale, occorre un atto di resistenza, un “processo legale transnazionale” che coinvolga giudici e funzionari di agenzie nazionali e internazionali, società civile, Ong ed associazioni, attori che abbiano la forza di rimanere resilienti contro il populismo e le pressioni delle superpotenze. Ancora si contesta: quando la legge è ignorata dai potenti può capitare che non possa essere efficacemente contrastata, come accade oggi nell’«età degli imperi». Sovviene un altro internazionalista, Eyal Benvenisti, professore di diritto internazionale a Cambridge: secondo lo jus cogens, «il diritto internazionale non muore mai nemmeno durante l’età degli imperi», al massimo può andare in letargo. Da qui l’importanza che giuristi e storici documentino lo stato del diritto così com'è, in attesa di un momento in cui l'ordine globale potrà essere ripristinato. Storia e diritto internazionale hanno una memoria lunga: gli Stati Baltici, ad esempio, hanno riacquistato la loro sovranità dopo cinquant’anni di occupazione sovietica. Lo stesso può e deve accadere se l'Ucraina fosse costretta ad accettare un diktat russo-americano o se i palestinesi fossero costretti a lasciare Gaza. Gli atti unilaterali o gli accordi imposti dagli imperi che si discostano dallo jus cogens - sul diritto all'autodeterminazione e sul divieto dell'uso della forza e delle annessioni - anche per la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 non hanno valore. Ciò che rimane imperativo è che gli Stati rispettosi del diritto internazionale (costituiscono la stragrande maggioranza), gli studiosi e la società civile continuino a sostenerlo, anche quando è oggetto degli attacchi dei nuovi imperi. Universale rimane la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati (New York, 24 ottobre 1970): vi si richiamano i principi di sovranità, eguaglianza e pari dignità degli Stati sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, e si enuncia il principio secondo cui «gli Stati risolvono le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non siano messe in pericolo». Pace, verità e giustizia sono le parole-chiave su cui Papa Leone XIV si è soffermato davanti al corpo diplomatico: ha ricordato che occorre sradicare «ogni distruttiva volontà di conquista» e «ridare respiro alla diplomazia multilaterale e a quelle istituzioni internazionali volute e pensate per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla Comunità internazionale». È l’idea che il teorico della democrazia moderna Hans Kelsen volle concepire per ridare speranza all’umanità dopo la II guerra mondiale: “Pace attraverso il Diritto”(Peace through Law- 1944). Un monito su cui l’Italia farebbe bene a dare un contributo forte, insieme a quella Europa che, a ragione, può proporsi come «comunità di pace e di diritto» rispetto alla logica egemonica e disumanizzante dei nuovi imperi.
Membro dell’International Law Association
© RIPRODUZIONE RISERVATA