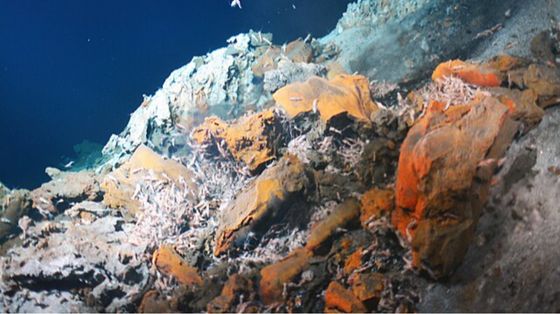A Gaza una tregua che non disarma
L’amara verità è che la sospensione delle azioni militari israeliane serviva anche a soddisfare il desiderio del presidente Usa Trump di apparire come il risolutore dei conflitti internazionali

Ma non era infine finita la guerra crudele e sanguinosa di Gaza? Non avevano suonato in mondovisione le fanfare volute dal presidente Trump per celebrare una “pace eterna”? Le opinioni pubbliche internazionali non avevano tirato un sospiro di sollievo, dopo due anni di stragi di civili inermi e di immagini scioccanti? Dobbiamo noi europei ancora parlare di Gaza quando le tensioni con la Russia e la febbre del riarmo ci spingono a guardare solo a cosa avviene alle nostre frontiere orientali? Sì, dobbiamo ancora sollevare lo sguardo e guardare alle sofferenze di milioni di palestinesi che sopravvivono a stento fra le macerie in cui è ridotta la Striscia. Perché l’amara verità è che – come temuto fin dal primo momento – la fragile, pasticciata e squilibrata sospensione delle azioni militari israeliane serviva anche a soddisfare il desiderio del presidente Usa Trump di apparire come il risolutore dei conflitti internazionali e a lavare le coscienze occidentali. Mentre i pilastri su cui andare a costruire una pace vera rimangono del tutto fragili e pericolanti.
Il governo di ultradestra israeliano non voleva e non vuole la fine del conflitto, anzi dei conflitti, dato che non ha mai smesso – in questi mesi – di bombardare a Gaza, in Siria e in Libano. Né ha posto un freno al terrorismo crescente dei coloni ebraici in Cisgiordania, che attaccano impunemente i villaggi palestinesi e distruggono i loro campi e uliveti. Allo stesso tempo, non si è trovato il modo di disarmare Hamas: un movimento certo indebolito e ferito, profondamente diviso al proprio interno, ma ben radicato nei gangli di potere della Striscia, che non intende rinunciare al suo controllo e che riesce a rintuzzare i tentativi delle altre milizie, spesso sostenute e armate da Tel Aviv, di cacciarla dalla Striscia. E ovviamente non si è concretizzata quella missione militare internazionale che doveva controllare Gaza e demilitarizzarla: molti stati non vogliono ritrovarsi intrappolati in un progetto senza possibilità di successo, mentre chi sarebbe disposto a farlo – come la Turchia – subisce il veto di Israele. Tanto meno si è avviata la ricostruzione: le monarchie arabe del Golfo non vogliono metterci un soldo, se Israele non smette di bombardare e se non si avvia il percorso per uno stato palestinese, tanto più che nella zona controllata dallo Stato ebraico i bulldozer continuano a radere al suolo quel che resta degli edifici. I valichi funzionano a singhiozzo, dato che si usa ogni pretesto per bloccare gli aiuti, mentre non tramonta il sogno dell’ultradestra di spingere i palestinesi fuori dalla Striscia.
Certo, sempre meglio questa “non pace”, questa finta tregua di una guerra vera e propria, che ha portato all’uccisione di più di settantamila palestinesi. E del resto, l’idea stessa che la pace si potesse scrivere su un pezzo di carta da far firmare in diretta televisiva era un’illusione sciocca: la pace è un percorso che va cercato e costruito giorno per giorno, a tutti i livelli, da quello diplomatico a quello del vivere quotidiano sul terreno, da quello militare a quello educativo. Un lavoro lungo e paziente, da “artigiani della pace”, come diceva Francesco. Il problema, tuttavia, è che questo lungo e faticoso cammino bisogna avere il desiderio di percorrerlo: nulla può essere ottenuto, se chi deve guidare vuole con crudele determinazione percorrere una strada opposta. Che è esattamente quanto sta avvenendo, con il governo di Tel Aviv e con Hamas. Anche se, spiace dirlo, lo stallo attuale è soprattutto frutto della determinazione a minare ogni tentativo di Bibi Netanyahu e dei suoi ministri estremisti. Lo ha sottolineato con grande chiarezza papa Leone nel suo recente viaggio in Turchia e Libano, quando ha detto che nessuna pace è possibile se non si riconosce il diritto di entrambi i popoli ad avere il loro Stato. Cosa negata con determinazione da un Israele sempre più attraversato da spinte radicali. All’Europa interessava soprattutto spingere Tel Aviv a fermare le stragi, dato che le politiche ambigue ed esitanti della maggior parte dei nostri governi stavano esasperando le opinioni pubbliche e, purtroppo, rinfocolando i fantasmi pericolosi dell’antisemitismo, un demone che noi europei conosciamo fin troppo bene. Ma ancora una volta, ci siamo rifugiati nell’aiuto spicciolo alle popolazioni e nell’evacuare bambini feriti. Azioni meritorie, ma che non bastano a bilanciare un’afonia politica e diplomatica evidente. Sapevamo fin dall’inizio che spenti i riflettori Washington avrebbe guardato altrove. Dovevamo essere noi del Vecchio Continente a rilanciare lo sforzo diplomatico per guidare la ricostruzione. Non è troppo tardi per cercare di farlo: i valori in cui crediamo non possono solo restare scritti nelle nostre dichiarazioni formali, ma vanno buttati, con coraggio, in mezzo al fango e alle macerie dell’inverno di Gaza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi