Ragazzi fragili, ecco perché oggi la giustizia rischia di dimenticarli
di Luciano Moia
La sentenza di ieri della Corte costituzionale rende il nostro diritto minorile sempre più strabico. Nel processo penale “protegge” gli educatori, nel civile la riforma Cartabia vuole cancellarli

Tra minori e giustizia il solco è sempre più profondo. Difficile parlare in modo diverso di un diritto minorile sempre più strabico, che guarda all’ordinamento civile con gli occhiali imposti dalla riforma Cartabia e a quello penale con quelli della sentenza depositata ieri dalla Corte costituzionale. Non si tratta di una questione per addetti ai lavori, ma di un aspetto sostanziale che riguarda i giudici onorari, cioè quei professionisti delle scienze umane (neuropsichiatri, psicologi, pedagogisti, educatori) che affiancano il giudice togato in una prospettiva interdisciplinare e intervengono in tutti quegli aspetti in cui la complessità delle situazioni impedisce di valutare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie soltanto sulla base di norme interpretate in modo asettico. La loro presenza è fondamentale per dare spessore umano alle realtà, sempre dense di sofferenza, in cui sono coinvolti minori e famiglie. La riforma Cartabia, come più volte sottolineato, ha invece limitato fortemente la loro presenza, trasformandoli da giudici in semplici collaboratori per quanto riguarda l’ambito definito “ufficio del processo”. Gli “onorari” non potranno più fare parte di un collegio giudicante né avere ruoli rilevanti nelle fasi istruttorie, soprattutto per i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale. Quando, cioè, si tratta di valutare se sospendere o cancellare la responsabilità di un genitore nei confronti di un figlio. Capita, per esempio, nei casi di abuso, abbandono, maltrattamento, riconosciuta incapacità educativa. Dove cioè ci sono bambini fragili e famiglie in difficoltà.
Ma se i giudici onorari sono stati lasciati ai margini del processo civile, in quello penale il loro ruolo è fuori discussione. La riforma Cartabia ha evitato di affrontare la questione, perché c’era già una sentenza della Corte costituzionale, la n.1 del 2015 che salvaguardava il ruolo dei giudici onorari nel processo penale minorile. A fugare ogni dubbio è arrivata ieri una nuova sentenza della Consulta, la n.23/2025, a proposito della legittimità costituzionale del decreto Caivano. Nel 2015 il caso era stato sollevato dall'allora presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, Pino Spadaro. In questa occasione, in riferimento agli articoli 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, il caso è stato messo in evidenza da Giovanni Gallo, giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento. Dove Spadaro (nella foto qui sotto) è presidente da un paio d’anni. Cosa hanno detto in sostanza i giudici della Consulta? Il comunicato diffuso spiega che «la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 della disposizione censurata, per violazione dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui indica "giudice per le indagini preliminari", anziché "giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)"». Significa che per la messa alla prova di un minore «si richiede la composizione pedagogicamente qualificata dell'organo giudicante, quindi un collegio integrato dagli esperti educatori.
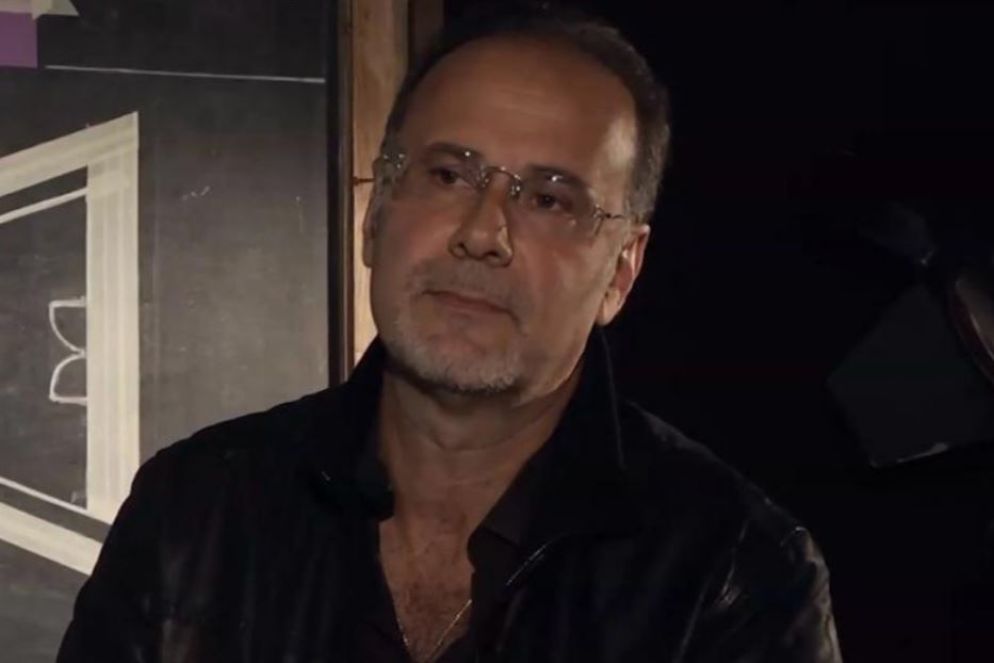
I giudici hanno poi respinto altre questioni sollevate dal giudice di Trento, salvando in sostanza il decreto Caivano - «la norma contestata "si sottrae alla richiesta di ablazione radicale”» - che qui ci interessa poco approfondire. L’aspetto rilevante rimane la sottolineatura riferita al ruolo del collegio giudicante – giudici togati e onorari insieme – che non potrà essere sostituito da un giudice monocratico, come invece prevede la riforma Cartabia per l’ordinamento civile. Ma che coerenza ci può essere in un impianto giuridico che attribuisce un rilievo fondamentale alla “composizione pedagogicamente qualificata” nel penale e lo nega nel processo civile? Anche in considerazione del fatto che nel civile la valutazione è ancora più complessa e delicata, perché non si tratta di stabilire se un ragazzo è più o meno colpevole, ma occorre valutare la sua situazione in rapporto alle dinamiche familiari e al quadro sociale.
Un aspetto che aggiunge nuovi interrogativi alla riforma Cartabia. Sulla questione, nei giorni scorsi, c’è stato un altro intervento dell’associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia (Aimmf). In un lungo comunicato firmato dal presidente Claudio Cottatellucci e dal segretario nazionale Anna Maria Casaburi, si rimettono in fila gli errori dell’impianto e si tornano a sottolineare le conseguenze negative della «progressiva estromissione della magistratura onoraria dai procedimenti sulla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art.330 e 333 c.c.». Un errore, ripetono i magistrati minorili, perché «la scelta di affidare la trattazione di questi procedimenti a un giudice monocratico nella sezione circondariale determinerebbe, per la perdita della collegialità e della multidisciplinarietà, un grave vulnus al sistema delle tutele necessarie». Una perdita che non potrà essere compensata dal moltiplicarsi delle consulenze tecniche d’ufficio (ctu) che già ora sono oltre 50mila l’anno e incidono pesantemente sui costi. Inoltre – si fa notare – quando saranno definitivamente accantonati gli attuali 770 giudici onorari, serviranno almeno 250 nuovi giudici togati. E come potranno essere assunti se la riforma Cartabia, come più volte ribadito, dev’essere a costo zero? Una finzione, sostengono i giudici minorili, perché in un anno i costi sarebbero lievitati tra i 20 e i 25 milioni. Si sottolineano poi le condizioni di lavoro delle procure minorili che, alla luce della riforma, «non sono ormai in grado, nella maggioranza dei casi, di partecipare attivamente allo svolgimento del processo e in molte situazioni debbono limitarsi alla presentazione del ricorso iniziale e alla formulazione del parere conclusivo». Una situazione non casuale che, secondo l’Aimmf, è il segno più evidente «della tendenza alla privatizzazione del processo minorile che rappresenta l’opzione di fondo che sorregge la riforma». Insomma, servono modifiche urgenti da introdurre nell’impianto della riforma che, per quanto riguarda la parte processuale, è entrata in vigore da circa due anni, mentre per quella ordinamentale (cioé la sostituzione degli attuali Tribunali per i minorenni con i nuovi Tribunali per la famiglia e per la persona) si andrà all’ottobre 2025. A meno che l’impossibilità economica di assumere altri 433 magistrati - secondo l’ultima stima trasmessa dal Ministero al Csm - per istituire le sole sezioni circondariali, imponga un nuovo slittamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







