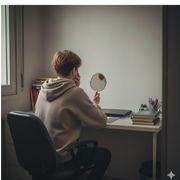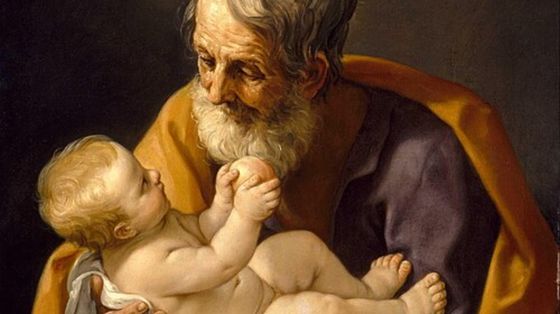La famiglia non è mai "fatto privato"
di Luciano Moia
Il filosofo Vincenzo Rosito: concetti come abitare, convivere, migrare, prendersi cura aiutano a ridefinire il ruolo sociale della famiglia, oltre la visione dualistica tra la “nostra casa” e il m

Cosa diciamo in realtà quando indichiamo la famiglia come realtà sociale? Quanto contano i vissuti di ogni famiglia per costruire quel sapere condiviso che, in ogni comunità, si trasforma in storia di apprendimento come risorsa collettiva? Come cambiano i rapporti di parentela? E la dimensione dell’abitare intesa non solo come scelta di ogni singolo nucleo familiare ma come condizione che investe gli spazi della realtà urbana, in un quadro di “convivenza” allargata? E poi il grande snodo dell’immigrazione, inteso come rapporto tra le famiglie che restano e quelle che arrivano da noi dalle zone più disagiate del mondo, comprese le vicende delle decine di migliaia di persone che si spostano in Occidente per provvedere al lavoro di cura in altre famiglie, ma così facendo lasciano vuoti difficile da colmare nelle proprie famiglie. Sono alcuni dei temi affrontati da Vincenzo Rosito, docente di Storia e cultura delle istituzioni familiari presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio, nel libro Famiglia e apprendimento sociale. Nuovi orizzonti di ricerca (Studium, Roma 2025). Si tratta di un testo che nasce anche dall’esigenza di rinnovare in chiave partecipativa e collaborativa gli studi interdisciplinari sulle famiglie contemporanee. Non solo riflessioni sulle realtà familiari e sulle loro trasformazioni, ma anche indicazioni su come “studiare insieme” le famiglie oggi.
Professor Rosito, perché è importante studiare i processi che fanno della famiglia una “scuola di apprendimento sociale”?
Essere famiglia è “ricordarsi di aver vissuto insieme”. Questa definizione mi piace molto perché descrive la famiglia non solo come un luogo in cui impariamo a fare le cose più importanti e utili per la vita, ma soprattutto perché descrive le famiglie come contesti che hanno una “storia di apprendimento”. Essere famiglia significa entrare a far parte di questa storia e riconoscersi in essa. Questa prospettiva è in grado di trasformare lo sguardo e il punto di osservazione sulle famiglie contemporanee. Alla luce dell’apprendimento sociale infatti, anche i “fallimenti” possono essere letti come “tentativi faticosi”, passi del vivere quotidiano, passaggi nella tessitura delle “trame familiari”. Ogni famiglia è portatrice di una “storia di apprendimento” la cui bontà può essere verificata innanzitutto chiedendosi se le vite di ogni membro sono fiorite; se si sono arricchite durante il cammino degli anni; se le persone, vivendo insieme ai loro familiari, hanno tirato fuori il meglio della loro umanità. La famiglia, ogni famiglia è prima di tutto «una scuola di arricchimento umano» ( Gaudium et Spes, 52). Questo libro nasce nel contesto della comunità accademica del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, grazie al contributo di molti colleghi e studenti. Anche l’essere parte di un “corpo accademico” (comunità di studio e di ricerca) vuol dire sentirsi membro di una comune storia di apprendimento. Per questo è importante “saper ricostruire” la traiettoria o il percorso di crescita che ciascuno ha fatto in famiglia o nelle comunità di studio di cui è stato parte.
Nel libro si mette in grande rilievo il cosiddetto “orizzonte della parentela”, con le tante implicazioni connesse. Ma con nuclei familiari sempre più piccoli e con relazioni parentali sempre più esigue, come è destinato a cambiare questo “orizzonte”?
Le relazioni di parentela cambiano non esclusivamente in relazione al numero dei membri di ogni famiglia. Le attuali trasformazioni delle forme di parentela dipendono da almeno altri due fattori: l’estensione e l’intensità. Le relazioni tra parenti assumono significati nuovi anche perché i membri di molte famiglie sono lontani per lavoro o altre necessità. In tal caso i legami parentali si “stirano”, ridisegnando nuove geografie degli affetti. Le famiglie transnazionali sono sempre “famiglie ricomposte”, i loro membri devono riassemblare creativamente gli spazi e i linguaggi delle relazioni familiari o dell’intimità di coppia Indagando la complessità dell’abitare, lei sottolinea la necessità di studiare la differenza tra “abitare dentro” e “abitare attorno”. Come leggere questo rapporto? Ci siamo abituati all’idea che l’abitare sia una tecnica organizzativa degli spazi interni intesi come spazi della vita intima o appartata. Non a caso chiamiamo “appartamenti” i moduli abitativi maggiormente usati per la vita familiare. Eppure, conduciamo le nostre vite non solo “dentro” le case, ma anche “attorno” a esse, negli spazi che definiamo comuni, nelle aree pubbliche delle nostre città. Dovremmo riscoprire l’abitare come l’insieme delle “pratiche progettuali della convivenza”. Ecologicamente siamo tutti e tutte conviventi su questo pianeta. La convivenza non è solo ciò che accade quando una coppia decide di “farsi una casa”.
Tra le ritualità della famiglia, descrive in modo molto efficace i tradizionali incontri a tavola, in occasione di eventi particolari o per le festività di Natale e di Pasqua. Tut-tavia, mette l’accento sull’incompletezza che, come lei scrive, sarebbe “il piatto forte di ogni riunione familiare”. Perché ha scelto questo punto di osservazione?
In ogni riunione familiare c’è qualcuno che manca. Si tratta spesso di una persona indesiderata, in molti casi lontana o allontanata: è la “pecora nera” di ogni famiglia. In queste occasioni festose la memoria di chi è assente diventa una questione o ancora meglio un compito per quella famiglia. Il biblista francese Philippe Lefebvre afferma che la famiglia è prima di tutto un gruppo in cui si fa memoria dei dimenticati. Spesso la convivenza familiare produce persone volontariamente allontanate, bandite. La memoria di costoro viene a farci visita inevitabilmente nel mezzo di ogni banchetto familiare. Anche questa esperienza di incompletezza familiare è un’occasione di ricomposizione e rinascita, è un’occasione di apprendimento.
Le famiglie costrette a migrare, a cui lei dedica un approfondimento di grande interesse, rappresentano una risorsa o un problema, per le famiglie che invece “restano”? E in quali condizioni si può immaginare una contaminazione positiva tra i diversi gruppi familiari?
Dovremmo studiare ancora più attentamente come la vita familiare sta cambiando in relazione alla “mobilità umana”. Viaggiamo sempre più frequentemente e velocemente. Sono “vite mobili” non solo quelle di chi emigra, ma anche quelle di chi resta. Nel libro analizzo le cosiddette “catene globali della cura” ovvero quelle situazioni in cui donne lavoratrici lasciano la propria famiglia per svolgere un lavoro di cura, in un altro Paese. Mentre si prendono cura di altre donne anziane, costoro hanno bisogno che le loro stesse madri o sorelle si prendano cura della famiglia che hanno lasciato a casa. Questa situazione manifesta l’interconnessione affettiva ed economica di molte lavoratrici, disvelando allo stesso tempo i processi di trasformazione della maternità. La realtà della maternità o della paternità transnazionale riguarda tutti. Ognuno di noi è sicuramente entrato in contatto con un papà o una mamma che hanno lascito la loro famiglia altrove.
Famiglia significa anche, soprattutto in alcuni momenti della vita, “prendersi cura”. Come è destinato a cambiare questo concetto nelle famiglie della postmodernità?
Sogno una società in cui la cura non sia solo medicalizzata, non sia necessariamente a pagamento e dove tutti possono prendersi cura di tutti. La cura non è un gesto “rimediale”, utile cioè a riparare il mondo. È invece il terreno delle utopie contemporanee. Il pensiero autenticamente utopico e trasformativo si trova oggi nelle pratiche di cura intese come gesti capaci di trasformare anche i sistemi sociali, politici ed economici.
A un certo punto lei scrive: “È tempo di superare radicalmente la concezione dualistica e riduzionistica del binomio famigliasocieta”. Possiamo spiegare da dove nasce questa necessità?
Famiglia non è sinonimo di privato! Anche le relazioni familiari sono un modo di composizione del comune. Per contrastare la deriva del familismo bisogna promuovere la visione di una “famiglia socialmente trasformativa”. Le famiglie cristiane ad esempio dovrebbero partecipare alla vita pubblica e sociale non per difendere i diritti esclusivi dei loro membri, ma per contribuire alla gestione dei beni comuni (ambiente, sanità e istruzione pubblica). Recentemente il sociologo francese Christian Laval ha detto che «i beni comuni sono le istituzioni di base dei mondi in costruzione».
Insomma, siamo di fronte a un “laboratorio familiare” che va continuamente aggregandosi e riaggregandosi e che quindi non è di facile lettura. Anche se il tema non è compreso in modo esplicito nel suo libro, le chiedo: ma la Chiesa in tutto questo come c’entra? Come ripensare a un progetto di pastorale familiare in tutta questa complessità?
Il laboratorio pastorale della famiglia è la sinodalità. Non c’è bisogno di calare nuove iniziative sulla testa delle famiglie. Possiamo invece entrare nei processi sinodali in cui apprendiamo “con” le famiglie. L’apprendimento è ancora una volta la chiave di una trasformazione possibile. L’apprendimento sociale è la prospettiva più efficace per prendersi cura della famiglia in una Chiesa sinodale. Le famiglie sono infatti «un luogo privilegiato per apprendere e sperimentare le pratiche essenziali di una Chiesa sinodale» ( Documento Finale della XVI Assemblea del Sinodo dei Vescovi, 35).
© RIPRODUZIONE RISERVATA