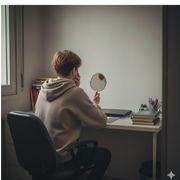Associazioni familiari, vince l'alleanza di vicinato
Emergono tra i nuclei familiari nuovi modelli di aggregazione che non fanno riferimento ai grandi scenari, ma più spesso al territorio, scelte meglio percorribili per i bisogni della vita quotidiana

Torniamo a dare spazio ad alcuni tra gli spunti più interessanti emersi al convegno organizzato dalla Fafce (Federazione delle associazioni familiare cattoliche in Europa) in occasione del Giubileo delle famiglie. Il titolo dell’incontro, “Le reti familiari per il futuro della Chiesa”, si proponeva di mettere al centro dell’attenzione il tema dell’associazionismo familiare. La proposta forte emersa dal dibattito è stata quella di immaginare un coordinamento mondiale delle associazioni. Qui sotto ampi stralci della proposta presentata da Francesco Belletti, direttore del Cisf.
«Non è bene che la famiglia sia sola». Anche per la famiglia rimane vera questa irrinunciabile premessa antropologica, a partire dall’idea di persona iscritta nel messaggio biblico. Proprio il racconto della Genesi, infatti, parte da una relazione fondativa primaria, l’essere “creatura”. L’azione creatrice di Dio rende ciascuno di noi persona, ma prima di tutto ci fa figli, perché nessuno si mette al mondo da solo, per propria volontà, ma dipende da un Altro – in questo caso con la “A” maiuscola, fin “dal principio” della storia dell’umanità. Così questa dipendenza diventa costitutiva dell’umano. Ho bisogno di un Tu per essere Io, di un “altro” indispensabile, anche se con la “a” minuscola. E infatti all’uomo nel Giardino viene data la donna (e alla donna l’uomo): un’altra relazione, generativa della pienezza della persona (“finalmen-te”!, dice Ad’am), ma anche indispensabile per interagire con la realtà: niente bastava all’essere umano, tra tutte le meraviglie del Creato, prima che ci fosse un ”tu”. Proprio da questa relazione sorge anche il compito “sovrumano” di contribuire alla creazione, diventando generatori di vita nei figli, e insieme custodi del Creato (generare e custodire, altre due parole ben poco di moda, nella contemporaneità).
Da notare che qui superare l’umano significa essere al servizio di un’altra vita che nasce; il contrario del transumano della contemporaneità, che è totalmente autoreferenziale all’individuo in se stesso (trascendere solo in sé il proprio sé – io basto a me stesso). In breve, tutto l’umano passa dalle relazioni, anche se l’uomo contemporaneo ormai sembra rifiutarle, come «impedimenti della propria libertà». Ma in effetti, come ricorda Pierpaolo Donati, «le relazioni sociali sono come la luce. Noi non vediamo la luce, vediamo con la luce e mediante la luce. Senza la luce non vediamo nulla. Così è per le relazioni. Di per sé le relazioni sono invisibili e immateriali, come la luce, ma sono la realtà che ci fa vedere gli altri e il mondo. Senza le relazioni saremmo tutti delle monadi isolate, esseri senza finestre sul mondo. Dunque noi vediamo con le relazioni e attraverso le relazioni» (Pierpaolo Donati, Studi Cattolici, n. 760, giugno 2024).
Emerge qui un primo grande compito culturale del mondo cattolico, nel mondo dei media, della ricerca e delle università: offrire all’umanità (e alla Chiesa stessa) argomentazioni ragionevoli ed evidenze empiriche che la vita delle persone – e delle famiglie – è intessuta prima di tutto di relazioni, prima ancora degli elementi visibili e strutturali più rilevabili (come le strutture familiari, le politiche, i ruoli all’interno della comunità). E queste relazioni vanno ricercate intenzionalmente ed osservate, perché è difficile osservare qualcosa che non si vuole vedere; così, se non ci si interroga sulle relazioni, non si raccoglieranno neanche informazioni sulla loro rilevanza – perché, come la luce, e un po’ provocatoriamente, «la relazione c’è, ma non si vede».
Anche la famiglia, intessuta e costituita per sua stessa natura da speciali relazioni tra le persone, ha assoluto bisogno di relazioni al di fuori di sé, con il mondo esterno. Ha bisogno di una comunità a cui appartenere, di compagni di viaggio con cui camminare, di pezzi di realtà da trasformare (con il lavoro, con l’abitare, nell’incontro con gli altri). In particolare ogni famiglia è chiamata ad essere anche soggetto sociale, generatrice di bene comune, non solo nel contesto sociale (famiglia cellula fondamentale della società), ma in modo ancora più rilevante all’interno della Chiesa: Chiesa di famiglie, perché costruita dalle famiglie, nelle case e nelle relazioni educative interne, così come nella trasmissione di valori, fede e virtù personali e sociali.
Si può descrivere questo compito generativo della famiglia nel contesto comunitario come un percorso di relazioni concentriche allargate, dalla persona alla società. Un primo livello di responsabilità della famiglia verso il bene comune riguarda il compito educativo, come costruzione del bene della singola persona. Si tratta di far crescere persone vere, adulte, persone «responsabili», potremmo anche dire «costruttori di bene e di pace». Una «cura del bene della persona» che dovrà essere capace di introdurla non solo alla propria autorealizzazione, ma anche alla responsabilità per la costruzione del bene comune. Il secondo livello riguarda la costruzione di “legami buoni” tra i propri membri, di reciprocità e gratuità. Del resto se la prospettiva del familiare non è costruire “legami buoni”, di fiducia e lealtà, la famiglia tradisce se stessa, e diventa una trappola, uno spazio che imprigiona, che distrugge le persone.
Il terzo livello di responsabilità sta nella capacità di aprire queste “buone relazioni” ad altre persone, non ponendosi come un territorio liberato dai confini chiusi, ma pensandosi come un ambito di buona vita da poter condividere con altre persone. È quanto molte famiglie stanno concretamente realizzando con le molte forme di accoglienza familiare e di solidarietà oggi presenti a livello nazionale ed internazionale (adozione internazionale, accoglienza di minori migranti, ospitalità, scambi di aiuto). Un quarto livello di responsabilità può essere sinteticamente definito “fare famiglia insieme” ad altre famiglie, associandosi in modo stabile. Le famiglie diventano così soggetti sociali collettivi, che cominciano ad avere voce, che generano auto e mutuo aiuto, che si mettono insieme per “produrre più famiglia” (servizi, relazioni, esperienze di condivisione), ma anche per contare di più, per organizzarsi, per fare lobbying, pressione, protesta.
Da ultimo, come ulteriore estensione del quarto livello di generatività sociale della famiglia, l’interazione e la collaborazione tra le varie associazioni (come nel Forum delle associazioni familiari) costituisce un ulteriore passaggio di responsabilizzazione nei confronti del bene comune. La capacità di costruire una voce e una progettualità unitarie a partire dalla diversità di carismi e di caratteristiche delle varie associazioni di famiglie genera infatti una incisività ed una efficacia molto maggiore, di fronte alla po-litica, all’economia, al sistema dei media.
Emergono infine, oggi, nuove modalità informali di connessione/aggregazione tra famiglie, più piccole, più direttamente collegate ad uno specifico territorio, che in genere corrisponde al territorio di riferimento delle famiglie stesse (più un quartiere che l’intera città, più una parrocchia che una diocesi), sempre fortemente intrecciate a bisogni di vita quotidiana. Oggi molte famiglie sembrano preferire forme non tradizionali di aggregazione, costruendo “reti interfamiliari” di relazioni corte/brevi, che preferiscono restare più vicine ai codici relazionali della famiglia che a costruirsi come “strutture organizzate della società” (ad esempio nella coabitazione/ cohousing, nelle relazioni di vicinato, attorno a specifici bisogni condivisi).
La qualità relazionale dentro le singole famiglie e tra le famiglie, nelle loro relazioni “corte”, quindi, sembra contare di più del ruolo sociale, del compito di rappresentanza nel dibattito pubblico e persino della possibilità di ricevere sostegno, riconoscimento e interazione con il sistema sociale esterno, che si tratti della comunità civile o delle forme aggregative ecclesiali.
Direttore Cisf (Centro internazionale studi famiglia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA