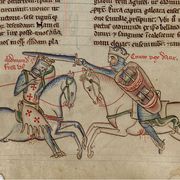Forma e anima dei Conclavi in otto secoli di storia
Nel suo ultimo saggio Melloni mostra come quest’assemblea adatti procedure e intenti al bisogno sempre nuovo di dare un pastore alla Chiesa universale

Anche in questo 2025, il Conclave con le sue antiche e rigide norme di ingaggio e di accesso – che dal 1274 ad oggi quasi ogni Pontefice ha modificato, da ultimo Benedetto XVI – ha dato buona prova di sé: in 24 ore, con probabilmente 4 scrutini, è salito al soglio di Pietro l’8 maggio scorso, papa Leone XIV. Primo statunitense e primo frate agostiniano: il cardinale Robert Francis Prevost. Di questo è convinto lo storico del Cristianesimo Alberto Melloni. E un volume scritto proprio da questo studioso, discepolo diretto di Giuseppe Alberigo e in libreria da poche settimane Il conclave e l’elezione del papa. Una storia dal I al XXI secolo (Marietti 1820, pagine 470, euro 29,00; anche in versione ebook, euro 19,90) racconta con una documentazione inedita ma anche articolata e per certi versi “audace” come avviene e si celebra realmente l’elezione del vescovo di Roma dentro il severo recinto michelangiolesco della Cappella Sistina in Vaticano. Tra i pregi e tra gli elementi più suggestivi di questa ricerca c’è il ritornare con fonti di prima mano sui Conclavi più recenti: quelli che portarono all’elezione del bavarese e teologo di fama internazionale Joseph Ratzinger (Benedetto XVI) nel 2005 e del gesuita argentino (primo ignaziano a salire sulla Cattedra di Pietro) Jorge Mario Bergoglio (Francesco) nel 2013. Tra gli elementi “dirompenti” di novità dell’elezione di papa Leone e di natura non squisitamente geopolitica non presenti per ovvi motivi all’interno di questo solido saggio (uscito a inizio di aprile di quest’anno, cioè prima della morte di Bergoglio) vi è anche questo: non era mai accaduto, in anni recenti, che a un gesuita succedesse sul “trono” di Pietro un altro religioso: l’agostiniano Prevost. L’elezione, infatti, di Bergoglio nel 2013 rappresentò un primato non solo per essere stato il primo gesuita e primo sudamericano a salire sul soglio di Pietro ma la sua elezione interrompeva una catena ininterrotta di Vescovi di Roma appartenenti al clero secolare. L’ultimo Papa proveniente da un Ordine religioso, prima di Bergoglio, è stato il monaco benedettino camaldolese Bartolomeo Alberto Cappellari (bellunese come Albino Luciani, ovvero Giovanni Paolo I), Gregorio XVI eletto Papa (e penultimo sovrano dello Stato della Chiesa prima di Pio IX) nel lontano 1831. Il saggio è un libro che ci aiuterà anche a comprendere in nuce – è la convinzione dello storico delle religioni Melloni e padre nobile del concetto di “ermeneutica della discontinuità” impressa da un evento a giudizio di questo autore epocale e di rottura rispetto al passato come il Concilio Vaticano II voluto, guarda caso, dal suo papa del cuore Giovanni XXIII – e così a tracciare quasi il passaggio ideale di testimone tra i due Successori di Pietro Francesco e Leone: il primo proveniente da un grande Ordine con una gerarchia di tipo militare, molto internazionale e capillare per la sua presenza nel mondo e il secondo appartenente a un Ordine mendicante, sorto nel 1244, con un’impronta più collegiale nel suo governo gerarchico e che ha fatto del pensiero del padre e dottore della Chiesa, vissuto tra il 354 e il 430, Agostino di Ippona (ispiratore ma non fondatore diretto come nel caso dei gesuiti con Ignazio di Loyola) la sua ragion d’essere. Dentro le pieghe di questo libro si ritorna alla nascita dell’istituto del Conclave, per come lo conosciamo dal XIII secolo, con le sue regole di accesso rigide come l’essere cardinali, il dover per forza raggiungere maggioranze qualificate di due terzi per designare il successore di Pietro e il rispetto dell’intervallo di dieci giorni dalla morte del Papa. Ma nel volume si scopre molto di più rispetto a questa elezione «sotto chiave» del principe degli apostoli cioè Pietro, come ha ben argomentato nei suoi studi la storica modernista Maria Antonietta Visceglia. Affiora, per esempio, da questa indagine, che attraverso la bolla di Sisto V Postquam verus il corpo elettorale del Collegio cardinalizio dal 1585 al 1963 (cioè, fino all’elezione di Paolo VI) era composto da 70 porporati e rimane invariato nel suo numero dei suoi membri fino a quella data. Il Collegio cardinalizio cambierà il suo volto anche con una marcatura sempre più internazionale e meno italiana (già avviata da Pio XII) con la “riforma” voluta da Paolo VI con la Costituzione apostolica del 1975 Romano Pontifici eligendo portando il tetto degli elettori a 120. Un corpo elettorale di 120 cardinali elettori che sarà “sforato” per volere di papa Francesco Conclave che ha visto la partecipazione al voto del suo Successore di ben 133 porpore (tutte ovviamente sotto gli 80 anni). Dentro queste pagine vengono a galla le «risonanze creative » di ogni Romano Pontefice come quella di Pio XII che non fece più cardinali dal 1953 e si privò della figura del Segretario di Stato (l’ultimo fu nel 1944 Luigi Maglione) per 14 anni, cioè fino alla sua morte avvenuta nel 1958. O ancora pensando a queste «risonanze creative» emerge la scelta di Francesco che rompendo una tradizione consolidata nei secoli non ha concesso la berretta rossa dei cardinali ai vescovi titolari di sedi antiche come Venezia, Milano o Parigi. Dentro le maglie di questo saggio si scopre, per esempio, come il candidato in pectore accarezzato e “designato” da Leone XIII, prima della sua morte, fosse il carmelitano scalzo e cardinale Girolamo Maria Gotti (« votatelo ») o ancora come il gesuita piemontese (molto prima di Martini e Bergoglio) cardinale di Genova Pietro Boetto nel Conclave del 1939 avesse avuto buone possibilità di essere il successore di Pio XI. Ma il volume ci aiuta a superare – per chi non è addetto ai lavori – le semplificazioni giornalistiche e mediatiche della tv generalista come questa: che gli italiani, durante un Conclave, votano sempre un candidato italiano o i religiosi fanno lo stesso con uno di loro. Da queste pagine affiora, a questo proposito tutto il contrario, la parziale diversità di vedute, quasi un’«ermeneutica delle differenze» direbbe Yves Congar, durante i giorni del Conclave (18-19 aprile) del 2005 che portò all’elezione di Benedetto XVI, sul destino della Chiesa e il ruolo del successore di Pietro, portata avanti dai confratelli gesuiti i cardinali il torinese Carlo Maria Martini e l’argentino Jorge Mario Bergoglio. Tra i meriti che Melloni concede a Giovanni Paolo II è anche quello di aver dato spazio e « voce» in seno al suo Collegio cardinalizio di fine millennio a due porporati discepoli diretti del suo amato Karl Rahner: Walter Kasper e Karl Lehmann. Come riconosce sempre Melloni, in base alla sua ricostruzione e tesi di questo libro che il vero «designato » a succedere sulla Cattedra di Pietro per Karol Wojtyla era il prefetto dell’ex Sant’Uffizio il cardinale Joseph Ratzinger. Come sono certamente interessanti e degne di note le pagine che l’autore dedica a papa Benedetto XVI come fine interprete dei Padri della Chiesa e della sua visione («ermeneutica della continuità ») del Vaticano II. Come è certamente singolare che l’illustre storico del cristianesimo nel suo saggio parlando sempre di Benedetto XVI accenni al sodalizio che intrattenne, nei suoi anni giovanili con Rahner durante il Vaticano II (vedi gli schemi preparatori sulle fonti della Rivelazione scritti assieme) e non voglia sottolineare la sintonia che ebbe soprattutto nel periodo del post-Concilio con altri due teologi molto ignaziani come Hans Urs von Balthasar e Henri de Lubac e cofondatori con lui nel 1972 della rivista Communio. Melloni si dice convinto, a conclusione del suo ragionamento, che il futuro della Chiesa come del ruolo che rivestirà il successore di Pietro, in questo caso Leone XIV, non dipenderà come immaginava Joseph Ratzinger da «minoranze creative» capaci di scuotere il vecchio Occidente europeo secolarizzato e post-cristiano ma dalla spinta da parte anche della gerarchia cattolica per un’«autentica trasmissione della fede» alle nuove generazioni (i cosiddetti millennial) secondo la felice definizione del teologo rahneriano il gesuita Christoph Theobald.
© RIPRODUZIONE RISERVATA