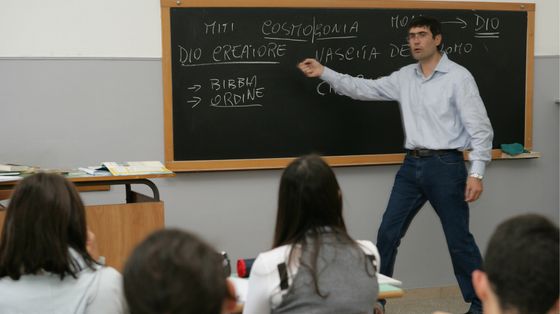«C’è una strada fino al segreto dei neuroni. E noi la stiamo scoprendo»
Parla Giuseppe Lauria Pinter, direttore scientifico dell’Istituto neurologico Besta di Milano, avamposto italiano della ricerca: conquiste, speranze, cantieri aperti. E la cura di malattie come la

«Molti sono i lavori indirizzati alla scoperta di nuove terapie contro le malattie neurologiche, e questo esperimento tenta di identificare nuovi fattori di trascrizione per ottenere neuroni da fibroblasti riprogrammati. Propone un’innovazione concettuale, quella di poter ottenere tipi specifici di neuroni, con caratteristiche biologiche uniche. Un passo utile al cambio di approccio nella classificazione delle malattie neurodegenerative: da quella attuale descrittiva e sintomatica a una di tipo biologico, che tenga presente questi peculiari aspetti che possono caratterizzarla dando luogo alle sue varie espressioni, dalle modalità di esordio alla progressione».
È profondamente convinto della necessità di questo cambio di passo Giuseppe Lauria Pinter, dal 2021 direttore scientifico dell’Irccs Istituto neurologico “Carlo Besta” di Milano e professore ordinario di neurologia dell’Università Statale milanese, al quale abbiamo chiesto un commento sul recente lavoro di un gruppo del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston che ha ottenuto su topi la conversione di fibroblasti della pelle in motoneuroni grazie all’utilizzo di fattori di trascrizione. Cerchiamo di capire meglio questo punto affrontando il tema della ricerca in neurologia.

Professore, ci parli di questa necessità di cambiare approccio nella ricerca sulle malattie neurologiche.
Spiegandolo in modo essenziale, oggi siamo in grado di effettuare analisi molecolari molto sofisticate di malattie che però, in molti casi, classifichiamo con il nome che è stato dato loro a metà del XIX secolo. Cioè, mettiamo sotto lo stesso ombrello della denominazione pazienti la cui malattia può avere caratteristiche biologiche differenti, e quindi differenti possibili terapie. Pensiamo all’oncologia: un recente lavoro ha permesso di ricostruire ben quattro sottogruppi biologicamente diversi di carcinoma polmonare a piccole cellule, ognuno poi associato a specifiche terapie. Questo significa fare medicina personalizzata, ed è stato possibile superando la classificazione descrittiva del tumore. Applicare lo stesso approccio in neurologia è dunque necessario, e piano piano confido che ci arriveremo.
Nel recente annuncio proveniente dal Mit viene fatto questo salto?
L’obiettivo non era quello, tuttavia offre una prospettiva metodologica innovativa. Cioè, che tipo di motoneuroni potremmo ottenere con la conversione delle cellule della pelle: quelli che innervano la lingua o i muscoli del braccio, o della gamba? Questo non è ancora possibile, ma un passo in questa direzione potrebbe svelare aspetti ancora sconosciuti di varie malattie, tra cui la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Oggi i pazienti che ricevono questa diagnosi vengono inclusi in trial clinici indipendentemente dalle variabili biologiche, per lo più ignote, che determinano le differenti forme di malattia. Non è un caso che negli ultimi trent’anni i trial siano falliti. L’unico studio che ha dimostrato un’efficacia, benché indiretta, è stato quello indirizzato su un bersaglio biologicamente conosciuto, cioè nella forma di Sla con mutazioni del gene Sod1, attraverso una terapia genica in grado di ridurre il livello della proteina tossica per i motoneuroni.
Quali sono le ricerche del “Besta” in questa direzione?
Il nostro centro Sla è composto da neurologi con competenze di ricerca che operano insieme a ricercatori di base, lavorando in modo parallelo sul piano sperimentale preclicnico e clinico. Stiamo studiando da alcuni anni i profili molecolari di motoneuroni che appartengono a sottogruppi specifici di malattia, partendo dall’assunto che la suscettibilità di queste cellule sia diversa come conseguenza della loro diversità biologica. Abbiamo pubblicato nel 2021 i risultati di uno studio italiano no profit, reso possibile grazie a un finanziamento di AriSla, la Fondazione italiana di ricerca per la Sla, in cui abbiamo dimostrato che il guanabenz, un vecchio anti ipertensivo ritirato dal mercato di cui si era scoperta la funzione di modulare i meccanismi di produzione e degradazione delle proteine nelle cellule, aveva un’efficacia clinica in pazienti con Sla a esordio bulbare. Grazie a questi risultati abbiamo attirato l’interesse di una piccola azienda francese, ottenuto un altro finanziamento dell’Als Association (Alsa), la più grande fondazione al mondo di supporto alla ricerca sulla malattia, e svolto un secondo studio clinico che ha incluso 50 pazienti con la forma di Sla bulbare. I risultati clinici e soprattutto l’analisi di numerosi biomarcatori sono stati positivi. Ora per noi è importante trovare risorse per svolgere un trial di conferma.
Quali altri risultati sono stati raggiunti in neurologia?
Oltre al farmaco che rallenta la forma di Sla causata da mutazioni del gene Sod1, altri due risultati straordinari sono stati la terapia genica contro l’Atrofia muscolare spinale (Sma), la patologia in cui si ha una progressiva perdita dei motoneuroni, che ha permesso di far sopravvivere e crescere in modo quasi normale i bambini affetti e, analogamente, la terapia per la forma genetica dell’amiloidosi, un disordine molto grave con accumulo di una proteina con configurazione anomala in vari tessuti e organi, in particolare cuore, fegato, nervi periferici. Abbiamo, poi, numerosi farmaci molto efficaci per la sclerosi multipla, che permettono oggi di controllare il decorso della malattia in modo davvero soddisfacente. Può presentarsi in forme aggressive e verosimilmente differenti sul piano biologico, per cui occorre approfondire le conoscenze per scoprire terapie specifiche. Per l’Alzheimer saranno disponibili in Italia, per una percentuale di pazienti, nuovi farmaci recentemente approvati dall’ente regolatorio europeo Ema. Il Parkinson, invece, è una malattia complessa, con alcuni geni che sono fattori di rischio e a manifestazione clinica variabile: non è ancora noto perché in alcune persone evolve più rapidamente ma è oggetto di intensa ricerca. Oggi con la tecnica non invasiva MrgFus si può trattare il tremore effettuando microlesioni termiche in una regione specifica del cervello, utilizzando ultrasuoni ad alta frequenza indirizzati dalla risonanza magnetica. Infine, nell’ambito delle lesioni midollari, soprattutto per quelle di natura traumatica, sono stati pubblicati lavori avveniristici che infondono la speranza di poter restituire almeno in parte la possibilità di movimento. Tra essi, il trapianto delle cellule mesenchimali e l’uso dell’interfaccia uomo-computer, con i progetti di neurorobotica che avanzano con passi da gigante. A sinistra, una ricercatrice in un laboratorio dell’Irccs milanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA