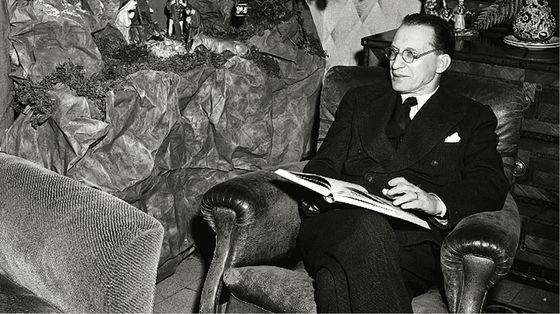Tragedie allo stadio, 40 anni dopo che si fa?
Sabato 11 maggio 1985, durante la partita Bradford City–Lincoln City al Valley Parade, nel West Yorkshire britannico, un incendio in tribuna causò 56 morti e 256 feriti. La squadra di casa festeggiava la promozione in Seconda Divisione davanti a 11.076 spettatori, quasi il doppio della media stagionale. Verso la fine del primo tempo, si sviluppò un incendio nel settore G della tribuna principale, causato da una sigaretta che incendiò un cumulo di rifiuti accatastati sotto la tribuna, tutta in legno, costruita nel 1911. Le fiamme si propagarono in quattro minuti, favorite dal vento e dalla copertura dello stadio in cartone catramato. Gli spettatori cercarono di fuggire verso il campo o verso le uscite superiori, molte delle quali però erano chiuse o bloccate. Il fumo nero rendeva impossibile vedere e respirare, la struttura che crollava e il panico trasformarono quella fuga in un massacro. L’arbitro Norman Glover sospese la partita, ma la situazione non migliorò, nel campo mancavano addirittura gli estintori, eliminati a causa del timore di vandalismi. I giocatori, l’allenatore del Bradford City Terry Yorath (i cui familiari erano nel settore colpito dall’incendio) e alcuni tifosi tentarono di aiutare nei soccorsi i vigili del fuoco che arrivarono in pochissimo tempo, ma trovarono la tribuna già distrutta. Le tragiche conseguenze si trassero all’alba: tra le 56 vittime (54 tifosi del Bradford, 2 del Lincoln) c’erano anche l’ex presidente del club di casa, Sam Firth, e 11 minorenni. Si scoprì anche che Il club era a conoscenza dei rifiuti sotto la tribuna, la cui rimozione era prevista due giorni dopo la partita. La tragedia scosse profondamente l’opinione pubblica inglese, la regina Elisabetta II, la Premier Margaret Thatcher e Papa Giovanni Paolo II. Tuttavia, mercoledì 29 maggio, soltanto 18 giorni dopo, l’orrore andò di nuovo in scena su un campo di calcio, questa volta in Belgio: era la maledetta sera dell’Heysel, altre 39 vittime della violenza, di uno stadio inadeguato, dell’assurda approssimazione nell’organizzazione di un evento come una finale di Coppa dei Campioni. Sono passati esattamente 40 anni, il calcio inglese ha saputo cambiare radicalmente paradigma e ha fatto proprio dell’eccellenza degli stadi e della loro sicurezza un elemento caratteristico, risolvendo anche (almeno in casa) il problema degli hooligans, perché - come noto - la bellezza di un luogo incide anche sul comportamento di chi, quel luogo, lo frequenta. In Italia, quaranta anni dopo, ci siamo sentiti rimproverare dai Presidenti di Fifa, Gianni Infantino, e Uefa, Aleksander Ceferin, di “non avere stadi al livello di altri Paesi, non solo europei”. In effetti gli stadi italiani, al netto di pochissime e lodevoli eccezioni, sono eredità di due momenti storici: il ventennio fascista e Italia ‘90. Circa la metà dei 120 stadi ancora oggi utilizzati (con capienza superiore ai 5.000 spettatori) sono stati inaugurati prima del 1946. E quelli “moderni”, ovvero costruiti o ristrutturati per i Mondiali di Italia ‘90, sono stati pensati negli anni ’80, proprio prima di quelle tragedie, e per un calcio che aveva esigenze completamente diverse e che non ha più nulla a che fare con quello di oggi. Le conclusioni? Le lascio a voi, ma la miopia di chi guida il calcio italiano, dei proprietari dei club e della politica, su questo tema, a maggior ragione in occasione di questi tragici anniversari, è stata ed è imbarazzante. © riproduzione riservata
© RIPRODUZIONE RISERVATA