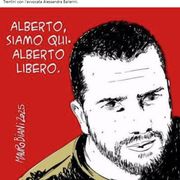Vita oltre le sbarre con il patto tra speranza teologica e secolare
Contro la solitudine che spinge i detenuti alla disperazione l’esperienza della fede e la rete di relazioni con figure di pura gratuità

Nelle domeniche dell’Anno Santo “Avvenire” sta ospitando voci credenti e laiche per offrire spunti di riflessione a partire dalle domande ispirate dalla Bolla d’indizione firmata dal Papa. Qual è, oggi, la speranza che “non delude”? Che speranze ispirano il nostro futuro? Su quali fondamenta edifichiamo progetti, attese, sogni? E la società, a che speranza attinge? Prosegue il nostro viaggio tra ipotesi di risposta.
Nella sua straordinaria ricchezza linguistica, l'arabo offre molti termini per tradurre la parola “speranza”. Tra questi ne segnalo due: raja’ e amal. Nel linguaggio comune possono essere quasi considerati sinonimi, ma i maestri spirituali che si sono espressi in questa lingua, a cavallo tra cristianesimo e islam, segnalano volentieri come il primo termine significhi speranza nel mondo a venire, mentre il secondo indica la speranza esercitata nei confini di questo mondo. Gli autori spirituali più esigenti “fanno campagna” per raja’ e svalutano amal: giungono addirittura a dire che, per avere davvero speranza nelle cose dell’altro mondo, bisogna “uccidere” ogni speranza mondana, poiché le aspettative di questa vita hanno il potere di oscurare i beni attesi da Dio.
Riflettendo sul valore della speranza nel mondo del carcere, io ritengo invece che sia necessario coltivare, con le persone detenute, entrambi i versanti di speranza. Per combattere le tentazioni di autolesionismo e suicidio, così pervasive nella vita ristretta, bisogna fare leva su entrambe le forme di speranza, direi nessuna senza l’altra. La speranza propria della dimensione religiosa ha un valore fondamentale nei processi di resilienza di chi subisce la perdita della libertà. Ho in mente un ragazzo poco più che maggiorenne, condannato a un lunghissimo periodo di detenzione per un grave delitto familiare. Parlando con lui, ho toccato con mano, da una parte, che cosa abbia significato la perdita di speranza sul piano inclinato che l’ha condotto al crimine, mentre d’altra parte assisto a una sorta di risurrezione della sua vita dietro le sbarre, dove la speranza ha ripreso a illuminare le tenebre della sua cella. Dopo la carcerazione ha voluto quasi subito riprendere il cammino della sua formazione religiosa, ha ricevuto il sacramento della cresima, si è iscritto a un corso di teologia.
Nel suo caso, come in tanti altri incontrati in carcere, posso segnalare il fatto che la speranza accesa dal ritorno alla dimensione religiosa si associa a una grande curiosità. Torna la voglia di scoprire il mondo, anzi, i mondi. Così avviene che persone detenute, accanto al proprio cristianesimo si aprono al dialogo con musulmani, buddisti, e appartenenti ad altri sistemi religiosi. Non credo si possa parlare a questo proposito di relativismo ma proprio di un impulso di apertura agli altri, che la vita carceraria paradossalmente provoca e favorisce. Ciò vale anche per gli altri: non è un caso isolato quello del musulmano che chiede di partecipare alla Messa, senza alcuna ambiguità o secondo fine. C’è in tutto questo anche il dato di una profonda esigenza personale: la speranza di essere perdonati. Qualunque atteggiamento un condannato abbia tenuto nel momento del suo processo, qualunque linea di difesa abbia adottato d’accordo con il proprio avvocato, resta però il fatto che nei lunghi mesi e anni di detenzione le fitte interiori del rimorso possono essere particolarmente dolorose. La speranza non è una via di fuga dalle proprie responsabilità ma l'intuizione che il reato commesso non è mai la sintesi suprema della propria vita, e che al di là delle proprie colpe rimane l'apertura su uno spazio esistenziale nuovo. Questa intuizione è appunto la speranza. L a speranza religiosamente connotata è dunque uno strumento prezioso nel progetto educativo delle persone detenute. Bisogna allora dare loro la possibilità di coltivarla. C’è bisogno di cappellani, di assistenti spirituali, di locali adatti, ma anche di ministri per le altre religioni: penso in particolare all'islam e alla difficoltà per migliaia di persone detenute di esercitare il proprio culto in carcere. Questa disponibilità di mezzi e di persone è anche il modo migliore per evitare gli effetti indesiderati della speranza religiosa: la radicalizzazione, dove la crescita dei valori spirituali dietro le sbarre può associarsi a un rifiuto del mondo circostante, fino all’assunzione di posizioni violente
Ed è a questo proposito che va coltivata un’altra forma di speranza, parallela alla prima, che è l’insieme delle aspettative buone per uno sviluppo della propria vita in questo mondo. Per nessuno dovrebbe valere il terribile slogan “buttiamo via la chiave”. A nessuna persona detenuta deve essere sottratta la speranza di rimettersi in piedi in questa vita. Mi viene in mente un altro ragazzo giovanissimo, musulmano, condannato a una lunga detenzione: nel momento in cui è entrato in carcere, si poteva dire che la sua vita era finita, ma non è stato così. A parte la ripresa della pratica religiosa, che ha riacceso la speranza in un Dio che può perdonare, si è messa in moto una dinamica virtuosa di vita impegnata in cose buone. Si poteva dirgli: perché ti metti a studiare, visto che devi stare in prigione tutta la vita? Invece le cose sono andate avanti nel segno della speranza: prima la licenza di scuola primaria, poi di scuola secondaria, poi l’iscrizione all’università, facoltà di Giurisprudenza. Poi è arrivato il lavoro, grazie alla presenza di un’azienda attiva in carcere. Raramente ho visto un ragazzo tanto impegnato come questo, al punto che lo potrei definire un ragazzo modello, un esempio per molti coetanei, che pur godendo del grande bene della libertà sembrano aver perso il gusto di costruire la vita giorno per giorno, ponendosi dei traguardi significativi da raggiungere. Questa è appunto la speranza in questo mondo.
Concludo aggiungendo che la speranza, sui due versanti qui sintetizzati, ha bisogno di una forte rete di collaboratori. Uno degli effetti devastanti della detenzione è quello di precipitare le persone in una profonda solitudine esistenziale, una condizione che apre la porta alla disperazione. La speranza “teologica” e quella “secolare” devono essere nutrite dalla rete di relazioni che si possono costruire in carcere, e in questo i volontari hanno davvero un ruolo cruciale. Lo posso dire per esperienza diretta: ci sono gli agenti di custodia, gli educatori, gli insegnanti, gli infermieri, cioè le figure professionali nella vita del carcere, ma qualcosa di speciale è portato, proprio sul piano della speranza, da quelle figure che sono preziose proprio perché agiscono a livello della pura gratuità. Spesso le persone detenute, magari scherzando, oppure con schietta amarezza, ci dicono che noi volontari non serviamo a nulla, e che potremmo fare anche a meno di spendere tempo e denaro per andarle a visitare. Ma siamo ben consapevoli che invece l’incontro con il volontario rimane essenziale, proprio sotto il punto di vista della doppia speranza: il volontario carcerario porta da fuori idee, preghiere, disponibilità ad ascoltare, magari anche vestiti e qualche semplice servizio concordato con la direzione. I volontari, soprattutto, fanno sentire alle persone detenute che non sono “reati che camminano” ma rimangono persone nel pieno senso della parola, ed è questo che infonde in loro il seme della speranza.
Monaco e islamologo
già delegato al dialogo per la diocesi di Bologna
membro della Piccola Famiglia della Annunziata
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi