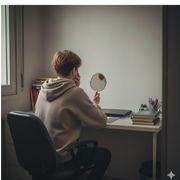Bambini strappati alle famiglie. Il ricorso alla forza è atto di inciviltà
di Luciano Moia
Dopo alcuni recenti episodi di cronaca, la garante per l’infanzia Marina Terragni lancia l’allarme. Urgente porre fine ad episodi - come dice la Cassazione - "inaccettabili per uno Stato di dirit

Parlare dei bambini allontanati da famiglie fragili e “non funzionali” – come dicono gli psicologi – non è tema da specialisti e da addetti ai lavori. Ma è un dovere di civiltà. Ignorare il problema, fingere che non ci riguardi, vuol dire decidere che la sorte dei circa 8mila minori che ogni anno vengono prelevati dalla propria casa con un intervento della forza pubblica su indicazione dell’autorità giudiziaria o, più spesso, dei servizi sociali, è qualcosa che ci lascia indifferenti. Ma sarebbe comportamento colpevole perché vorrebbe dire ignorare che, insieme a quei bambini e a quegli adolescenti, ci sono altrettante famiglie. Vorrebbe dire dimenticare che, secondo una delle pochissime ricerche sul tema – Università di Padova - il 50 per cento dei genitori sottoposti a procedimenti per la sospensione della responsabilità genitoriale hanno potuto dimostrare l’infondatezza delle accuse e i giudici hanno ordinato il ritorno a casa dei bambini. Ma, allora, perché ricorrere a un provvedimento tanto traumatico? Davvero è sempre necessario intervenire con la forza? Pochi casi isolati, si dirà. Macché! Negli ultimi vent’anni le famiglie coinvolte in situazioni come queste sono state circa 160mila, secondo una stima fondata sugli unici dati ufficiali diffusi nel 2019 dall’allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5s). Ma allora vuol dire che i magistrati minorili sbagliano nella metà delle volte? Anche questa sarebbe un conclusione azzardata. Per tanti minori l'allontanamento, quando avviene in modo prudente e rispettoso, può risolvere situazioni di grave pericolo e può tradursi in una forma di salvezza. Per altri può diventare un inferno. Ma il magistrato, quando conferma la validiità del provvedimento, non lo sa. Come è quasi impossibile per i servizi sociali prevedere l'esito finale della vicenda. Perché allora tante situazioni sono intrise di sofferenze, incomprensioni, tensioni gravissime? Vediamo di capire.
Ne abbiamo parlato tantissimo in questi anni, abbiamo dato voce ai genitori che subiscono queste decisioni – spesso senza capire e senza sapere da dove nasca il provvedimento - , agli psicologici le cui valutazioni sono spesso determinanti per orientare il parere dei magistrati, agli avvocati, agli stessi giudici minorili le cui valutazioni possono cambiare il corso di una storia familiare. Ma dobbiamo tornare a parlarne perché nei giorni scorsi la garante per l’infanzia, Marina Terragni, di fronte a una serie di “prelievi forzosi” di minori da parte della forza pubblica, ha deciso che è arrivato il momento di fare chiarezza.
Terragni ha chiesto un incontro alla ministra per la famiglia Eugenia Roccella, al ministro della giustizia Carlo Nordio e al Ministro dell’interno Matteo Piantedosi “allo scopo di definitivo chiarimento in merito ai prelevamenti forzosi dei minori destinati al collocamento in case famiglia e/o altre strutture extrafamiliari, e in particolare all’uso della forza pubblica per l’esecuzione del prelevamento”.
Nella lettera inviata ai ministri Terragni ha ricordato che “svariate sentenze stabiliscono che il provvedimento forzoso può essere adottato unicamente a tutela dell’incolumità del minore e nei casi in cui vi siano rischi certi e imminenti per la sua vita”. In particolare, ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione 9691 del 2022, che ha definito misura “non conforme allo stato di diritto” l’uso della forza per il prelevamento del minore e ha ribadito l’imprescindibilità dell’ascolto del minorenne.
La questione è complessa e, per comprenderla al meglio, dobbiamo chiarire bene tutti gli aspetti. La garante per l’infanzia e l’adolescenza non discute la necessità di intervenire, in alcuni, limitati casi, allontanando il bambino dalla sua famiglia per collocarlo provvisoriamente in una struttura protetta, ma non accetta il “metodo forzoso”, cioè l’intervento di polizia municipale e altre forze dell’ordine che troppo spesso agiscono senza alcun rispetto per la tutela del bambino e per il suo equilibrio psico-fisico, con procedure tanto risolute da apparire violente e comunque poco rispettose della sensibilità e del quadro emotivo del piccolo. Va anche detto che l’Italia, tra i Paesi europei, è quello in cui si registra il minor numero di provvedimenti d’allontanamento, con variazioni profonde tra Nord e Sud. E qualche esperto fa notare come questi dati non stiano ad indicare situazioni familiari positive ma, all’opposto, vaste lacune nel sistema di tutela dei minori fuori famiglia.
Ma quando l’allontanamento scatta e i genitori si oppongono perché non ne condividono le motivazioni, cosa succede? Occorre dire che le cause che inducono servizi sociali, forze dell’ordine e magistrati minorili ad intervenire affondano spesso nelle dinamiche drammatiche di separazioni conflittuali, con i due coniugi che si combattono senza esclusioni di colpi. Proprio in queste situazioni – ma la gamma delle eventualità è vastissima - i genitori stessi diffondono in rete video strazianti, con bambini letteralmente strappati dalle braccia di mamme o papà, infilati con la forza nell’auto della polizia, tra urla e pianti.
Come mai possono avvenire episodi simili? Le ragioni, in estrema sintesi, sono due. Le lacune della riforma Cartabia e la mancanza di un protocollo nazionale per regolare le procedure negli ordini di allontanamento coatto. Fino al 2022, l’articolo 403 del codice civile legittimava l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia disposto dalla pubblica autorità senza tuttavia prevedere adeguate garanzie di controllo. Una disattenzione nei confronti dei bambini motivata dal fatto che il legislatore nel 1942, quando cioè questo articolo fu introdotto, riteneva giusto lasciare ampia discrezionalità alle pubbliche autorità e agli enti di protezione dell'infanzia. Scelta giustificabile ottant’anni fa, ma non più oggi. Tanto che all’Italia sono arrivate condanne plurime da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo.
La riforma Cartabia ha in parte rimediato. Oggi, per l’applicazione, del “403” c’è una tempistica rigorosa - 24 ore per informare il pubblico ministero che ha poi altre 72 ore per decidere se annullare il provvedimento o chiedere al giudice minorile di confermarlo – e un coinvolgimento immediato dei genitori. Il magistrato verifica le ragioni che hanno indotto l’allontanamento del bambino - se davvero sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nel proprio ambiente familiare, a un grave pregiudizio o grave pericolo per la propria incolumità psicofisica – e quindi, entro altre 48 ore, provvede alla nomina del curatore speciale del minore e fissa entro 15 giorni l'udienza di comparizione del minore per l'audizione, dei genitori e del curatore stesso.
Tutto bene quindi? Peccato che la riforma – il cui completamento è rimandato ad ottobre e probabilmente subirà nuovi rinvii - non abbia previsto di fissare le modalità con cui deve avvenire l’allontanamento. Al riguardo c’è solo una sentenza della Cassazione del 2022, quella citata anche dalla garante per l’infanzia e l’adolescenza, in cui si spiega che il ricorso a “una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede… non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto” perché “potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona”.
Ma quando le istituzioni sono convinte che occorra proprio allontanare con urgenza il bambino dalla sua famiglia, molto spesso come detto da quell’unico genitore rimasto, perché esistono situazioni obiettive di “grave pericolo o di grave pregiudizio”, come si dovrebbe fare? Non esiste un protocollo nazionale, cioè una procedura che sia vincolante per assistenti sociali, forze dell’ordine ed enti locali. In alcune regioni, a livello territoriale, sono stati adottate regole di buon senso per evitare quei traumi e quelle offese alla dignità della persona che anche la Cassazione ipotizza, ma certamente non basta.
Nei mesi scorsi è stato avviato un confronto tra l’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ordine nazionale degli assistenti sociali proprio allo scopo di verificare le modalità per arrivare a un protocollo nazionale che non solo escluda nel modo più assoluto ogni forma di violenza e di costrizione, ma preveda l’accompagnamento psicologico dei genitori, aiutandoli a comprendere ed accettare le motivazioni che hanno indotto quel provvedimento. Che è sempre triste, invasivo e dilaniante. Ma se davvero mettiamo al centro il “superiore interesse del minore”, non possiamo immaginare che famiglie e istituzioni non vengano aiutate a condividere lo stesso punto di vista e la stessa strategia. Senza l’uso della forza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA