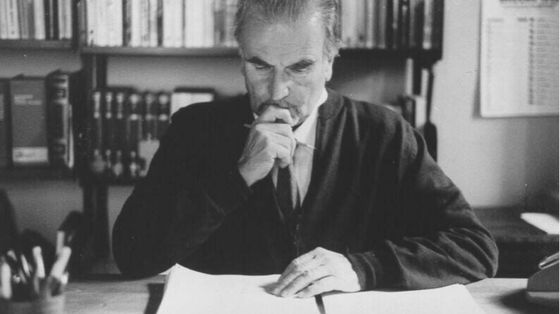Quanta confusione sotto il cielo della moda sostenibile
All’annuale Forum tenutosi a Venezia, le aziende e gli esperti del comparto hanno evidenziato la necessità di mantenere tra i punti fermi l’innovazione, l’accessibilità dei capitali e l’armonizzazione delle regole. «L’ultra fast fashion pone interrogativi seri»

«I
l mondo della moda europea dell’abbigliamento è sotto attacco dell’ultra fast fashion»: il modello di produzione «rapida e continua di capi di tendenza a prezzi bassi, spesso altamente inquinante», ma di successo perché alla portata di tutti. Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda non usa mezzi termini aprendo il “Venice Sustanaible Fashion Forum”, l’appuntamento – organizzato con The European House Ambrosetti (TEHA) e Confindustria Veneto Est, che riunisce ogni anno il settore (imprese, del lusso soprattutto, esperti internazionali, giovani startup) per fare il punto sulle tendenze e riflettere sulle criticità. Sburlati ripete un mantra forse già troppe volte sentito tra i più assidui frequentatori del meeting. E ne cambia il registro. Per cui, se prima la fast fashion era un attore con cui dialogare (tra i relatori nel 2024 c’era anche un rappresentante di Shein, colosso online della moda low-cost), oggi è diventato un «nemico ultra fast», ancora più veloce. Che invade tramite «l’alluvione di centinaia di migliaia di pacchi che arrivano ogni giorno nelle nostre case» e che «non pagano dazi, dogane e spesso neppure Iva». Una «aggressione» che proviene per lo più dai Paesi emergenti, Cina in testa, da cui la moda artigianale e ricercata europea deve «difendersi». Come? Spingendo ancora di più sui suoi punti di forza che sono qualità ed eccellenza. E sostenibilità. Ma anche questa non è una novità per chi da anni legge la strategia del settore. Cosa è successo allora? La sensazione è che – in una fase congiunturale critica – nella città lagunare sia arrivato un comparto confuso, incastrato in percorsi intrapresi a metà. In cui proprio la transizione green fatica. E che deve cambiare passo se vuole restare competitivo. Anche perché a guardare bene, in casa ha le debolezze. Come in casa ha le soluzioni.
Le cifre tra luci e ombre.
I numeri sono quelli del “Just Fashion Transition 2025”, lo studio realizzato da TEHA per comprendere la trasformazione sostenibile dell’industria europea dell’abbigliamento in tutta la filiera. «Quest’anno – si legge – la conversione ecologica si intreccia con la geopolitica e la sicurezza industriale». La crisi sta ridisegnando le catene del valore mentre l’Ue tenta di reagire con il Clean Industrial Deal, un piano da oltre 100 miliardi di euro pensato per sostenere la decarbonizzazione dei comparti energivori. La moda però resta ai margini con il rischio che dalla transizione rimanga fuori una fetta di mercato strategica in Europa, formata al 90% da piccole e medie imprese (Pmi). Le conseguenze potrebbero essere molto serie: l’Unione infatti resta la regione più esposta ai fenomeni ecologici in corso, con un 65% del Pil che dipende direttamente dagli ecosistemi naturali. Eppure parliamo di un fiore all’occhiello del Vecchio Continente concentrato in sei Paesi – Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Romania e Italia, che da sola contribuisce a quasi la metà di tutta la produzione europea – il cui fatturato è destinato a crescere tra il 12 e il 17% al 2030. Ma che allo stesso tempo potrebbe perdere forza lavoro, quasi 300mila occupati, a causa dell’automazione del sistema e del rientro in patria di aziende in passato delocalizzate.
Ultra fast fashion vs sostenibilità.
In questo quadro complicato si inserisce «l’invasione dell’ultra fast fashion». Un dato seppur relativo ma esemplare lo dà Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est: «In Veneto», dice, nel primo semestre 2025 «l’export del settore è calato del 4,5%, a fronte di un +4,3% di import che sale a nove se si guarda alla sola Cina». Cioè produciamo «il meglio» eppure lo esportiamo meno; di contro spalanchiamo le porte a quelli che una volta erano «gli ultimi della classe». Ma è possibile che l’Europa non fosse preparata? In effetti da tempo l’Ue si è attrezzata per difendere la sua manifattura (che in Italia vale il 5% del Pil) in chiave green, ma qualcosa è andato storto: avrebbe dovuto essere capofila, e invece raggiungerà gli standard di sostenibilità previsti al 2030 con otto anni di ritardo. A parlare sono sempre i numeri del report: «La produzione mondiale di fibre – per esempio – è più che raddoppiata in 20 anni, ma nel Vecchio Continente solo il 20% dei tessili viene effettivamente riciclato». Le esportazioni di usato poi, spostano il problema in Paesi con meno regole ambientali, non lo risolvono. L’Unione Europea insomma si presenta all’appello annuale come un animale zoppo che avrebbe potuto fare «tanto» e non ha fatto nemmeno «abbastanza». E che ora rischia di pagarla cara se non elimina gli ostacoli sul suo cammino.
Quali ostacoli? I costi in primis. Il 66% delle tecnologie verdi a disposizione del comparto è maturo ma ha un’applicazione limitata a causa dei prezzi iniziali, troppo alti per le tante Pmi che da sole non ce la fanno. Non a caso in questo momento il peso della sostenibilità lo portano sulle spalle i brand del lusso e mancano «4,4 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi per la decarbonizzazione», spiega Carlo Cici di TEHA. L’Europa arranca anche sul piano culturale e mediatico, non conosce il suo consumatore. «Non sa – aggiunge Cici – che non si accontenta più del rispetto dell’ambiente, chiede anche quello dei diritti». Ed è confuso, «di chi fidarsi?» si chiede non a torto, se si pensa anche alla grande frammentazione normativa del mondo della moda europea. Interessante il caso dei Millennial e della Generazione Z, giovani che – cresciuti nell’incertezza economica e climatica – rispondono al pessimismo con il cosiddetto “doom spending”: una spinta a spendere in beni di lusso come forma di gratificazione emotiva. La maggior parte di loro compra una volta ogni sei mesi, privilegiando autenticità, esclusività e valori etici con il paradosso che solo il 30% verifica davvero l’origine o l’impatto di ciò che acquista.
Che fare allora?
Da Venezia arrivano sei raccomandazioni i cui punti cardine sono: più innovazione, capitali accessibili e armonizzazione delle regole. Urge inoltre scrivere un «vocabolario comune della sostenibilità» che consenta alle aziende di dialogare tra loro e al pubblico di orientarsi. Deponendo l’ostilità nei confronti di un mondo, quello della fast fashion, ormai capace – nolente o volente – di fare business. A meno che non si voglia delegare il green alla nicchia del lusso. E non sembra quello che vuole un settore a cui va dato il merito di mettersi in discussione ogni anno alla luce del sole. Non si tratta più solo di «voler bene al pianeta», ma di essere rilevanti.
© riproduzione riservata
© RIPRODUZIONE RISERVATA