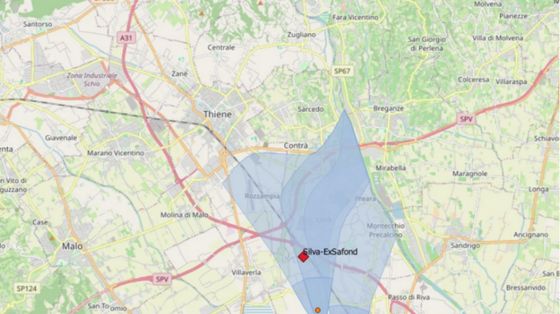Le donne che dirigono il carcere: «Da sole non possiamo cambiarlo»
Negli istituti penitenziari italiani sono donne quasi la metà dei direttori: noi abbiamo incontrato quelle della Lombardia. Ecco cosa ci hanno raccontato

Ritrovarsi tutte le mattine dall'altra parte del cancello, oltre la linea che separa il fuori dal dentro, nell'abisso del carcere. Col compito di dirigerlo, l'abisso. Nonostante tutto: l'emergenza, il sovraffollamento, il caldo, la percentuale sempre più alta di detenuti tossicodipendenti, la difficoltà nella gestione di quelli stranieri, l'inadeguatezza delle strutture, la mancanza di personale e di fondi, il dramma dei suicidi. Il compito che pare impossibile tocca a 254 direttori negli istituti penitenziari del nostro Paese (a fronte di un organico previsto di 350 unità, almeno stando ai numeri aggiornati al 31 dicembre 2024) tra cui 121, cioè quasi la metà, sono donne. Un dato per certi versi sorprendente, per un incarico che nell'immaginario collettivo ha o dovrebbe avere più a che fare con l'esercizio della forza e dell'autorità e che nella realtà dei fatti si misura con un mondo decisamente declinato al maschile: dei quasi 63mila reclusi al momento nelle carceri italiane, 60mila sono uomini. E per soli uomini è stata concepita la maggioranza dei nostri istituti di pena, dai servizi igienici fino agli spazi comuni e ai progetti di reinserimento lavorativo.
Perché dunque così tante donne al comando? E come affrontano la sfida della direzione delle carceri in un tempo così complesso? Avvenire lo ha chiesto alle direttrici delle carceri lombarde (donne in tutte le strutture, fatta eccezione per Bollate, Como e Voghera) nel corso di un forum organizzato nella nostra sede di Milano nei giorni scorsi. Un’occasione «per guardarci allo specchio» secondo la provveditora regionale dell’amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco d’Aragona, che al coordinamento del sistema lombardo è arrivata a sua volta dopo gli anni di direzione negli istituti liguri di Genova Pontedecimo, Chiavari, Genova Marassi: quasi trent’anni d’esperienza dietro le sbarre, tra le veterane uscite dal concorso bandito nel 1997 ( l’ultimo prima di quello arrivato soltanto nel 2020, da cui sono uscite 16 nuove leve), negli occhi ancora la passione per un lavoro scelto perché «avevo il desiderio di sapere cosa c’era dall’altra parte dell’esercizio della legge. Ricordo ancora quando dissi a mia madre di aver ottenuto il ruolo: “Compri il pane ai carcerati?” mi chiese, immaginandomi come una specie di crocerossina. Eppure facciamo tutto, noi, tranne che assistenzialismo ». A cominciare dalla rocambolesca sfida di quel che in gergo tecnico si chiama “diritto applicato” e che nella realtà di tutti i giorni si trasforma nel tentativo creativo (e complicatissimo) di trovare soluzioni immediate a problemi molto concreti con quello che si ha a disposizione: «Ciò che ci tiene attaccate al telefono 24 ore su 24 – spiega Metella Romana Pasquini Peruzzi, direttrice a Mantova – e che in qualche modo rende questo lavoro il più difficile ma anche il più bello del mondo: doverci dare da fare continuamente, dover adattare, interpretare e per così dire “digerire” la norma giuridica caso per caso, giorno per giorno».
«Quando vinsi il concorso mia madre mi chiese: “Compri il pane ai detenuti?”, immaginandomi come una specie di crocerossina. Eppure facciamo tutto, noi, tranne che assistenzialismo. Ogni giorno affrontiamo la sfida del “diritto creativo”: trovare soluzioni che non ci sono ai problemi del carcere»
Maria Milano Franco d’Aragona, provveditora regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Lombardia
Si può fare
Lo sa bene Francesca Paola Lucrezi, direttrice a Brescia, dove è presente anche una piccola sezione femminile e dove dal 2004 si portano avanti attività miste: «Siamo partiti dalla scuola, via via abbiamo costruito e sperimentato altri progetti, intrecciando rapporti con le associazioni e il mondo del Terzo settore». Serviva lo sguardo di una donna, per provare a superare l’isolamento delle detenute donne, che in carcere vivono una sofferenza doppia: « Le loro sono quasi sempre storie di violenze e di traumi subiti, oltre che di reati commessi. Distacco dagli affetti e interruzione delle relazioni di cura completano il quadro: le donne, essendo spesso il fulcro del nucleo familiare in particolare come madri, soffrono enormemente per il distacco dai propri figli, e poi dai mariti, dai genitori. Molto spesso la loro famiglia si disgrega o non c'è più nessuno a far loro visita, gettandole in uno stato di profonda solitudine». Alla gestione di questi percorsi di detenzione, insomma, serve un’attenzione tutta particolare. E le direttrici donne quell’attenzione in carcere l’hanno portata su tutta la linea negli ultimi anni «con la loro empatia, scompaginando i giochi e aprendo anche il sistema penitenziario verso l’esterno» aggiunge la direttrice del carcere di Monza Cosima Buccoliero, alle spalle l’esperienza consolidata nella struttura modello di Bollate: « Ho sempre avvertito la rigidità e l’aridità, per così dire, del diritto e delle legge. Quando sono entrata la prima volta in carcere, a Cagliari, ne ho toccato con mano il sangue e la carne. Le donne direttrici non sono tante solo perché vincono più facilmente i concorsi (ride, ndr), ma perché portano naturalmente con sé ascolto, comprensione e quel “si può fare” che a Bollate, per esempio, ha preso forma più che altrove. Io me lo porto dietro in ogni carcere, me lo ripeto continuamente con convinzione: si può fare».

Le ferite da curare fuori
Il mantra serve a sconfiggere la solitudine di un lavoro oggettivamente difficilissimo, «fatto di amarezza, delusione, a volte impotenza» ammettono senza mezze misure la direttrice di Busto Arsizio Maria Pitaniello e quella di Varese Carla Santandrea: « In carcere tutti, detenuti e personale, guardano a noi e se noi ci fermiamo tutto si ferma». La mente vola alle tensioni nelle sezioni, agli “episodi critici” (incendi, aggressioni, principi di rivolte), ai suicidi che «non dipendono solo dal sovraffollamento ma dalla fragilità degli ultimi fra gli ultimi con cui siamo chiamate a confrontarci ogni giorno e che arrivano in cella». Tragedie, queste ultime, su cui spesso si fatica a intervenire anche quando si avviano percorsi di accompagnamento mirati «e che ci portiamo a casa, che viviamo come fallimenti personali ». Se è vero che in carcere, d’altronde, «si osservano i problemi che diventeranno emergenza anche nel mondo di fuori nel giro di 5 anni» spiega la direttrice uscente di San Vittore, Elisabetta Palù, «vero è anche che da fuori bisognerebbe iniziare a curare le ferite del carcere», con politiche sociosanitarie più attente al disagio psichico o alla tossicodipendenza soprattutto dei giovani e dei giovanissimi, con progetti educativi, con un occhio di riguardo alle prime e seconde generazioni di stranieri, che costituiscono larga parte della popolazione reclusa e su cui è difficile intervenire proprio per la mancanza di percorsi di integrazione precedenti alla scelta o spesso alla necessità di delinquere: « Il direttore e il personale penitenziario non possono lavorare da soli. Io in carcere sono entrata quando avevo 26 anni – continua Palù –. Da allora ho visto cambiare profondamente questo mondo: penso ai detenuti in primo luogo, ai problemi di droga e alle diagnosi psichiatriche che portano con sé nel 75% dei casi. Penso ai giovani adulti stranieri che non riusciamo quasi mai a ingaggiare in percorsi trattamentali, disinteressati, spesso senza progetti sul loro futuro tranne quello di evadere. Penso agli agenti, che necessitano di altrettanto supporto, di formazione». Un mondo sotto pressione anche quello della polizia penitenziaria, con le giovani leve alle prese con una realtà a volte più pesante di quella che immaginavano, a volte completamente diversa dalle loro aspettative.
«Non sono arrivata a questo lavoro per scelta, ma l’ho scelto innumerevoli volte dopo, convinta di poter cambiare il sistema. A Brescia ho tentato di farlo promuovendo attività miste tra detenute e detenuti: le donne recluse vivono un doppio isolamento, spesso sono vittime di violenza ed entrando in cella vengono separate dai loro figli»
Francesca Paola Lucrezi, direttrice del carcere di Brescia
Manca una visione
Uomini o donne al comando poco importa, da questo punto di vista, e poco importano viste da dentro anche le misure una tantum di indulto o amnistia su cui la politica è tornata in questi settimane a interrogarsi e scontrarsi: si avverte con forza piuttosto la necessità di un ripensamento del carcere, di investimenti sulle strutture (è il caso di San Vittore proprio o di Opera) in cui interi reparti sono chiusi da anni in attesa di ristrutturazione. E poi di attenzione da parte della società civile e delle associazioni: «Servirebbe una buona volta – continua Santandrea – che il carcere fosse considerato come una risorsa e non solo come un problema da risolvere, che sui territori si attivassero nuove relazioni. Chi dirige un carcere non è un carceriere, né un burocrate, il nostro lavoro non può essere ridotto a questo. Serve una nuova visione del carcere».
«Dietro le sbarre vediamo i problemi che diventeranno emergenza anche fuori nel giro di 5 anni. Il punto è che da fuori bisognerebbe iniziare a curare le ferite del carcere, con politiche sociosanitarie più attente al disagio psichico, alle tossicodipendenze, con l’educazione. Il direttore e il personale penitenziario non possono lavorare da soli»
Elisabetta Palù, direttrice del carcere di San Vittore
Restare umani
La solitudine, sembra una beffa, è ciò che accomuna amministrazione penitenziaria e popolazione detenuta. Il mondo del carcere è tutto, in blocco, invisibile e dolente. Si cerca una luce, una speranza. La direttrice del carcere di Bergamo, Antonina D’Onofrio, dopo tanti anni lo avverte fisicamente tutte le volte che le porte del suo istituto si aprono e si chiudono alle sue spalle: «Io sento l’odore del carcere, che è odore di sofferenza, ma è anche odore di umanità. Ed è su questo odore, dell’essere e del dover restare umani, che mi concentro ogni giorno per trovare il bandolo di una matassa così arrovellata. Il senso dell’amministrazione penitenziaria è il bene comune, il recupero delle persone. Il carcere è il luogo in cui traghettare le persone, attraverso percorsi di rieducazione, al recupero delle proprie vite nel rispetto della legge e dei valori comuni. E le persone sono il cuore, sono ciò che ci viene consegnato». Lo sguardo sulle persone d’altra parte «è lo stile femminile di approccio alla realtà e poter dare un volto ai profili cartacei è quello che desideravo fare dopo 24 anni trascorsi in una cancelleria di un tribunale di sorveglianza. Il mio lavoro in carcere è questo: sguardo, ascolto, empatia» precisa Gisella Russo, vicedirettrice a San Vittore. Per Anna Laura Confuorto, direttrice a Lodi al momento in maternità (e che al forum di Avvenire ha partecipato col suo neonato in braccio) le persone sono una missione da quando, giovanissima, ha messo il suo primo piede a Poggioreale: «Lì io mi sono sentita a casa, forse perché col racconto del carcere sono cresciuta fin da piccola, con le storie di mio zio che era a sua volta direttore del manicomio di Aversa». Per Confuorto un carcere non si dirige in ufficio, ma in sezione, tra i detenuti, guardandoli in faccia e costruendo relazioni: «È il motivo per cui quando sono rimasta incinta ho deciso di continuare a fare il mio lavoro fino all’ultimo. Se il carcere è casa, mi sono detta, anche mio figlio deve entrarci. E la maternità – spiega con gli occhi che le brillano – ha arricchito la mia esperienza professionale, avvicinandomi ancora di più ai detenuti e facendomi vedere la loro condizione da un altro punto di vista: sono stata in attesa, come loro, per un tempo che mi è sembrato infinito. Ho cullato la vita che avevo in grembo come in carcere, un luogo nascosto dove si gettano semi, sperando che un giorno portino frutto».
«Io sento l’odore del carcere, che è odore di sofferenza, ma è anche odore di umanità. Ed è su questo odore, dell’essere e del dover restare umani, che mi concentro ogni giorno per trovare il bandolo di una matassa così arrovellata. Il senso dell’amministrazione penitenziaria è il bene comune, il recupero delle persone»
Antonina D’Onofrio, direttrice del carcere di Bergamo
Sos conciliazione
Non che sia tutto così semplice, per una donna e una mamma direttrice di carcere, anzi. Reperebilità h24, per 365 giorni all’anno, spostamenti noti al personale dell’istituto, scorte: «La conciliazione è un nodo da sciogliere ogni giorno, proprio come ogni giorno dobbiamo sciogliere le problematiche delle strutture in cui lavoriamo prendendo decisioni che non troviamo scritte nella norma» spiega Stefania D’Agostino, direttrice a Opera, madre di due figli, affiancata dalla sua vice Antonella Murolo. La condivisione del lavoro con altre donne, vicedirettrici e comandanti di polizia (anche in questo ruolo la presenza femminile è cresciuta moltissimo nel corso degli ultimi anni), è un aiuto: «A Brescia funziona come un vero e proprio sodalizio – spiega la vicedirettrice Concetta Carotenuto – permettendoci di condividere decisioni, linee strategiche e anche la passione per quello che facciamo». Lo stesso a Bollate, «dove la collaborazione si estende anche alle agenti. Nel loro caso, per esempio, è spesso difficile separare l’aspetto emotivo da quello professionale: lavorare insieme ci aiuta tutte» conferma la vicedirettrice Francesca D’Aquino. Questo quando il vice c’è: secondo i calcoli dell’Osservatorio Antigone la fortuna tocca a poco più del 20% degli istituti nel nostro Paese (mentre al 20% dei direttori tocca l’incarico di gestire più di un istituto). Ma in Lombardia, che conta da sola su una popolazione carceraria di quasi 9mila persone, la logica del gruppo e della condivisione è ciò che anima anche l’amministrazione penitenziaria a livello regionale, con la provveditora Milano che riunisce le direttrici periodicamente, tutte insieme, per mettere al centro progetti condivisi e confrontarsi anche sulle criticità delle singole strutture: «L’esperienza vissuta da ognuna di noi diventa così una risorsa per tutte».
Quale maschilismo
E i maschi? Gli agenti, i detenuti? Anche in questo il mondo del carcere è cambiato. «La presenza di direttrici non è affatto una novità, né qualcosa di strano o straordinario all’interno degli istituti» racconta la giovane direttrice di Cremona, Giulia Antonicelli, in servizio da un anno dopo la formazione ad Opera. «La verità è che il carcere è un mondo sconosciuto all’esterno ed è fuori che c’è ancora un pregiudizio rispetto al fatto che questo ruolo possa essere svolto da donne e da donne giovani. Io fatico a spiegare quello che faccio ai miei coetanei, spesso mi sento porre domande come “davvero tu puoi avere contatti con i detenuti?”». La vecchia guardia del concorso del ‘97 d’altronde, che in molti casi ha scelto la professione per caso («anche se Dio solo sa quante volte l’ho scelta col cuore dopo» ammette ancora la direttrice di Brescia, Lucrezi), ha battuto la strada e sono lontanissimi i tempi in cui il maschilismo imperava negli uffici penitenziari, «con gli agenti che scortavano le direttrici nelle sezioni o facevano battute sull’abbigliamento» ricorda Rosalia Marino, direttrice a Vigevano («gli agenti, non i detenuti. Il maschilismo tra i detenuti non c’è stato mai» aggiunge Palù).
«Sono situazioni con cui la nostra generazione non s’è misurata» conferma la collega di Sondrio, Ylenia Santantonio, anche lei alla prima esperienza in un carcere. Come le altre in ruolo da poco, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, (c’è anche la vicedirettrice di Monza Roberta Galati) ha alle spalle un percorso di scelta più consapevole del ruolo di direttrice e considera il lavoro in carcere come un traguardo: «Al concorso sono arrivata dopo un’esperienza nel sociale e coi minori. Volevo cambiare le cose e prendere in prima persona le decisioni per poterlo fare – racconta –. Noi entriamo in quel pezzo di società che nessuno vuol vedere e con cui nessuno vuole avere a che fare, ma che della società fa parte e della società parla o dovrebbe parlare a tutti». «Il direttore dal mio punto di vista non ha sesso» sostiene invece ancora Pitaniello, sottolineando che la competenza e il modo di essere sono più importanti del genere. «Maschilismo non so – conferma Santandrea –, ma una cosa è certa: il carcere è un’istituzione storicamente maschile, concepita per gli uomini. Questo rende molto difficile per le detenute donne trovare il proprio spazio e adattarsi a un ambiente che non è pensato per le loro esigenze specifiche, anche in aspetti banali come l'assenza di specchi a figura intera per la cura personale». Esiste poi un “pregiudizio atavico” nella società, sostiene Antonicelli, «che non perdona alla donna il reato commesso, portando a una minore indulgenza rispetto all'uomo». Come se fossero più colpevoli, le donne.
Dirigere educando
Non solo direttrici. Al cuore del provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per la Lombardia, nell’Ufficio detenuti e trattamento, c’è dalla fine degli anni Ottanta anche Francesca Valenzi, educatrice di lungo corso ( ora si chiamano “funzionari giuridico pedagogici”) che poi ha passato il concorso da dirigente. Parla al femminile anche questo ambito, quello degli educatori nelle carceri, che dovrebbero essere molti di più e molto più formati: «Io ho scelto di lavorare dietro le sbarre, da giovanissima, lasciando il mio lavoro nelle comunità di tossicodipendenti. Mi chiedevano, i colleghi, “e come pensi di rieducarli i carcerati?”. Io sorridevo. Nel tempo ho imparato che vanno capiti, che serve il tempo e l’attenzione per individuare il movente del loro possibile cambiamento». Essere donna fa la differenza, nonostante le difficoltà coi detenuti stranieri che provengono da culture in cui il genere femminile non vive in condizione di emancipazione: «Ma la sensibilità femminile aiuta soprattutto di fronte a queste diversità: chi delinque e arriva da un altro Paese ha nella maggior parte dei casi una storia di fallimento migratorio alle spalle che va ascoltata, ricostruita, superata». Alla rieducazione servono percorsi individualizzati e risorse, che mancano come l’aria nelle celle del nostro Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA