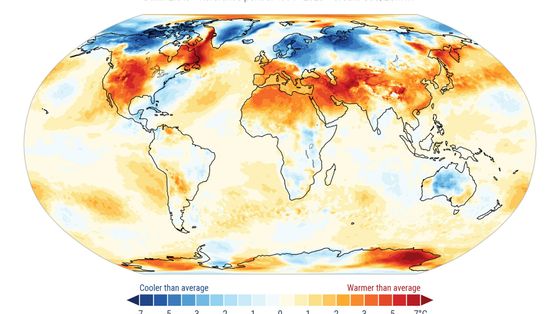Vincere gli Australian contro il generale inferno
di Davide Re
A Melbourne riparte la scalata di Sinner alla prima posizione mondiale. Nel femminile invece Coco Gauff proverà a scalzare le favorite Swiatek e Sabalenka

Gli Australian Open non dicono quasi mai chi vincerà l’anno. Dicono qualcosa di più sottile e forse più decisivo: chi è già pronto a non perderlo. Melbourne è una soglia. Non solo perché apre la stagione, ma perché costringe il tennis a mostrarsi per ciò che è diventato: uno sport di resistenza sistemica, dove il talento da solo non basta più.
Il primo avversario non è l’altro, ma il caldo. L’Australia è il luogo in cui il clima entra nel gioco come variabile strutturale: temperature estreme, partite spezzate, tetti chiusi, pause forzate. Qui il corpo è messo sotto pressione prima ancora che il tennis. E non è un caso se proprio a Melbourne si misura meglio la longevità reale, non quella anagrafica ma quella funzionale: la capacità di reggere più match lunghi, di recuperare, di non scomporsi quando il fisico chiede tregua. È una longevità che riguarda allo stesso modo ventenni e trentenni, campioni affermati e giocatori in ascesa.
In questo senso, il tennis maschile arriva agli Australian Open come a un banco di prova definitivo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rappresentano due modi diversi di attraversare la soglia: controllo e continuità il primo, esplosione e rischio il secondo. Melbourne non sceglie tra i due, ma indica chi riesce a portare il proprio tennis dentro condizioni ostili senza snaturarlo. Ed è qui che si apre uno spazio inatteso.
Perché se i grandi reggono, ma rallentano, la stagione può aprirsi anche a chi è appena sotto. Lorenzo Musetti è forse l’unica prospettiva credibile, oggi, di ingresso stabile nella top five se qualcosa si incrina ai vertici. Non per una rivoluzione improvvisa, ma per un processo: crescita mentale, miglior tenuta fisica, maggiore accettazione della fatica. Melbourne, più di altri Slam, può dirci se Musetti è pronto non tanto a vincere subito, quanto a restare competitivo quando il tennis smette di essere bello.
C’è poi un elemento che a Melbourne pesa più che altrove e che spesso viene letto solo in controluce: il tempo. Non il tempo del punteggio, ma quello della stagione che inizia. Gli Australian Open arrivano quando il corpo non è ancora rodato e la mente è ancora fragile, sospesa tra preparazione e realtà. È qui che il tennis mostra una verità scomoda: chi parte troppo forte rischia di consumarsi, chi parte piano rischia di non partire affatto. Melbourne chiede misura, non esuberanza. Chiede di saper perdere un set senza perdere il match, di saper attraversare una giornata storta senza trasformarla in una crisi. È un torneo che educa alla gestione dell’errore, non alla sua rimozione. Ed è forse per questo che, più di altri Slam, racconta il tennis contemporaneo: uno sport in cui la vittoria non è più un’esplosione isolata, ma una traiettoria lunga, fatta di aggiustamenti continui. In questo senso, l’Australian Open non è solo il primo appuntamento dell’anno, ma il luogo in cui si capisce chi ha già interiorizzato una verità fondamentale: la stagione non si conquista, si amministra.
L’Australia, però, è anche un paradosso emotivo. È lontana, isolata, quasi fuori dal mondo. Eppure è uno dei tornei più amati dai giocatori. Non perché si sia soli — oggi nessun tennista lo è davvero, circondato com’è da staff, dati, preparatori, fisioterapisti — ma perché qui la solitudine diventa scelta interiore. Lontani dall’Europa, dai media di casa, dalle aspettative immediate, molti trovano a Melbourne una concentrazione rara. È un isolamento che protegge, non che schiaccia. E questo fa la differenza. Ed è anche per questo che i match sono tutti così spettacolari.
Nel femminile, questa soglia è ancora più evidente. La stagione si apre attorno a un triangolo che non è rivalità classica, ma equilibrio instabile: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Tre modi diversi di stare in campo e nel mondo: il controllo totale e la pressione della numero uno, la potenza che ha imparato a governarsi, la giovinezza che deve convivere con un’esposizione mediatica enorme. Melbourne non incorona, ma mette a nudo. Qui si vede chi riesce a reggere l’aspettativa, chi accetta il ruolo e chi lo subisce.
E poi c’è un aspetto spesso sottovalutato, ma decisivo per capire il tennis contemporaneo: i doppi. Non solo come specialità autonoma, ma come laboratorio di collaborazione, lettura del gioco, adattamento. Gli Australian Open ricordano ogni anno che il tennis non è solo solitudine eroica. E per l’Italia, i doppi restano uno spazio di eccellenza e di possibilità concrete, maschili e femminili, spesso più vicine del singolare ai grandi risultati.
Alla fine, Melbourne non consegna certezze. Consegna indizi. Dice chi ha già superato la soglia del caldo, della fatica, della pressione. Dice chi può permettersi una stagione lunga senza spezzarsi. Gli Australian Open non dicono chi vincerà il 2026. Dicono, forse con maggiore precisione, chi non è destinato a perderlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA