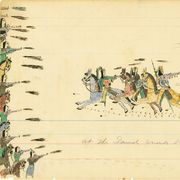Grandi tragedie della Storia e piccole comicità
Quella di Enrico Fink è una narrazione di fantasmi che va in profondità e aiuta a comprendere quanto i racconti di chi ci ha preceduto siano parte integrante di ciò che siamo
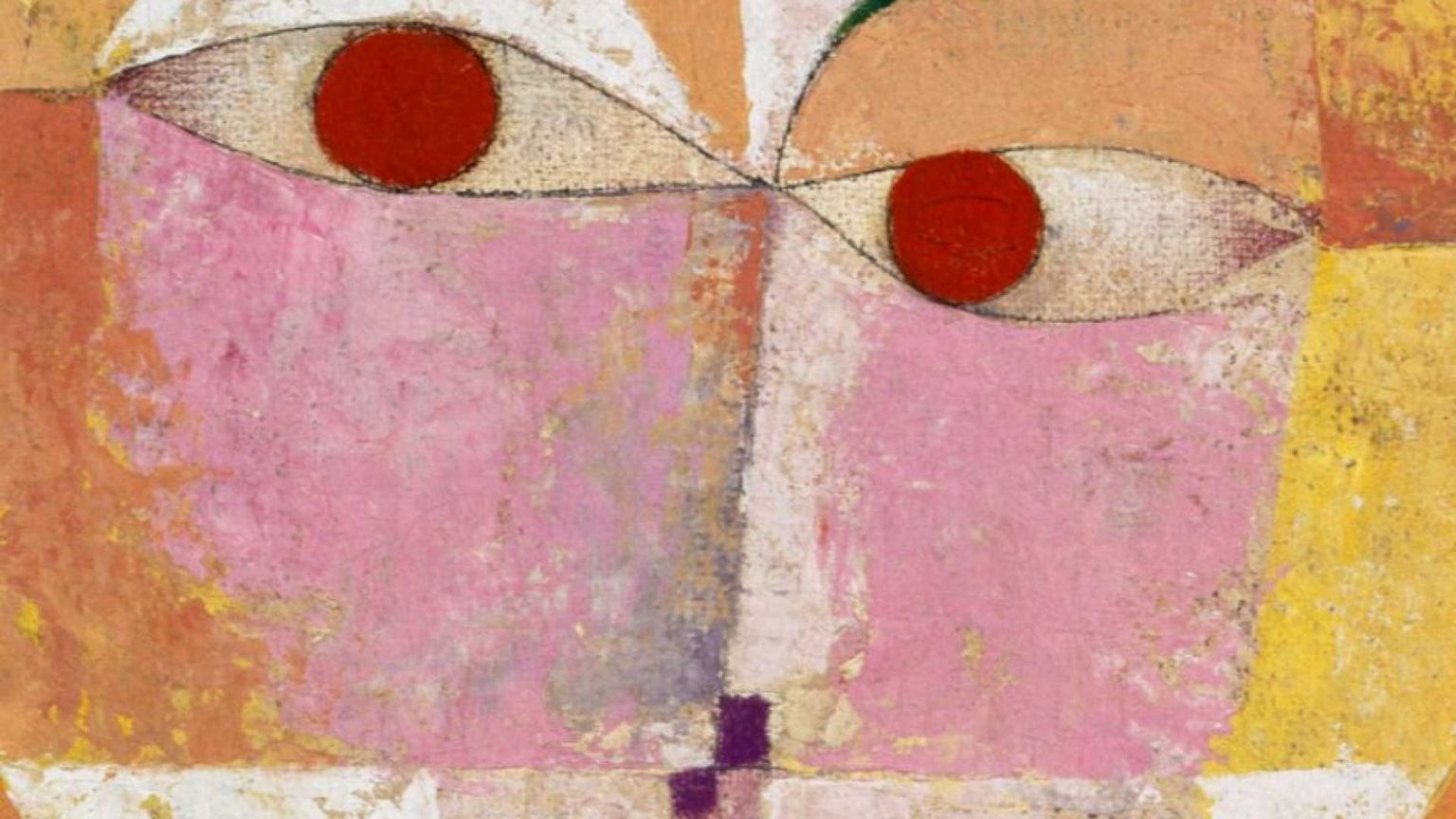
Divisa in quattro libri - nero, grigio, blu, marrone, come colori di una partitura musicale, o stagioni, o elementi, o fasi lunari, o punti cardinali, o i lati del quadrato, della terra, delle proporzioni umane, o le lettere del tetragramma, ma anche dei quattro figli diversi cui narrare l’haggadà di Pesach, l’Esodo e la redenzione, sotto i quali si celano i tre padri della propria stirpe maschile e lo stesso autore – l’opera di Enrico Fink (Patrilineare. Una storia di fantasmi, Lindau, pagine. 389, euro 21,00) è una storia personale e collettiva, un vero romanzo storico dentro il racconto del proprio apprendistato: una iniziazione alla Wilhelm Meister che per il protagonista dura circa trent’anni. Non a caso Fink si muove dall’ambito teatrale, dallo spettacolo musicale, con l’inserimento della tecnica cinematografica - antico espediente dei narratori e dei visionari - assorbito nel Novecento dal cinema, che è stato la passione del padre, grande studioso di letteratura anglo-americana (e non solo). Una telecamera offre il suo occhio con visioni da lontano, dall’alto, e da vicino, esplorando micro e macrocosmo, e offrendo il suo distacco. Enrico, che qui si chiama Elias, nome del nonno materno Bassani presidente della Comunità Ebraica di Ferrara, rievoca la nonna Laura, madre del padre Guido, la donna arguta, forte, la prima raccontatrice del passato, e unica superstite dall’eccidio del 15 novembre 1943, insieme al piccolo Guido di otto anni. Nella casa antica di via Mazzini dirimpetto alla Sinagoga, risuonano a Elias le parole che il proprio padre le rivolse nella notte dei rastrellamenti per la deportazione a Fossoli e poi ad Auschwitz: «Mamma, è questa notte che mi ammazzi?». Il libro inizia così dalla morte della nonna, e dalla nigredo: «Polvere sei e alla polvere ritornerai./ Il Signore è giusto giudice»: le parole della condanna di Adamo nell’espulsione dall’Eden, e il riconoscimento della giustizia che è Legge imprescindibile: Torà scritta a lettere di fuoco nero su fuoco bianco delle origini. Solo che il nipote, rimasto accanto a lei fino all’ultimo, non può assistere al funerale della nonna amatissima. Deve correre a suonare il suo flauto per vivere, e lo fa in una discoteca della campagna fiorentina – abitano da tempo a Firenze - con sensi di colpa e incubi infiniti. Lo insegue l’Ombra: più terribile delle Erinni che tormentano Oreste. L’abile, ispirato musico e cantore - che è Enrico-Elias – possiede l’arte atavica della sdrammatizzazione, dell’alleggerimento, del détour e del depistaggio: sicché da questo momento tutta la partitura sarà un’alternanza di tremendo e di felice, di leggero e di duro al fondo tragico. Mentre vive la sua esperienza a colori psichedelici, descrivendola con i toni tragicomici di un’intensa autoironia, affonda contemporaneamente nella memoria, vedendo dovunque segni, coincidenze, premonizioni. Sinché lui stesso, che ne è al centro, riuscirà a concludere la storia pluricentenaria, di cui si è riappropriato, nella conciliazione e nel rimescolamento dei quattro diversi figli di cui è l’ultimo: dialogando con l’Ombra. Quando Elias torna nella casa avita, tutto è coperto di polvere. Esplora le cantine che s’inoltrano sotto la via, le soffitte colme di mobili e cimeli, i grandi armadi pieni di oggetti e ricordi. Scruta le foto dalle quali gli antenati lo guardano. L’Ombra lo segue, anche se prende la forma protettiva di Giancarlo Rossi, il poeta stesso dell’Ombra, che i suoi stimavano al pari di Giorgio Bassani, il quale era stato supplente nella scuola ebraica dove Laura insegnava disegno, e che sul suo matrimonio con l’askenazita venuto dalla Russia, connubio tra una delle più antiche famiglie ebraiche a Ferrara dal Rinascimento e un profugo dell’Est, aveva incentrato quella che chiamava Fiaba, un racconto del Romanzo di Ferrara. Rossi diventa un Hermes traghettatore, un nume benefico e discreto, con la sua bicicletta, i suoi gatti, fino all’evoluzione di Enrico-Elias, quando egli compirà la scelta, apparentemente paradossale, di diventare ebreo praticante a partire dalla circoncisione, sebbene ebreo fosse soltanto il padre, nemmeno osservante, e laico. Dopo studi rabbinici, è diventato presidente della società Ebraica di Firenze. Dal Museo del Passato retto da Persefone, è impossibile estrarre vita, se non fantasmatica, come sa Faust. Come rianimare la polvere? Intanto Elias è il primo a smuoverla. Perlustra, indaga, mentre cerca se stesso. Il percorso è davvero difficile. Intervista il padre. Chi altri? Guido aveva scritto Le tre notti del 1943 sul film di Vancini (La lunga notte del ’43) ispirato a Una notte del ’43 di Bassani, di cui aveva prefato Cinque storie ferraresi, rievocando altrove memorie sulla scuola ebraica e via delle Vigne dov’è il cimitero (ora leggibili insieme nella bella antologia curata da Roberto Barbolini, Nel segno di Proteo, Guaraldi 2015). Ma qui ecco che le sue parole escono dal registratore come stampate, raccontando diffusamente il puro orrore: il precario rifugio in campagna scelto dalla madre, mentre i nonni vengono venduti dai contadini, che pure avevano pagato perché li nascondessero: e il padre Isidoro, vagando in bicicletta per non farli scoprire, apprende che sono stati portati via, e fugge, finché viene catturato, imprigionato insieme a tutti gli altri della famiglia: infine deportati ad Auschwitz, moriranno. Alla figura di Isidoro Enrico dedica diverse belle pagine, dall’infanzia a Gorizia, al traumatico collegio di Torino nella Prima guerra, alla terrificante, assurda, e nobile fine. Il libro è di una tale ricchezza e profondità, che non consente di essere riassunto: ogni descrizione è un dettaglio fondamentale, perché Fink riempie di echi e rimandi una storia antichissima e tragica, che non è storia privata. I simboli dai quali dipende il cristianesimo sono vissuti nella carne. Ogni senso dei rituali si rinnova nei segni, nei movimenti, nella concretezza della vita quotidiana, come nel canto che gli amanti di Dio non si stancano di levare. Il bisnonno Benziòn, ossia “figlio di Sion” emigra dalla Russia con la moglie Rosa alla fine dell’Ottocento, non per i pogrom, ma in cerca di commercio di acciaio, a Gorizia. Non va in Palestina, sceglie l’Italia. Ma i piani non decollano, e poi verrà la guerra. Umile segue la Shekinah, l’ultima traccia di Dio. Si adatta a cantore e a custode: ne libera le scintille divine, mentre rimuove la polvere spazzando, e mette in salvo i rotoli della Legge coronati, durante i bombardamenti: e con la medesima delicata, solenne umiltà, ubbidendo ai precetti, dopo avere seguito il figlio Isidoro sposo a Ferrara, proprio fino all’inerme dolcezza del giusto, fiducioso, resta preda dell’assassino fascista e nazista. Ma sempre quella sua voce dall’accento straniero si leva, anche sotto le bombe, trasmettendo preghiera e lode, come nel Kaddish che Guido pronuncia incerto, e che è la paradossale glorificazione del Signore nella morte, nel tema costante della giustizia. Il mite e agguerrito romanzo di Fink si chiude con una visione fantastica di trasmissione stellare. È un fisico che ha rinunciato a una brillante carriera universitaria, e crede sia nel ricompattarsi dei grani di polvere verso nuova vita, sia nella vibrazione del canto che si irradia fin sulla luna con il senso di quella benedizione che è lode e protezione insieme: una pace che assomiglia a questa: «Altissimu, onnipotente, bon Signore,/ tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA