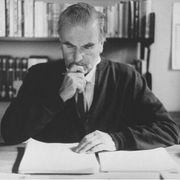Le domande senza risposta dei nativi americani
La parabola dei vinti non finisce mai di interrogarci, ogni volta che un popolo viene ridotto a metafora, a folclore. Il nuovo saggio di Claudio Ferlan

«Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek». Ognuno ha i suoi fantasmi culturali, i propri miti d’infanzia: per qualcuno sono i versi di De André, per altri le pagine di Tex Willer o il crepuscolo polveroso dei film di Sergio Leone. È da lì, da quell’immaginario in bilico tra epica e colpa, che comincia Il lungo sentiero. La storia mai conclusa dei nativi nel Nordamerica, edito dal Mulino (pagine 248, euro 22,00) e firmato da Claudio Ferlan, ricercatore all’Istituto storico italo-germanico di Trento. Il cuore del libro non è la cronaca di un genocidio – sebbene di genocidio si tratti, e il termine non sia eccessivo –, ma la lenta consapevolezza che la parabola dei vinti non finisce mai davvero: continua a interrogarci, ogni volta che un popolo viene ridotto a metafora, a folclore, a ombra di sé stesso. Non siamo di fronte a un racconto edificante. L’autore non cede alla tentazione dell’indignazione. Sceglie, al contrario, il passo lungo della storia: dal primo incontro con gli europei fino alla rinascita culturale dei movimenti indigeni contemporanei, attraversando secoli d’invasioni, deportazioni, promesse tradite, resistenze silenziose. Il sottotitolo non allude soltanto alla persistenza dei conflitti territoriali o identitari. È la cifra d’una condizione morale: quella di un’umanità che non ha ancora imparato a convivere con l’alterità, e continua a risolverla con il rifiuto, la marginalità, l’appropriazione.
L’arco narrativo è ampio e coerente. Dalle prime interazioni tra mondi – “i primi contatti”, prima e dopo il 1492 – all’organizzazione di un “Mondo Nuovo”, il libro ricostruisce la progressiva trasformazione dell’incontro in dominio. Il commercio, la missione religiosa, la cartografia e le prime forme di amministrazione coloniale diventano i tasselli di un processo di rimozione. L’Europa, persuasa di portare civiltà, inventa il modo di legittimare la conquista. Ferlan mostra come la libertà proclamata per i coloni si accompagni alla negazione di quella altrui: un’idea di democrazia che si fonda sull’esclusione. La costruzione dell’America coincide con la cancellazione dei suoi popoli originari. La “conquista del West”, le riserve, le migrazioni forzate, le battaglie e i trattati violati compongono il grande affresco di una civiltà che si proclama libera mentre costruisce recinti. Non è difficile percepire la risonanza universale di tali meccanismi: l’idea che la sicurezza di alcuni richieda la scomparsa di altri. Ma Ferlan non cede alla polemica; il suo tono rimane analitico, documentato, attento alla complessità dei contesti. L’obiettivo non è giudicare, ma comprendere come un intero sistema politico, culturale e religioso abbia potuto rappresentare l’espulsione come una necessità morale. In questo senso, Il lungo sentiero è anche una riflessione sulla fragilità della modernità: sul prezzo umano della conquista, sul nesso tra sviluppo e distruzione, tra memoria e oblio. Negli ultimi capitoli, la prospettiva cambia. Dopo il 1890, quando le guerre finiscono, inizia un’altra fase. I nativi sono integrati solo in apparenza, resi invisibili attraverso le leggi, la scuola, la religione, la burocrazia. La violenza non si manifesta più nella strage, ma nella pedagogia, nell’assimilazione, nella normalizzazione. È il tempo in cui il genocidio si traveste da progresso. E, tuttavia, la storia riapre il suo respiro. Ferlan sottolinea come, nel secondo Novecento, le comunità native abbiano riscoperto le proprie lingue, le tradizioni, i diritti, e abbiano trasformato la memoria in strumento politico. Non si tratta di un lieto fine, perché nessuna ferita è davvero rimarginata; ma è il segno di una vicenda che, come il titolo promette, non si è mai conclusa.
Il destino dei nativi nordamericani interpella l’Occidente. È una parabola universale del potere e della memoria: ogni volta che una civiltà si costruisce sull’idea di “civilizzare” l’altro, ripete lo stesso copione. Così, dietro il racconto delle guerre indiane, delle riserve, delle scuole di assimilazione e dei trattati violati, s’intravede un discorso più ampio sulla violenza della modernità. Ciò che emerge non è solo la conquista del West, ma quella del racconto: l’appropriazione dell’immaginario, l’esclusiva d’una narrazione. Il cinema, la letteratura popolare, la retorica patriottica hanno fatto il resto, trasformando le vittime in comparse, i carnefici in pionieri, l’espropriazione in destino. Ferlan lo mostra senza enfasi, lasciando che a parlare siano le fonti, le testimonianze, le voci dimenticate. Con ciò, la lezione che se ne ricava è di straordinaria attualità. Restituire ai nativi la densità della loro vita, il diritto alla complessità, l’elementare riconoscimento di esistere come soggetti e non come simboli è, dunque, un’operazione di giustizia e di restituzione: un modo per ricomporre, almeno in parte, la frattura tra chi ha scritto il passato e chi l’ha subito.
Insomma, Il lungo sentiero non è solo un libro sul passato. Invita a guardare di nuovo ciò che credevamo di conoscere, a restituire nomi ai volti cancellati, a riascoltare parole che la conquista aveva ridotto al silenzio. È un gesto contro l’oblio e contro la retorica, un invito a fare della memoria non un repertorio di rimpianti, ma una forma di responsabilità. Perché la storia, ci ricorda Ferlan, non appartiene ai vincitori più di quanto il futuro appartenga a chi lo possiede: resta sempre aperta, come un sentiero che attende di essere percorso ancora. Lasciata l’ultima pagina, il lettore ha una duplice impressione: quella di aver attraversato un continente di dolore e, insieme, di avere toccato la radice di una speranza. La conclusione è sobria ma luminosa: le lingue indigene che risorgono, i movimenti per la tutela delle terre sacre, le rivendicazioni culturali e spirituali che tornano a farsi sentire. Perché, conclude Ferlan – riportando una frase di un libro famoso, Seppellite il mio cuore a Wounded Knee, di Dee Brown –, non bisogna dimenticare un aspetto fondamentale: nonostante tutto, «we’re still here».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi