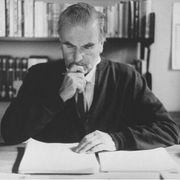Samorì, il sacrificio della pittura come varco per la bellezza
L’artista crea opere “perfette” che poi distrugge: la personale allestita tra Pinacoteca Ambrosiana e Capodimonte

Da quando con l’Umanesimo la cultura occidentale non si è più sentita in diretta continuità con il tempo antico ma ha percepito per intero lo scarto e la frattura, il sentimento che l’ha legata al mondo classico è stato quello della rovina e della distanza, a cui rispondeva contemporaneamente il desiderio di ricostruzione, per ripristinare un ideale di compiutezza perduta. Un’illusione (o un sotterfugio) che fu chiara a tutti solo quando la coscienza acquisita della sua irreparabilità divenne motivo struggente del sublime. Così la modernità in ultimo ha dichiarato l’impossibilità della bellezza. Dio è morto, anche quello dell’arte. E se, invece di tentarne scipiti surrogati, solo l’accettazione del collasso di ogni ideale – metafisico o individuale – di perfezione (di più: sposarne la sconfitta) fosse oggi il modo attraverso cui si rivela possibile la bellezza autentica? Al presente si può fare grande pittura solo ammettendone lo scacco permanente?
Sembra essere questa la linea di Nicola Samorì, tra gli artisti più dotati della sua generazione (e non solo italiani), che da tempo ha messo al centro del proprio lavoro il confronto con la grande tradizione pittorica, in primis barocca ma non solo, e non attraverso anacronismi o pastiche linguistici, ma per via frontale e tragica. Nei suoi lavori l’immagine si costruisce attorno a vistose imperfezioni della materia o va sfasciandosi non appena raggiunto lo stato compiuto. La distruzione e la ferita appaiono come varchi di una metamorfosi, da intendersi non come passaggio ad altro ma come una forma che trova una paradossale gloria vitale e precaria solo se attraversa, contraddice e cancella continuamente se stessa.
I suoi lavori sono al centro della mostra “Classical Collapse”, a cura di Demetrio Paparoni, Alberto Rocca ed Eike Schmidt, che rappresenta un’importante collaborazione tra la Pinacoteca Ambrosiana di Milano e il Museo di Capodimonte a Napoli. Allestita simultaneamente nelle due sedi – fino al 10 marzo a Milano e fino al 1° marzo a Napoli – l’esposizione pone i dipinti e le sculture di Samorì indialogo diretto con i capolavori delle rispettive collezioni, in una serie di confronti che figurano come pietra di paragone per la tenuta di un artista. Se a Capodimonte le sue opere si trovano in confronto diretto con le loro fonti, dirette o ideali (come ad esempio The Veil accanto agli Apollo e Marsia di Ribera e Luca Giordano, tra i suoi artisti di riferimento), a Milano Samorì ha realizzato La Scala, una tecnica mista su carta di proporzioni gigantesche (5 x 10 metri) collocata accanto al cartone della Scuola di Atene. L’armonia umanistica di Raffaello è dispersa in una visione di spettri ma, come nel cartone, la scena resta saldamente composta attraverso un montaggio di gruppi autonomi, per quanto ormai ridotti a disiecta membra. Nelle singole figure converge una moltitudine di riferimenti, da Fidia a Bacon, che testimonia la vastità della cultura visiva di Samorì. «La scala – dice l’artista – è una sorta di grande macchia dalla quale ho estrapolato, di giorno in giorno, immagini che giacciono nella mia memoria come in un deposito silente, pronte a riaffiorare. È una macchina per provocare immagini e lo spazio dove questi fantasmi si danno convegno».
Nel suo testo in catalogo (Moebius, progetto grafico studio Sonnoli) Paparoni offre una lettura filologica del lavoro di Samorì destinata a restare di riferimento, ricostruendo in modo puntuale genealogie, processi e spinte tematiche che convergono in questa ossimorica unione del “classico” e del “collasso”. L’immagine nasce sempre da un confronto diretto con un modello storico, assunto come un dispositivo di camouflage per «nascondere le reali finalità che l’opera intende perseguire – osserva giustamente Paparoni – ossia attraversare l’arte del Novecento». La prima fase del processo è una dimostrazione di controllo tecnico e adesione formale. Nel secondo momento ha luogo l’intervento distruttivo, non privo di una vena sadica. Il trauma inferto all’immagine compiuta, in una interessante analogia con Richter, è l’atto che ne determina il senso: come osserva Rocca, il vulnus diventa «parte legittima della forma». Se la copia antica nasce per appropriarsi dei segreti dell’immagine e per moltiplicarla, la replica in Samorì (di nuovo, come in Richter) dichiara inattingibile l’originale, dissolvendolo. La ferita, ampiamente esaminata in catalogo anche da Schmidt, con numerosi riferimenti alla storia della cultura, diventa costruzione di una tradizione attraverso il suo sabotaggio: come d’altronde accade in ogni tradizione autentica. «Il suo alterare immagini ricche di storia – scrive Paparoni – è un modo di prendersene cura, di rivitalizzare la memoria collettiva assopita».
Scorticamenti, corrosioni, incisioni, piegature, strappi: ogni tipo di aggressione è calibrato sul materiale e ne segue resistenza e fragilità. Il corpo del quadro si identifica con quello dell’immagine. C’è una precisa corrispondenza tra tecnica aggressiva, supporto (non di rado rame e pietre come l’onice) e soggetto, come nel caso dei màrtiri, da san Bartolomeo (scuoiato) a Lucia (alla quale vengono cavati gli occhi). Lo stesso Samorì chiarisce che «un dipinto è sempre una pelle che riveste uno scheletro: la tela, il telaio, il muro, il foglio. Una volta costruito il corpo della pittura per me è quasi automatico pensare che se ne possa scorticare la pelle per mettere in evidenza le prime pennellate... Il rovescio della pittura, come la parte nascosta della pelle, rivela allora qualcosa di fresco e di brutale». Lo scorticamento diviene un’azione simbolica che permette di «entrare nelle viscere della pittura», mettendo in contatto il piano visibile e «addomesticato» con quello interiore e «indomito».
Si riconosce qui una eco della poetica di Fontana, come anche di Burri. Samorì ci arriva attraverso la storia dell’arte, in modo radicale. Nel caso della scultura i motivi di studio, con le loro forme piene di vuoti, sono Bambaia, del quale l’Ambrosiana custodisce diversi rilievi, e Wildt (che di Fontana era stato maestro e che allo scultore rinascimentale aveva guardato con passione). Da loro riprende la capacità di rendere il marmo, nelle parole di Paparoni, «molle come una forma disossata», spinto fino al limite tecnico per dare forma a una «elegia del vuoto». L’esito, che sia pittura o scultura, supera sempre la tecnica. Se l’approdo è il sacrificio dell’immagine, è solo per restituirla, attraverso l’annichilimento, alla sua natura originaria, rovente e liberatoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi