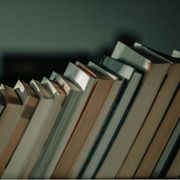Ravasi: «Vi racconto la dolce forza di Arnaldo Pomodoro»
Il cardinale, che gli fu amico, ricorda lo scultore scomparso: «Una sua Croce, severa e luminosa, tormentata eppure armonica, mi sta davanti agli occhi mentre scrivo queste righe»

Arnaldo Pomodoro, tra i più importanti artisti italiani del secondo Novecento, è scomparso domenica il giorno prima di compiere 99 anni. Pubblichiamo un ricordo del cardinale Gianfranco Ravasi.
Vivevo allora a Milano, ove ero prefetto della Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana. Là, quand’era di passaggio a Milano, veniva a visitarmi Ermanno Olmi, un amico a cui ero da tempo legato sia come ammiratore della sua emozionante produzione cinematografica, sia per la sua straordinaria umanità e sincerità. Fu lui un giorno a realizzare un mio antico desiderio, quello di incontrare Arnaldo Pomodoro nel suo studio sui Navigli. Si compiva, così, quello che anni prima – fin da quando ero ancor giovane sacerdote ed ero rimasto affascinato dall’Orestea di Gibellina – consideravo una semplice aspirazione illusoria: conoscere l’artista che riusciva a collaborare con la natura nell’erosione, nello scavo, nella penetrazione della realtà, incarnata nelle sue grandiose sfere bronzee. In una mattinata luminosa di primavera, entrai dunque con Olmi nell’atelier di Pomodoro, in quella affollata galleria di simboli e di presenze, accolto proprio dall’artista che ci conduceva per mano, quasi in un pellegrinaggio sacro e profano al tempo stesso. Pomodoro, però, non aveva nulla del liturgo ieratico né dell’artista altezzoso e fiero della sua trascendenza creativa e creatrice: era una persona essenziale, e netta fin nella sua stessa fisionomia, dotato di quella virtù suprema che è la semplicità, colorata persino di dolcezza. Quella mattinata si concluse davanti a una mensa all’interno di una delle trattorie tradizionali di quel quartiere suggestivo di Milano, accanto a tavoli ove persone della quotidianità più normale salutavano e interloquivano spontaneamente con Arnaldo. Era nato, così, un legame che si intrecciava – quasi esistesse da sempre – con quello che mi univa a Ermanno. Si configurava un’amicizia che il filosofo e poeta americano Ralph W. Emerson avrebbe definito “implicita” perché capace di vivere anche senza incontri diretti, verifiche, dialoghi.
Questo per me idealmente si ripete anche ora che da anni ho lasciato Milano e sono approdato in Vaticano. Ogni volta che attraverso il grandioso Cortile della Pigna, lo sguardo mi cade spontaneamente sull’imponente Sfera con sfera di 4 metri di diametro che Arnaldo ha donato nel 1990 ai Musei Vaticani. Lacerata dall’interno, segnata da profondi tagli che fanno emergere un’altra sfera celata in quella maggiore, quest’opera sembra esistere là da sempre, incastonata nell’armonia degli spazi architettonici che la circondano. Ogni volta il mio pensiero corre appunto, in una sorta di dialogo “implicito”, con l’artista-amico. Mi sembra in tal modo di ascoltare le sue parole quando mi mostrava il senso di quelle sue creazioni dalla “pelle” così sensuale e vellutata, eppure così ferite dall’“erosione” e dagli squarci: « Durante il giorno, alla luce del sole o all’ombra, le mie sculture cambiano. Gli effetti specchianti includono l’orizzonte esterno e lo spettatore che nella sfera si riflettono in un’immagine inedita e distorta. Questo rende la scultura viva, parte di noi e della natura». Certo, da teologo, potrei anche intuire in quelle ferite come delle feritoie che infrangono la superficie per svelarci il mistero che si annida nell’essere e nell’esistere. Questo, però, non esclude la “drammaticità” che alle sue sfere Pomodoro assegna quando in quelle spaccature intravede invece «il potenziale distruttivo che emerge nel nostro tempo di disillusione».
L’implicito, però, può talora esplicitarsi. Sono momenti particolari in cui ci si ritrova e, come se ci si fosse lasciati soltanto da poche ore, si riprende il filo del discorso. Vorrei evocare solo due incontri. Era il 4 luglio 2011 e il papa Benedetto XVI aveva da pochi giorni celebrato i 60 anni dalla sua ordinazione sacerdotale. Nell’atrio dell’Aula Paolo VI avevo convocato 60 artisti delle più diverse discipline per un ideale augurio espresso attraverso le loro opere. Anche Arnaldo accettò di partecipare e lo fece con un emblema “sofferto”. Già a Milano mi aveva narrato la sua amarezza di non aver potuto realizzare i portali del duomo di Cefalù per ragioni estrinseche di indole socioburocratica. Aveva, allora, deciso di inviarmi per quell’esposizione una specie di dittico: in esso, su carta intelaiata, in acrilico appariva la “Porta dei Re” abbozzata per quella cattedrale. Nella prima tempera si presentavano i due battenti aperti visti dall’interno, mentre in basso al centro era posta una sfera lucida. Nel secondo studio, ecco invece il portale in tutto lo splendore del tema evangelico scelto, la Trasfigurazione. Pomodoro aveva coagulato nella base il magma terrestre come contrappunto alla “nube luminosa” dell’orizzonte superiore ove era risuonata la voce del Padre celeste: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo!». Con originalità Arnaldo aveva, però, intrecciato Trasfigurazione e Ascensione di Cristo e spiegava: «Trattandosi qui della divina trasformazione del Cristo, risorgente dalla tomba, per ascendere al cielo, alla sfera celeste, all’assoluto, da parte mia occorreva mostrare come la forza di questa ascensione sublime dissolvesse la terra che la tratteneva, in forma gloriosa ed esaltante: mentre l’uomo-Dio si trasfigura in un moto di liberazione (per sé e per tutti gli uomini idealmente). Ho quindi realizzato il cielo o l’aldilà in una lucidissima sfera d’oro e ho voluto che il magma terrestre si diffondesse attorno alla base come alone, nella presenza alta della nube luminosa con la voce del Padre». Ora questi due studi di notevoli dimensioni (152 x 100 cm) parte della Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani.
Ma c’è anche un secondo e ultimo incontro diretto che vorrei rievocare. Esso si raccorda spontaneamente al primo da cui siamo partiti. Nella piazza San Pietro, durante la solenne celebrazione conclusiva dell’Anno della Fede, il 24 novembre 2013, a rappresentare l’arte davanti a papa Francesco avevo invitato proprio loro due, Ermanno Olmi e Arnaldo Pomodoro. Fu nello scenario imponente e solenne della Basilica e nell’abbraccio del colonnato del Bernini che anche noi ci abbracciammo, memori di quel primo incontro lontano almeno una quindicina d’anni eppure ancora intatto nel ricordo. Anche allora l’implicito si manifestava, il sottinteso si svelava, il tacito si esprimeva senza nessuna soluzione di continuità. Ma lo splendore epifanico e la potenza drammatica dell’opera di Pomodoro, sempre associati alla semplicità pacata e serena della sua amicizia, continuano anche adesso ad accompagnarmi. Infatti, una sua Croce, severa e luminosa al tempo stesso, tormentata eppure armonica, mi sta davanti agli occhi nello spazio ove ogni giorno scandisco i miei giorni, i miei incontri, il mio impegno ecclesiale e ove scrivo ora questo mio ricordo a lui dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi