Charles Townes: la luce che nasce quando due mondi si parlano
Per tutta la vita ha mantenuto un tratto che oggi potremmo definire rivoluzionario: non ha mai separato la sua fede dalla sua scienza. Le riconosceva come due strumenti, entrambi necessari, per esplorare qualcosa di più grande
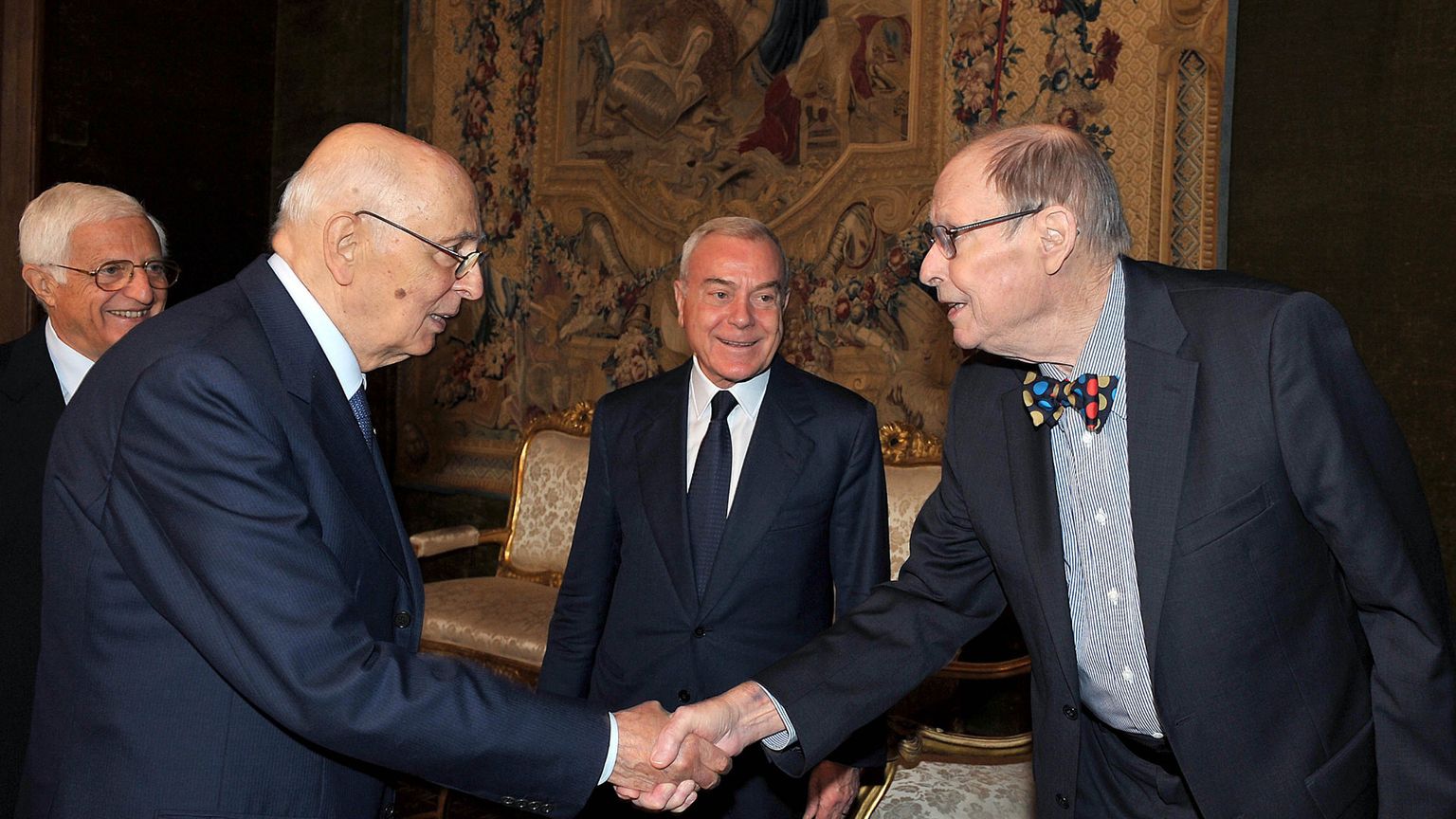
C’è un’immagine che mi torna sempre in mente quando studio la vita di Charles Townes. Non è un laboratorio, non è un Nobel, non è un esperimento. È lui seduto su una panchina, a New York, all’alba, nel 1951.
Le strade ancora vuote, il traffico non è cominciato, i taxi dormono come animali stanchi. E Townes, in quell’ora sospesa, sente che un’idea gigantesca sta arrivando. Non sa ancora come chiamarla, non sa come costruirla, non sa se funzionerà. Ma sente che è lì. E mentre tutto si apre nella sua mente, lui la descriverà più tardi così: «Fu un momento di rivelazione».
Non usò termini tecnici, non parlò di calcoli. Parlò di rivelazione. E questo dice tutto. Ed è proprio da qui che io parto nelle mie ricerche: dai momenti in cui le vite dei fisici non sono fatte di formule, ma di epifanie. Di attimi in cui la razionalità da sola non basta a spiegare ciò che accade dentro una persona. Di momenti che non trovi nei manuali, ma nei loro quaderni privati, nelle interviste tardi nella vita, nella luce particolare di certe frasi che sembrano scivolate fuori senza difese.
Charles Townes per tutta la vita ha mantenuto un tratto che oggi potremmo definire rivoluzionario: non ha mai separato la sua fede dalla sua scienza. Non perché le confondesse. Ma perché le riconosceva come due strumenti, entrambi necessari, per esplorare qualcosa di più grande. Townes nasce nel 1915 in una famiglia profondamente religiosa della Carolina del Sud. La sua fede non è dogmatica: è un modo di guardare le cose. Un’abitudine. Un gesto quotidiano. E questa postura interiore la porterà con sé in tutti i laboratori in cui lavorerà: dal Bell Labs al MIT, alla Berkeley.
Quando entro negli archivi che lo riguardano – negli appunti, nelle foto sgranate degli anni Sessanta, nelle lettere ai colleghi – trovo un uomo che cerca, sempre. Che non si accontenta. Che si domanda cosa significhi davvero “capire”. E questa, permettetemi, è la domanda che muove anche me.
Quando cerco storie per questa rubrica, quando rovisto nelle vite dei fisici, cerco quel punto in cui l’essere umano smette di essere solo un ricercatore e diventa una persona. La storia del laser, quella che tutti conosciamo, comincia molto prima delle equazioni. Comincia in quella panchina, in quell’alba. Townes racconta che sentì una “chiarezza improvvisa”, come se qualcosa dentro di lui si fosse allineato. E, cosa ancora più sorprendente, disse che non vide nessuna differenza tra quel tipo di intuizione e ciò che lui chiamava “ispirazione spirituale”. Pensava che la creatività scientifica fosse una forma di grazia.
Non nel senso religioso stretto, ma come un dono. Come qualcosa che non controlli del tutto. I suoi colleghi più scettici, negli anni, gli dissero di lasciar perdere. «È impossibile», «la fisica non funziona così», «non ha senso». Lui non litigò, non alzò la voce, non si arrabbiò.
Fece ciò che fanno gli uomini profondamente radicati: continuò. Quando finalmente l’esperimento riuscì, quando la luce coerente – il laser – divenne realtà, molti provarono a raccontare la cosa come un trionfo puramente tecnico. Ma basta leggere le sue memorie per capire che per Townes non fu mai così. Diceva: «La scienza e la fede cercano entrambe la verità. E la verità è una sola».
In un mondo che ama le divisioni nette, questa frase è ancora oggi un terremoto. E mentre continuo le mie ricerche – tra lettere, conferenze, interviste – mi accorgo che Townes non cercava di “dimostrare” nulla.
Non voleva convincere nessuno. Viveva semplicemente in uno spazio doppio, in cui la scienza gli diceva come funziona il mondo e la spiritualità gli diceva perché vale la pena cercare. E qui entra la mia ricerca, quella che porto avanti da puntata a puntata: cosa accade agli esseri umani che non accettano di tagliarsi in due? Che non rinunciano né alla loro razionalità né alla loro interiorità? Che non si vergognano né dell’una né dell’altra?
Townes era uno di loro. Un ponte. Un equilibrio. Una figura che oggi, forse, avremmo più che mai bisogno di ascoltare. Negli ultimi anni della sua vita, già molto anziano, continuava a dire che la curiosità è una forma di gratitudine.
Una frase che vorrei incidere su un muro. Una frase che racconta tutto il suo percorso. E allora arrivo alla domanda finale. Una domanda larga, morbida, aperta, come dovrebbe essere ogni conversazione vera. Tu, oggi, dove senti nascere le tue intuizioni più luminose? Nella concentrazione? Nel silenzio? Nel caos del quotidiano? Nelle cose che fai senza pensarci? Nelle parole di qualcuno che non vedi da tempo, ma che ti sono rimaste dentro? O forse in uno di quegli attimi sospesi che non sappiamo spiegare, ma che ci cambiano la direzione?
Raccontamelo. Con un’immagine, un episodio, una frase che non ti lascia più. Leggerò tutte le vostre risposte: potete inviarle a interferenze@avvenire.it o (se brevi) nei commenti sui social network.
Raccontamelo. Con un’immagine, un episodio, una frase che non ti lascia più. Leggerò tutte le vostre risposte: potete inviarle a interferenze@avvenire.it o (se brevi) nei commenti sui social network.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







