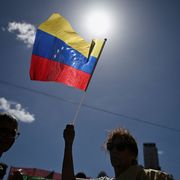Terra e sicurezza, prima via per la pace Israele-Palestina
Che cosa insegna la lunga storia di guerre e di fragili intese
Una preghiera per invocare la pace su di una delle terre più tormentato. Una preghiera a più voci quella offerta da papa Francesco, che si ritroverà domenica in Vaticano con i presidenti di Israele, dell’Autorità nazionale palestinese e del patriarca ecumenico ortodosso, Bartolomeo. Per cercare di ridare forza e speranza a un percorso di pacificazione che sembra ormai smarrito fra veti incrociati, estremismi e sfiducia sulla possibilità che possano davvero coesistere pacificamente due Stati, Israele e Palestina. Difficile riassumere le tante motivazione che rendono così complesso raggiungere un compromesso accettabile, soprattutto a causa del pre-giudizio ideologico che ha sempre caratterizzato il dibattito sul problema israelo-palestinese. E tuttavia è impossibile non partire dalla storia per cercare di comprendere le radici profonde di questo conflitto.L'idea di un ritorno a Eretz Israel, la Terra di Israele, è parte della storia del popolo ebraico; ma è solo con il sionismo politico alla fine del XIX secolo che si forma un movimento organizzato che propugna la nascita di uno Stato nazionale per gli ebrei. Il fondatore, Theodore Herzl, immaginava Israele come un’entità laica e moderna, che proteggesse gli ebrei oggetto di crescenti campagne anti-semite in tutta Europa. Fra la fine di quel secolo e la Prima guerra mondiale gruppi sempre più numerosi di ebrei si trasferiscono in Palestina – allora un territorio poco abitato all’interno dell’Impero ottomano – comprando terre e organizzandosi in Kibbutz, comunità agricole comunitarie che formarono lo zoccolo della presenza ebraica nella regione. Nel 1917, la famosa dichiarazione di Lord Balfour, del governo britannico, sembra aprire la strada per la creazione di uno Stato ebraico, ma il dopoguerra deluderà le speranze sioniste. Al contrario, in una Palestina controllata dagli inglesi, la crescente immigrazione ebraica fece crescere le preoccupazioni arabe e alimentò un senso di ostilità che si tradusse nello scoppio di violenze crescenti. Dopo la Seconda guerra mondiale e il dramma della Shoah, le neonate Nazioni Unite proposero di dividere la Palestina in due Stati, scontrandosi tuttavia con il rifiuto degli arabi, che accettarono la presenza di minoranze ebraiche nella regione, ma solo all’interno di un’unica entità araba. Ritiratisi gli inglesi nel 1948, gli ebrei proclamarono unilateralmente lo Stato di Israele. La risposta degli Stati arabi fu una guerra (quella del 1948-49) per distruggere Israele: mal condotte e prive di coordinamento, le truppe arabe vennero sconfitte dagli israeliani, i quali ottennero uno Stato più grande del previsto e anche metà città di Gerusalemme. Per i palestinesi fu la nahba, la catastrofe, che portò all’emigrazione (ma anche alla cacciata violenta da parte israeliana) di parte della popolazione, che si rifugiò negli Stati vicini (dove a milioni vivono ancora oggi da profughi). Per decenni, vi saranno conflitti sempre vinti da Israele, che nel 1967 – durante la guerra dei Sei giorni – ottenne la sua più sfolgorante vittoria, conquistando la Cisgiordania, le alture del Golan della Siria, il Sinai e anche l’agognata Gerusalemme Est. Di questi territori, solo il Sinai verrà poi restituito all’Egitto con la Pace di Camp David del 1979. Alle umiliazioni militari degli Stati arabi seguì la sconfitta delle forze di guerriglia dei palestinesi (i fedayyn) dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, attivi negli anni ’60 e ’70, ma costretti a fuggire dal Libano invaso da Israele nel 1982. Da allora in poi, la lenta evoluzione dell’Olp (l’Organizzazione per la liberazione della Palestina) verso il riconoscimento di Israele e il rifiuto del terrorismo. Alla fine degli anni ’80, la sorpresa dell’Intifada, ossia le proteste non armate dei palestinesi contro l’oppressiva occupazione dei territori occupati da Israele nel 1967, che il governo ebraico si è sempre rifiutato di restituire. Israele reagisce con troppa violenza contro i ragazzini che lanciano sassi alle Forze armate israeliane: una scelta che indebolisce l’immagine di quello Stato e che non piega le proteste. È in questa fase che Arafat, il capo dell’Olp, e Rabin, primo ministro israeliano, avviano trattative segrete che culminano nel 1993 con gli accordi di Oslo. Nasce l’Autorità nazionale palestinese che può amministrare alcune parti dei territori occupati e si chiudono i conflitti con diversi Stati arabi. La pace sembra finalmente a portata di mano. È un’illusione, purtroppo: sia fra i palestinesi sia fra gli israeliani, sono in troppi a non volerla. Rabin viene assassinato da un fanatico israeliano nel 1995, mentre pesano come macigni la mancata soluzione delle questioni più spinose. Anzi tutto, il ritiro di Israele dai territori occupati dopo il 1967 (dove si si è insediata una miriade di colonie ebraiche); poi lo status giuridico di Gerusalemme, annessa da Israele e proclamata capitale dello Stato, nonostante l’opposizione internazionale, benché da sempre la Santa Sede chieda di riconoscere il carattere di città sacra alle tre religioni monoteistiche con uno statuto giuridico speciale, rifiutando l’idea che Gerusalemme 'appartenga' solo a un popolo. E infine, il diritto al ritorno di milioni di palestinesi (che se tornassero trasformerebbero Israele in uno Stato a maggioranza araba, cosa inaccettabile per gli ebrei). Il processo di pace naufraga lentamente fra opposti estremismi, lo scoppio di lunghe stagioni di violenza e terrorismo, la frattura interna al movimento palestinese, lo scivolamento a destra dell’opinione pubblica israeliana, la crescita dei radicalismi religiosi islamico ed ebraico, la costruzione di un muro difensivo (a protezione dalle incursioni terroristiche) che taglia in modo brutale il territorio palestinese e sembra la reificazione del rifiuto di due popoli a riconoscersi. A uno sguardo distaccato, sembra non esserci molto spazio oggi per nuove trattative di pace. Il governo Netanyahu non vuole uno stato di Palestina; non si ritira dai territori occupati, non ferma la creazione di colonie ebraiche. E non sa come fare con una popolazione araba sempre più numerosa, che mina l’idea di Israele come Stato ebraico. I palestinesi, deboli e divisi, con una leadership piagata dalla corruzione, stanno cercando di reagire a un senso di crescente marginalizzazione e disinteresse internazionale. Nel mezzo la comunità cristiana, che appare due volte 'profuga': vittima tanto delle intolleranze degli islamisti quanto di un atteggiamento israeliano spesso ingiusto e ambiguo. Ma se si vuole dare una speranza, per quanto tenue, alla pace, bisogna ripartire proprio dall’atteggiamento delle nostre comunità: che rifiutano la violenza come mezzo di relazione sociale e che interagiscono con tutti, ebrei e musulmani, senza rifiutarsi di dare legittimità all’esistenza dell’altro. Consapevoli che l’unica strada per evitare nuovo sangue su di una terra così piccola e così densamente popolata di etnie e religioni distinte sta nel garantire la sicurezza di tutti, non di una parte a scapito delle altre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA