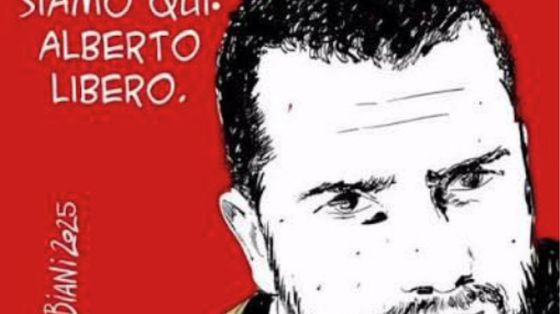L'attualità dell'America assomiglia sempre di più a un «Infinite jest»
Le mire sul Canada, i social senza controllo, l'intrattenimento perpetuo, la Danimarca dell'Amleto che ritorna per scherzo. Il romanzo di David Foster Wallace del 1996 ci parla ancora del presente

Il romanzo di David Foster Wallace e gli annunci di Donald Trump Capita che un lettore di fronte a una mole imponente di pagine arretri, o al più ne scorra le prime con diffidenza. È quello che spesso capita di fronte a un testo di David Foster Wallace, il narratore americano più eccentrico, fluviale, analitico e impeccabile della generazione attiva attorno al cambio di millennio. E c’è una cosa che però questo lettore pavido si perderebbe, anzi due: perché la prima è il piacere di essere continuamente stupiti sul piano estetico, l’altra è la capacità profetica di un’intelligenza che Wallace sa applicare non solo alla comprensione della realtà ma nell’individuazione di aspetti e segni che la maggior parte della gente tralascia e che invece chi sa leggere nel mondo in quel modo sa avvertire e poi convertire in narrazione. Che in questo caso sono le 1.280 pagine di Infinite Jest, l’opera monstre di questo scrittore monstre che pochi hanno letto, tra i quali c’è probabilmente Donald Trump, anche se le recenti boutade geopolitiche del tycoon potrebbero indurci a pensare il contrario.
Per dirne una, nel romanzo, Canada, Messico e Stati Uniti sono unificati e all’interno della mega-nazione si agitano movimenti secessionisti. Ma soprattutto vero protagonista è un filmato smarrito la cui visione produce nello spettatore uno stato di catalessi per cui il malcapitato perde ogni altro interesse nel mondo reale e non riesce a staccarsi da ciò che quella visione gli propina. Attorno a questa sorta di convitato di pietra si dipanano una miriade di storie secondarie ma che fedelmente ritraggono l’America: c’è la pubblicità, per cui perfino gli anni come fossero stadi sono sponsorizzati dalla ditta di turno – ce n’è addirittura uno intitolato ai pannoloni –, c’è lo sport vissuto nella sua variante televisiva e commerciale – Wallace è stato un buon tennista, e al tennis, e in particolare a Roger Federer, ha dedicato pagine di rara acutezza e poeticità –, ci sono le droghe e le dipendenze, è tutto un mondo, dice a un certo punto il narratore, parafrasando la massima evangelica, «incapace di non amare nulla più di sé stesso».
Un mondo che vive in un perpetuo intrattenimento, dove ogni affermazione tanto più guadagna consenso quanto più è irreale e indipendente da ogni riscontro oggettivo. Non è forse qualcosa che somiglia molto alla recente rinuncia al fact checking di Musk e Zuckerberg? Tutto questo non deve farci pensare a un atteggiamento moralistico da parte di Wallace che invece ha un tale radicato senso di pietas e simpatia per l’umano da guardare con ironia spassionata ma mai giudicante questo formicaio di pulsioni, questa dedizione assoluta all’imperativo tutto yankee dell’autoaffermazione. Proprio questa ragnatela di vicende trasmette l’idea di un mondo che brulica di progetti e di passioni, però fatalmente determinate dalla finzione. La vera assente è l’impossibilità di fidarsi di ciò che si vive in questo continuo intrattenimento.
Il Wallace che ha seguito la campagna elettorale del repubblicano McCain, che è andato in crociera per fare una cosa che non farà mai più ma dove tutte le pretese e i vizi dell’americano medio sono raccontate, è anche soprattutto il Wallace della affettuosa prolusione agli studenti del Kenyon College, quella che comincia con l’apologo dei due pesci giovani che non sanno più dove stanno nuotando e che non conoscono cosa sia l’acqua, cioè l’ambiente in cui vivono e che li determina. Senza offrire ricette, senza moralismi ma senza dimenticare l’empatia umana, Wallace invitava quegli studenti a superare «il corredo naturale di pulsioni elementari», quello che «ci fa credere di essere il centro del mondo» e guardare al resto della gente come «una sorta di gregge di subumani che urlano nei cellulari», ma immedesimarsi nella vita di chi incontriamo, pensare che dietro l’atteggiamento dell’altro ci possa essere un vissuto di sofferenze e dolore, e quindi sentirsene umanamente partecipi. Perché, concludeva, «nelle trincee quotidiane della vita adulta non esiste ateismo. Non esiste il non adorare. L’unica scelta consiste in cosa adorare. E una ragione preminente per scegliere un Dio o la Madre Terra oppure un insieme di principi etici è che qualsiasi altra cosa voi vi mettiate in testa di adorare vi divorerà: il denaro, il corpo, la bellezza, il potere, l’intelletto».
Un aiuto viene dalle storie, come confidò a Larry Mccaffery in una lunga intervista del 1993: le storie che sono vere in quanto relazione «tra la coscienza di chi scrive e chi legge, una relazione vera perché vivente tra esseri umani». Non l’intrattenimento irresponsabile e disincarnato, non l’Infinite jest di cui parla il malinconico Amleto nell’opera omonima. E a proposito, non era forse Amleto il principe di quella Danimarca che Trump vorrebbe privare della Groenlandia?
© RIPRODUZIONE RISERVATA