È illusione di un mondo giusto la trappola della meritocrazia
Prosegue il confronto sulla volontà di premiare chi contribuisce all’efficienza della società
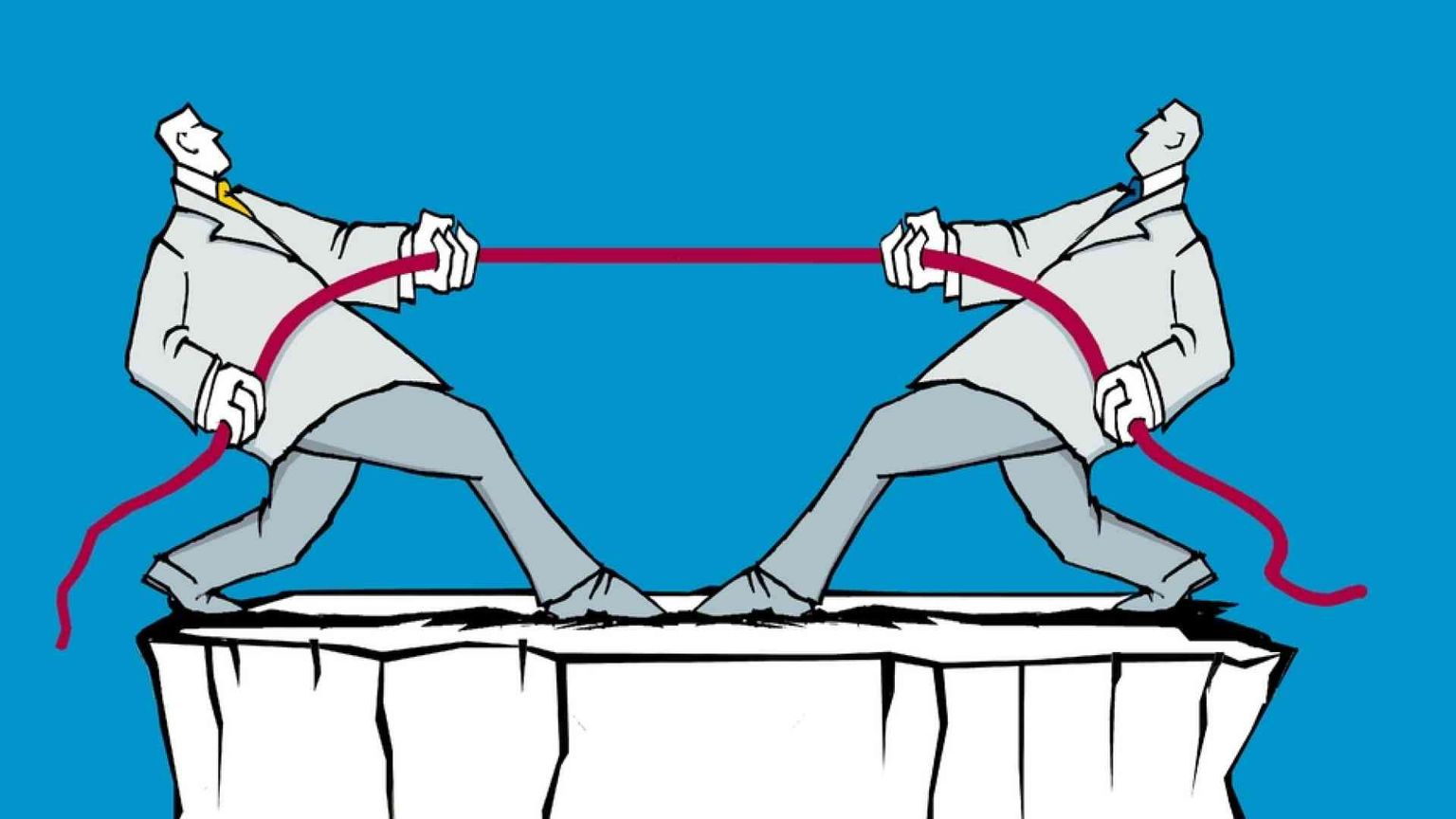
È piuttosto curioso che un’idea nata originariamente per descrivere una distopia, una visione che prefigura un futuro angosciante e indesiderabile, viene oggi considerata, da molti, un’utopia, un ideale da perseguire e su cui costruire il nostro ordine sociale. Stiamo parlando dell’idea di meritocrazia, termine coniato nel 1958 da Michael Young per descrivere, nel suo romanzo “L’ascesa della meritocrazia”, una società futura basata interamente sul merito, inteso come somma di talento e impegno, di quoziente intellettivo e sforzo, da dedicare totalmente al servizio delle “esigenze dell’efficienza”. A un certo punto è successo qualcosa e si è cominciato a considerare la meritocrazia come un viatico verso una società giusta, perché capace di premiare con riconoscimento, successo e denaro chi più contribuisce a quelle stesse esigenze dell’efficienza.
La questione del merito è politicamente trasversale. Entra nel dibattito politico negli anni 80 del Novecento con Reagan negli Usa e con Blair in Gran Bretagna, e arriva fino a Obama che sceglie come slogan “you can make it if you try” (se ci provi, ce la puoi fare). Alla Leopolda del 2019, l’ex-ministra Bellanova afferma: «Chi ce l’ha fatta, ce l’ha fatta per merito e il merito è di sinistra […] il merito è il nostro unico parametro di misura». Ma merito di cosa esattamente? Nel giugno 2001, lo stesso Michael Young, dovette scrivere un articolo su “The Guardian” per cercare di far capire l’equivoco. Per cercare di spiegare quanto l’idea stessa di meritocrazia fosse stata fraintesa, facendola assurgere a principio fondante, invece di riconoscere in essa il pericoloso antecedente di una deriva distopica. Ma non fu sufficiente.
Eppure, oggi, qualcosa inizia a muoversi. La dimensione ideologica, forse, inizia a venire a galla e la retorica è soggetta sempre più frequentemente a efficaci esercizi di decostruzione. Ne hanno dato conto, anche in queste pagine, Luigino Bruni e Paolo Santori («La meritocrazia? Un’illusione che giustifica le diseguaglianze», 5 maggio 2021) illustrando i contenuti di un convegno organizzato dall’associazione Heirs (Happiness and Relationships in Economics) e dall’Università di Cardiff, sull’«Illusione del merito» e sol- lecitando un dibattito plurale e aperto.
L’idea di una società futura basata interamente sulla capacità di premiare in virtù del quoziente intellettivo e dello sforzo profuso nasceva in virtù di una visione distopica, poi trasformata in positiva
La mia posizione è decisamente critica non tanto sulla meritocrazia in sé – è un principio così vago che si fatica anche a criticarlo – ma, piuttosto, sulla retorica che circonda il principio. Enunciando la tradizionale formula “talento + impegno”, per esempio, retoricamente, viene nascosto il fatto che anche la capacità di impegnarsi, oltre che il talento, è molto spesso, ereditata, è cioè, qualcosa di cui non abbiamo merito. La perseveranza, la determinazione, la capacità di darsi degli obiettivi e di perseguirli con costanza, tutti elementi che facciamo ricadere nella categoria dell’“impegno”, fanno parte di quelle che i neuroscienziati definiscono “funzioni esecutive”. Quello che gli studi mostrano è che queste abilità si formano in età estremamente precoce e poi si fissano e perdono plasticità. L’ambiente familiare, quindi, da questo punto di vista, è fondamentale. È c’è davvero poco merito, se il nostro carattere determinato e perseverante, si è formato così com’è perché, magari, siamo nati in una famiglia che ci ha amato e stimolato, in una nazione avanzata, in una città a misura d’uomo e in un quartiere residenziale tranquillo e non in uno slum di Nairobi. Il fatto che anche la capacità di impegnarsi deriva, in parte da, fattori fuori dal nostro controllo, non significa che chi si impegna e ottiene risultati non debba essere apprezzato e riconosciuto.
La credenza secondo cui le persone generalmente ottengono ciò che si meritano si fonda in realtà su basi irrazionali
Vuol dire, piuttosto, che chi non ha ottenuto gli stessi risultati, molto spesso, non li ha ottenuti non certo perché non si è impegnato abbastanza, per pigrizia o “menefreghismo”, ma più semplicemente, perché la vita gli ha messo addosso una zavorra insopportabile, con la quale neanche i più “meritevoli” sarebbero stati in grado di raggiungere i loro traguardi. È questa «simmetria delle valutazioni» tra successo e insuccesso e, quindi, tra merito e demerito che alimenta la retorica meritocratica e la giustificazione morale delle disuguaglianze. Gli psicologi sociali definiscono «ipotesi del mondo giusto» la credenza diffusa secondo cui le persone generalmente ottengono ciò che si meritano. È un atteggiamento infantile e irrazionale che risponde, però, a un bisogno profondo e ci fa percepire il nostro ambiente sociale come se fosse stabile e ordinato. Senza una tale convinzione sarebbe molto più difficile darsi obiettivi di lungo periodo e gestire, per esempio, l’insensatezza del dolore innocente.
Poiché la convinzione che il mondo sia giusto serve una funzione così importante, d’altro canto, le persone sono riluttanti a rinunciare a questa convinzione anche davanti all’evidenza contraria. Se da una parte, dunque, abbiamo uno scudo psicologico che ci protegge dalla durezza del mondo e alimenta il senso di controllo sul nostro destino, dall’altra, lo stesso scudo diventa un’arma contro gli altri: capita spesso, per esempio, che in virtù della credenza in un mondo giusto si tenda a colpevolizzare le vittime di un crimine: pensate a quante volte in un caso di stupro sentiamo qualcuno affermare che la vittima se l’era cercata; o nei casi di bullismo, quante volte si pensa che forse la vittima avrebbe dovuto imparare a difendersi e a farsi valere. O, ancora, quante volte abbiamo sentito, a proposito dei migranti morti in mare che, che se fossero rimasti a casa loro ora sarebbero ancora vivi. Ma l’«ipotesi del mondo giusto» fa qualcosa di più, di peggio: spinge le stesse vittime a sentirsi in colpa e a pensare che in fondo, quella disgrazia o quell’altra sventura se la sono meritata. Alcune ricerche condotte recentemente negli USA hanno messo in luce che le fasce della popolazione più contrarie alle politiche redistributive sono quelle che da tali politiche potrebbero trarre maggiore sollievo. Pensano di non meritarsi di essere aiutati dallo Stato.
Questo è il meccanismo psicologico che alimenta la retorica della meritocrazia. Un lato oscuro che non dovrebbe mai essere sottovalutato, minimizzato o rimosso. Bisognerebbe, anzi, iniziare a riconoscerlo esplicitamente se vogliamo condurre un dibattito senza preclusioni ideologiche e con un atteggiamento di costruttiva distanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







