Il nome prima del nome col quale ognuno di noi viene chiamato: figlio
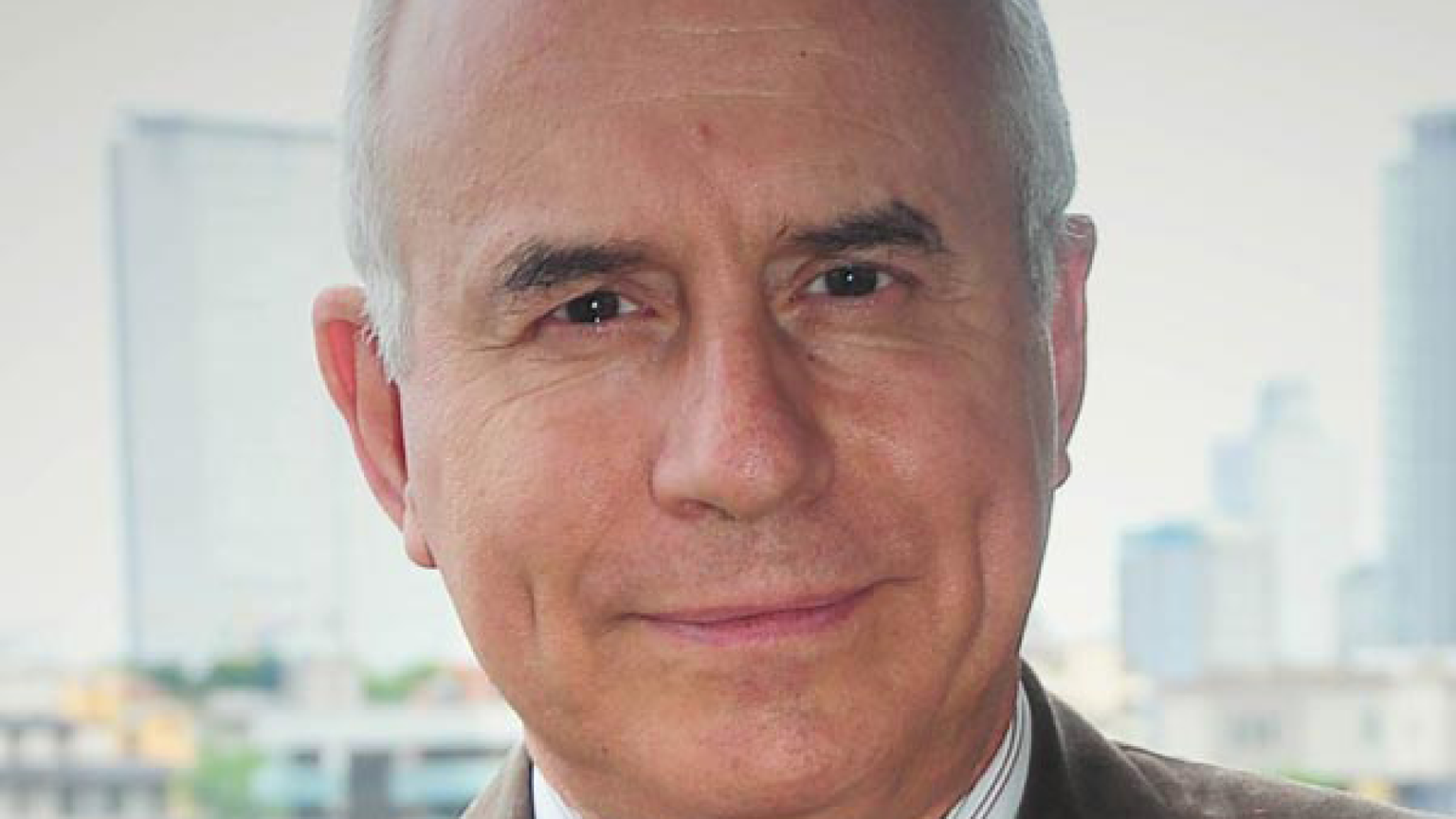
Gentile direttore,
le scrivo in merito alla polemica in corso sulla sepoltura dei feti abortiti. Era il 1999 quando don Oreste Benzi celebrò il primo funerale di un bimbo abortito. Era il figlio di una signora con tanti problemi, vissuta per un periodo anche con la mia numerosa famiglia. Temeva che i Servizi sociali non le permettessero di fare la mamma togliendole il figlio alla nascita. Purtroppo perse il bimbo spontaneamente, a 19 settimane di gestazione. Fu l’ostetrica dell’ospedale pubblico, un istante prima dell’espulsione, a chiederle se avrebbe desiderato per lui il battesimo e quale nome dargli. Era consapevole infatti che sarebbe potuto nascere vivo ma troppo piccolo per poter vivere più di qualche istante una volta separato dalla madre. La signora ne fu lieta, accolse volentieri anche la possibilità di una degna sepoltura con rito cristiano. Nel tempo questo gesto si rilevò molto importante per lei ed era di grande sollievo portare un fiore sulla sua tomba. Ricordo ancora con emozione quel bimbo in miniatura e la sua manina perfettamente formata, grande come un’unghia. Da allora la Comunità Papa Giovanni XXIII si rende disponibile a sostenere i genitori di questi piccoli nell’adempiere al loro desiderio di una degna sepoltura, troppo spesso osteggiato dal personale sanitario. Rileviamo purtroppo come sia prassi ospedaliera e talvolta anche cimiteriale utilizzare il termine “feto di...” o “prodotto abortivo di...” per identificare ciò che resta di quel piccolo essere umano. Per i genitori si tratta di una terminologia molto sgradevole e spesso è impedito loro di poter scrivere sulla lapide il nome che avrebbero voluto dare al proprio bambino. Il lutto prenatale è ormai classificato al pari di quello perinatale o post-natale. Una sofferenza che i genitori vivono in modo molto profondo ma così spesso minimizzata e repressa. La sepoltura e i riti connessi danno la possibilità di socializzare il dolore e di avviare una più facile elaborazione del lutto. Talvolta i genitori, pur desiderando rispetto per le spoglie del loro figlio, non si sentono di procedere in prima persona e delegano noi. Questo avviene in forma anonima attraverso l’ospedale. Essendo inequivocabile ai genitori la nostra fede di appartenenza, ci sentiamo in dovere di effettuare un rito cristiano e deporre una croce. Talvolta invece abbiamo accompagnato genitori musulmani. In questi casi abbiamo lasciato che loro stessi recitassero le loro preghiere. Noi abbiamo fatto un passo indietro e ce ne siamo astenuti. Quando siamo coinvolti dagli ospedali, ogni salma è identificata da un codice che viene poi riportato sul registro cimiteriale e associato alla tomba. Solo la madre può ottenere quel codice dall’ospedale e recarsi al cimitero per conoscere, anche a distanza di 5/10 anni, il luogo esatto in cui è stato sepolto il figlio. Le madri e i padri ci ringraziano sempre e testimoniano il valore e l’importanza di questo gesto. Dare una degna sepoltura.
le scrivo in merito alla polemica in corso sulla sepoltura dei feti abortiti. Era il 1999 quando don Oreste Benzi celebrò il primo funerale di un bimbo abortito. Era il figlio di una signora con tanti problemi, vissuta per un periodo anche con la mia numerosa famiglia. Temeva che i Servizi sociali non le permettessero di fare la mamma togliendole il figlio alla nascita. Purtroppo perse il bimbo spontaneamente, a 19 settimane di gestazione. Fu l’ostetrica dell’ospedale pubblico, un istante prima dell’espulsione, a chiederle se avrebbe desiderato per lui il battesimo e quale nome dargli. Era consapevole infatti che sarebbe potuto nascere vivo ma troppo piccolo per poter vivere più di qualche istante una volta separato dalla madre. La signora ne fu lieta, accolse volentieri anche la possibilità di una degna sepoltura con rito cristiano. Nel tempo questo gesto si rilevò molto importante per lei ed era di grande sollievo portare un fiore sulla sua tomba. Ricordo ancora con emozione quel bimbo in miniatura e la sua manina perfettamente formata, grande come un’unghia. Da allora la Comunità Papa Giovanni XXIII si rende disponibile a sostenere i genitori di questi piccoli nell’adempiere al loro desiderio di una degna sepoltura, troppo spesso osteggiato dal personale sanitario. Rileviamo purtroppo come sia prassi ospedaliera e talvolta anche cimiteriale utilizzare il termine “feto di...” o “prodotto abortivo di...” per identificare ciò che resta di quel piccolo essere umano. Per i genitori si tratta di una terminologia molto sgradevole e spesso è impedito loro di poter scrivere sulla lapide il nome che avrebbero voluto dare al proprio bambino. Il lutto prenatale è ormai classificato al pari di quello perinatale o post-natale. Una sofferenza che i genitori vivono in modo molto profondo ma così spesso minimizzata e repressa. La sepoltura e i riti connessi danno la possibilità di socializzare il dolore e di avviare una più facile elaborazione del lutto. Talvolta i genitori, pur desiderando rispetto per le spoglie del loro figlio, non si sentono di procedere in prima persona e delegano noi. Questo avviene in forma anonima attraverso l’ospedale. Essendo inequivocabile ai genitori la nostra fede di appartenenza, ci sentiamo in dovere di effettuare un rito cristiano e deporre una croce. Talvolta invece abbiamo accompagnato genitori musulmani. In questi casi abbiamo lasciato che loro stessi recitassero le loro preghiere. Noi abbiamo fatto un passo indietro e ce ne siamo astenuti. Quando siamo coinvolti dagli ospedali, ogni salma è identificata da un codice che viene poi riportato sul registro cimiteriale e associato alla tomba. Solo la madre può ottenere quel codice dall’ospedale e recarsi al cimitero per conoscere, anche a distanza di 5/10 anni, il luogo esatto in cui è stato sepolto il figlio. Le madri e i padri ci ringraziano sempre e testimoniano il valore e l’importanza di questo gesto. Dare una degna sepoltura.
Enrico Masini
Caro direttore,
francamente non sapevo che fosse possibile seppellire i feti, credevo venissero inceneriti, da un lato mi ha fatto piacere sapere che questo avviene, e che non ci si limita a scrollarsi il “problema” come polvere dalle scarpe... Penso, però, che sia anche sbagliato segnalare le tombe anche col nome della madre come è stato fatto a Roma: è un modo non rispettoso che non posso condividere, anche se guardo da sempre con dolore e orrore alla pratica abortiva, che per quanto legale e culturalmente “sdoganata”, rimane inquietante e dolorosamente disumana. Molte delle donne che hanno vissuto quella esperienza, si portano dentro il vuoto di quella decisione, e la fatica di riprendere una quotidianità che in ogni caso sarà diversa. Poi c’è l’atteggiamento censorio degli abortisti militanti. Rimango sempre basito di fronte a quella arroganza negazionista. Ma, proprio perché l’aborto legalizzato in Italia e altrove è ormai una realtà consolidata da decenni, è così scandaloso dare una collocazione a quei poveri umani resti, salvaguardando l’identità e la privacy della madre?
Eugenio Sgarbi
Grazie, gentili e cari amici, per le vostre parole. Sono specialmente contento che vengano da uomini come me, che sanno esprimere con delicatezza un rispetto vero per le parti prima di tutto in causa in una vicenda d’aborto, il bambino e la madre, ma danno voce e spessore a una parte, il padre, che troppo spesso, quando si arriva a negare la vita di un figlio o di una figlia in arrivo, è – o si mostra – inadeguato, indifferente, ignaro, in fuga, comunque assente.
Lettere come le vostre fanno sperare – parlo per me e, ne sono certo, non solo per me – che nella nostra Italia, nonostante tutto, pietà non “l’è morta”. E aiutano a capire meglio che c’è un sistema di regole sensate e ragionevolmente articolate – per quanto imperfette e, purtroppo, qualche volta applicate male – che presidia uno dei capisaldi della nostra civiltà: il rispetto dei morti, l’inchinarsi davanti alla memoria e ai corpi umani, pur se la vita di costui o di costei era appena agli inizi, pur se la persona ancora non era nata. Fino a quando sapremo dare degna sepoltura a ogni figlio e figlia di donna e d’uomo, anche morto d’aborto, e fino a quando riusciremo a parlarne con la sobria e profonda empatia che entrambi dimostrate, che il signor Masini ci consegna con la forza di una testimonianza coinvolgente, la pietà continuerà a vivere. E continuerà a consolarci e ad accompagnare la nostra lenta e faticosa risalita dalla valle delle parole vuote e dei più sussiegosi luoghi comuni.
In questi giorni, però, ammetto di aver avuto la sensazione di essere precipitato di nuovo in quella cupa valle. Non mi abituerò mai, infatti, all’algido sussiego “dirittista” di parecchie voci di donna e d’uomo che hanno furoreggiato (e ancora insistono) del dibattito che s’è ovviamente aperto sui seri errori che a Roma sono stati compiuti nel dare sepoltura, dopo l’aborto, ai corpicini dei bambini non nati arrivati almeno alla ventesima settimana di gestazione. Casi divenuti clamorosamente di cronaca ci hanno fatto scoprire che nella capitale non ci si è limitati a riportare sulle sepolture delle loro tombe, corredate di una piccola croce, un numero di riferimento e di identificazione, ma si è inciso anche il nome della donna che non ha voluto o potuto diventare madre. Pure questa è una incivile mancanza di rispetto per il dramma che, in ogni caso, quella donna ha vissuto.
Tuttavia, come la mia collega Antonella Mariani ha saggiamente annotato su “Avvenire” di venerdì 2 ottobre, ciò che colpisce immensamente è la misera qualità della parole che sono state usate in questo dibattito da quanti non intendono ammettere che la creatura abortita è «uno di noi» e non un’escrescenza del corpo della madre, è qualcuno e non “qualcosa”, non è uno scartabile “prodotto” dell’incontro tra una donna e un uomo, ma è una vita umana, originale, unica e irripetibile. Quelle parole sono gelide, e lontane anni luce da quelle che oggi ci offrono la scienza medica e psicologica più avanzate e da quelle, calde, che l’esperienza esistenziale di tantissimi di noi continua a generare.
Nessuno più s’azzardi, dunque, sia pure su una targhetta da cimitero, a dare a una creatura il nome della madre che a quel figlio o a quella figlia ha dato la vita, ma poi non l’ha messa al mondo. Ma nessuno s’azzardi a pensare che quell’esserino non abbia nome: si chiama figlio, si chiama figlia. È il nome prima del nome col quale ognuno di noi viene chiamato, per amore o almeno per pietà.
Lettere come le vostre fanno sperare – parlo per me e, ne sono certo, non solo per me – che nella nostra Italia, nonostante tutto, pietà non “l’è morta”. E aiutano a capire meglio che c’è un sistema di regole sensate e ragionevolmente articolate – per quanto imperfette e, purtroppo, qualche volta applicate male – che presidia uno dei capisaldi della nostra civiltà: il rispetto dei morti, l’inchinarsi davanti alla memoria e ai corpi umani, pur se la vita di costui o di costei era appena agli inizi, pur se la persona ancora non era nata. Fino a quando sapremo dare degna sepoltura a ogni figlio e figlia di donna e d’uomo, anche morto d’aborto, e fino a quando riusciremo a parlarne con la sobria e profonda empatia che entrambi dimostrate, che il signor Masini ci consegna con la forza di una testimonianza coinvolgente, la pietà continuerà a vivere. E continuerà a consolarci e ad accompagnare la nostra lenta e faticosa risalita dalla valle delle parole vuote e dei più sussiegosi luoghi comuni.
In questi giorni, però, ammetto di aver avuto la sensazione di essere precipitato di nuovo in quella cupa valle. Non mi abituerò mai, infatti, all’algido sussiego “dirittista” di parecchie voci di donna e d’uomo che hanno furoreggiato (e ancora insistono) del dibattito che s’è ovviamente aperto sui seri errori che a Roma sono stati compiuti nel dare sepoltura, dopo l’aborto, ai corpicini dei bambini non nati arrivati almeno alla ventesima settimana di gestazione. Casi divenuti clamorosamente di cronaca ci hanno fatto scoprire che nella capitale non ci si è limitati a riportare sulle sepolture delle loro tombe, corredate di una piccola croce, un numero di riferimento e di identificazione, ma si è inciso anche il nome della donna che non ha voluto o potuto diventare madre. Pure questa è una incivile mancanza di rispetto per il dramma che, in ogni caso, quella donna ha vissuto.
Tuttavia, come la mia collega Antonella Mariani ha saggiamente annotato su “Avvenire” di venerdì 2 ottobre, ciò che colpisce immensamente è la misera qualità della parole che sono state usate in questo dibattito da quanti non intendono ammettere che la creatura abortita è «uno di noi» e non un’escrescenza del corpo della madre, è qualcuno e non “qualcosa”, non è uno scartabile “prodotto” dell’incontro tra una donna e un uomo, ma è una vita umana, originale, unica e irripetibile. Quelle parole sono gelide, e lontane anni luce da quelle che oggi ci offrono la scienza medica e psicologica più avanzate e da quelle, calde, che l’esperienza esistenziale di tantissimi di noi continua a generare.
Nessuno più s’azzardi, dunque, sia pure su una targhetta da cimitero, a dare a una creatura il nome della madre che a quel figlio o a quella figlia ha dato la vita, ma poi non l’ha messa al mondo. Ma nessuno s’azzardi a pensare che quell’esserino non abbia nome: si chiama figlio, si chiama figlia. È il nome prima del nome col quale ognuno di noi viene chiamato, per amore o almeno per pietà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







