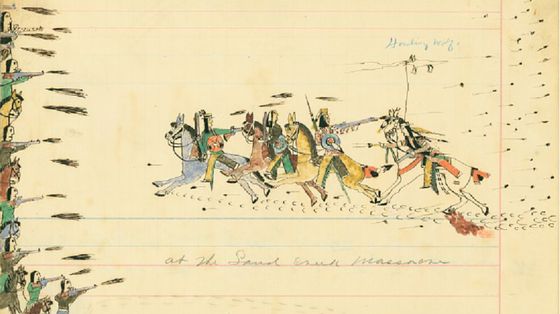Il tempo di decidere per il futuro
Sempre più evidenze scientifiche documentano il crescente impatto dei cambiamenti climatici in atto sul nostro organismo e sulla sicurezza alimentare. E impongono scelte coraggiose

Ammetto di essere un po’ sotto choc, pur occupandomi di questi temi da tempo. Infatti, questa settimana, nel corso della prima riunione della Commissione internazionale costituita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Who) sul tema “Clima e salute” abbiamo ascoltato alcuni dei massimi esperti di cambiamento climatico e del suo impatto sulla salute umana, che hanno dipinto una situazione a tinte fosche, specialmente per il nostro continente.
Il messaggio degli scienziati è inequivocabile: la crisi climatica sta accelerando anche oltre ciò che si immaginava solo pochi anni fa e l’Europa si sta riscaldando più rapidamente delle altre parti del mondo. Di conseguenza, tutti gli indicatori sanitari, dalla mortalità correlata al caldo all’ansia climatica, stanno peggiorando rapidamente. Nei 35 Paesi europei oltre 100.000 persone sono morte a causa del caldo nel biennio 2022-2023, un terzo dei decessi mondiali per tale motivo. Nel nostro continente accelerano in modo preoccupante anche la diffusione di malattie infettive e l’insicurezza alimentare. Ovviamente, tali fenomeni colpiscono soprattutto i più vulnerabili, cioè gli anziani, i poveri, i minori, alla faccia di chi dice che le politiche per la transizione ecologica possono aumentare le disuguaglianze.
Il solo inquinamento atmosferico provoca 7 milioni di morti all’anno in tutto il mondo, di cui mezzo milione nel nostro continente, 300.000 nell’Unione europea e circa 60.000 in Italia (per ulteriori approfondimenti si veda qui).Ogni Paese dovrebbe seriamente domandarsi come prepararsi ad affrontare un presente e soprattutto un futuro così complicato e drammatico.
Di questo si è parlato il 13 giugno nel corso dell’incontro “Costituzione: nuovi orizzonti per il nostro Paese” svoltosi presso la Camera dei deputati, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dal think thank italiano per il clima “Ecco” e da Globe Italia. Il titolo può sembrare decisamente lontano dalle questioni affrontate dalla Commissione della Who, ma non è così. Infatti, la modifica della Costituzione, proposta dall’ASviS fin dal 2016, intervenuta all’inizio del 2022 ma ancora poco conosciuta al grande pubblico, ha riguardato sia l’articolo 9, che ora recita «è compito della Repubblica tutelare l’ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità, anche nell’interesse delle future generazioni», sia l’articolo 41, che indica come l’attività economica non possa svolgersi recando danno all’ambiente e alla salute.
Si tratta di una modifica che mette l’Italia all’avanguardia internazionale, almeno sul piano dei princìpi, su una tematica, quella della giustizia intergenerazionale e dello sviluppo sostenibile, che riguarda in realtà tutti i Paesi del mondo, soprattutto quelli in cui gli squilibri, anche demografici, tra generazioni stanno esplodendo e il conflitto tra gli interessi degli attuali viventi e quelli di chi verrà sta assumendo dimensioni senza precedenti. Questi nuovi princìpi devono ora trasformarsi in politiche concrete (comprese quelle climatiche e quelle della salute), ed è su come cogliere le nuove prospettive aperte dalla riforma della Costituzione che si è incentrato il dibattito di ieri.
Il governo, anche in questo caso su proposta dell’ASviS, ha inserito in un disegno di legge (AS n. 1192) approvato per ora dal Senato, sia la previsione che «le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale, anche nell’interesse delle future generazioni», sia l’introduzione di una preventiva Valutazione dell’impatto generazionale (Vig) delle nuove leggi «in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale». Sperando in una rapida conclusione dell’iter legislativo, bisogna domandarsi già oggi come la Valutazione dovrà essere svolta dal Governo e il ruolo che dovrà avere il Parlamento per assicurare la costituzionalità delle nuove leggi.
Il governo, anche in questo caso su proposta dell’ASviS, ha inserito in un disegno di legge (AS n. 1192) approvato per ora dal Senato, sia la previsione che «le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale, anche nell’interesse delle future generazioni», sia l’introduzione di una preventiva Valutazione dell’impatto generazionale (Vig) delle nuove leggi «in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale». Sperando in una rapida conclusione dell’iter legislativo, bisogna domandarsi già oggi come la Valutazione dovrà essere svolta dal Governo e il ruolo che dovrà avere il Parlamento per assicurare la costituzionalità delle nuove leggi.
Dalla risposta a queste domande si capirà se si tratta di un’ennesima “ammuina” della politica per evitare cambiamenti reali del modo di compiere le scelte da cui dipende il nostro futuro o se il nostro Paese intende veramente “cambiare registro”, coerentemente con quanto le giovani generazioni (ma non solo) chiedono insistentemente e con quello che ci dice la scienza. Un passo importante sarebbe anche l’approvazione di una legge per il clima, sulla falsariga di quelle approvate a livello europeo e in vari Paesi che ne fanno parte, la quale dovrebbe definire la governance del processo di decarbonizzazione, fissando gli elementi minimi di garanzia di rispetto degli obiettivi climatici, come l’adozione di un carbon budget, l’allineamento delle politiche agli scenari scientifici e agli impegni internazionali, e l’istituzione di un consiglio scientifico in grado di valutare in maniera indipendente l’efficacia della strategia e la coerenza del processo legislativo.
Come direbbero gli anglosassoni, non si tratta di “scienza missilistica”, ma di dotarsi di strumenti per affrontare in modo serio quanto la riforma della Costituzione, votata all’unanimità da tutte le forze politiche, ci impone di fare per affrontare le sfide drammatiche che abbiamo di fronte. Sarebbe il modo migliore per prendersi cura non solo della “casa comune” di cui parlava papa Francesco (cioè del nostro Pianeta) ma anche di chi in quella casa abita, cioè noi, e di chi ci abiterà in futuro. Dopotutto, non dovrebbe essere questo il compito della politica?
© RIPRODUZIONE RISERVATA