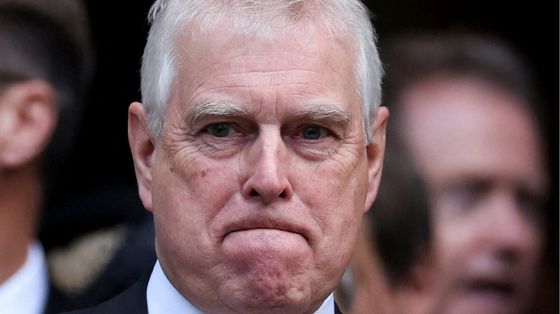Li stiamo ancora proteggendo i bambini della famiglia nel bosco?
Sono passati tre mesi dalla sospensione della potestà genitoriale per la coppia di Palmoli, è il caso di chiedersi se il tempo della giustizia, dei servizi sociali e delle perizie coincida veramente con il tempo dell’infanzia

Nel susseguirsi di relazioni, perizie, comunicati, ricostruzioni che da settimane accompagnano la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” abbiamo visto accadere tutto e il contrario di tutto. La storia è nota, ma vale la pena ripercorrerla brevemente e provare a tirare una linea. Il 20 novembre scorso – esattamente tre mesi fa – il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dispone la sospensione della potestà genitoriale della coppia anglo-australiana formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e l’allontanamento dei tre figli piccoli dal casolare nel bosco dove vivono, a Palmoli, in provincia di Chieti. I bambini vengono collocati in una casa-famiglia a Vasto. La misura viene motivata dall’esigenza di tutelare i minori e valutarne le condizioni all’interno di un percorso protetto. Nei rapporti dei servizi sociali si parla di disagio abitativo: un casolare in pietra privo di impianto idraulico, rete fognaria e servizi igienici. Si segnala l’assenza di entrate lavorative stabili e la scelta dei genitori di non mandare i figli a scuola, in nome di uno stile di vita neorurale. Non emergono, invece, elementi di violenza, né segnali di sofferenza fisica o psicologica nei bambini, né indicatori di maltrattamento o trascuratezza grave. Al netto di un episodio di avvelenamento da funghi e della mancanza – per definizione sanabile – delle vaccinazioni, il quadro non presenta profili di emergenza acuta o di pericolo immediato. La separazione del nucleo familiare innesca immediatamente un acceso dibattito pubblico. Alla madre viene consentito di trasferirsi nella struttura insieme ai figli, seppur in una zona separata; al padre è permesso far loro visita. I genitori inizialmente rifiutano i tentativi di conciliazione, poi accettano la proposta del Comune di trasferirsi in un’abitazione più idonea ai bambini. Viene accertato, inoltre, che i figli ricevono una forma di istruzione riconducibile ai criteri (riconosciuti) dell’homeschooling. In questo contesto, tutto lascia prevedere una soluzione rapida, inizialmente ipotizzata entro le festività natalizie. Non per indulgenza, ma per proporzione: il caso non presenta, cioè, elementi tali da giustificare una sospensione protratta nel tempo della vita familiare. Da quel momento, però, la traiettoria dei fatti cambia radicalmente.
Le relazioni degli assistenti sociali e della struttura di accoglienza iniziano a descrivere un atteggiamento “ostile” da parte della madre. I documenti restituiscono l’immagine di una donna esasperata – come non sorprende che sia – e di un clima di tensione crescente, di «resistenza». Parallelamente arrivano valutazioni di segno opposto. L’équipe di Neuropsichiatria infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti, incaricata di una perizia indipendente, certifica uno stato di disagio e sofferenza nei bambini, attribuendo un ruolo centrale al trauma dell’allontanamento e riconoscendo nei genitori un «valido riferimento emotivo». In questo documento si parla esplicitamente della necessità di ripristinare una continuità affettiva e di garantire la presenza del nucleo familiare come condizione per il benessere psicologico dei minori. Una valutazione a cui si richiama anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, chiedendo che venga tenuta in debito conto in sede giudiziaria. Intanto proseguono – a singhiozzo – i colloqui con la psichiatra nominata dal tribunale: incontri interrotti a volte per la fragilità emotiva della madre, più spesso per la mancanza, difficilmente giustificabile, di traduttori dall’inglese.
Nel frattempo, il racconto si frantuma ulteriormente. Catherine rompe il silenzio e parla di bambini spaventati, di notti difficili, addirittura di porte chiuse a chiave per impedire ai figli di raggiungerla. La casa-famiglia replica con fermezza, smentendo ogni limitazione nei contatti e denunciando ricostruzioni mediatiche scorrette. Eppure, altre ricostruzioni riferiscono di corridoi effettivamente chiusi “per motivi di sicurezza”, di bambini costretti a restare all’interno della struttura per evitare l’assedio di giornalisti e curiosi. Una protezione che si starebbe traducendo, per i piccoli, in isolamento. Lunedì scorso, infine, i legali della coppia presentano una nuova istanza di revoca della sospensione della potestà genitoriale, allegando una relazione tecnica che documenta danni psicologici già in atto nei bambini a causa della separazione. A supporto, video e immagini che mostrano gli effetti del trauma. In questo continuo rimbalzo di versioni, valutazioni e interpretazioni diventa sempre più difficile intravedere una direzione, prima ancora che una verità. E non è certo compito del commento pubblico stabilire chi abbia ragione: queste sono valutazioni che richiedono accesso pieno agli atti e competenze che solo la sede giudiziaria può garantire. C’è però una questione che non può più essere elusa, perché esula dal merito e riguarda il cuore stesso della tutela dei minori: il tempo. Oggi, che è il 20 febbraio, sono infatti passati tre mesi dal giorno in cui i tre bambini di Palmoli – una di 8 anni, due gemelli di 6 – sono stati allontanati dai loro genitori. E tre mesi di separazione da mamma e papà sono un tempo infinito per qualunque bambino. Tanto più se è così piccolo, se ha vissuto un allontanamento improvviso, traumatico, se è stato sistemato in un luogo sconosciuto, tra persone estranee, alle prese con nuove abitudini, del tutto diverse da quelle a cui è stato abituato dalla nascita.
Le strutture di accoglienza sono strumenti fondamentali di protezione. Ma per loro natura non possono e non devono diventare luoghi di permanenza prolungata per minori che una famiglia ce l’hanno. La legge 184 e la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia non lasciano spazio a interpretazioni: l’allontanamento dal nucleo familiare è un’extrema ratio e, quando necessario, deve durare il meno possibile. Il punto, allora, non è più – e forse non lo è mai stato – scegliere tra genitori e istituzioni. È chiedersi se il tempo che stiamo imponendo a questi bambini sia ancora compatibile con il loro interesse, che la legge definisce «supremo». Perché il tempo della giustizia, dei servizi sociali e delle perizie non coincide con il tempo dell’infanzia. E quando le decisioni si allungano, il rischio concreto è che a pagare il prezzo più alto siano proprio coloro che il sistema è chiamato a proteggere. Rivolgiamo dunque da queste pagine una domanda non più rinviabile: i bambini della “famiglia nel bosco” li stiamo proteggendo davvero?
© RIPRODUZIONE RISERVATA